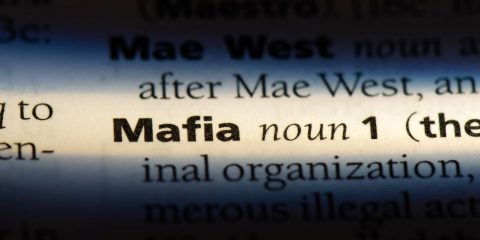Per gentile concessione dell’editore pubblichiamo l’epilogo del saggio di Salvatore Sechi “La Mafia non è finita, dalla trattativa con lo Stato all’arresto di Messina Denaro (1993-2023)” (Firenze goWare, 2023), seguito da un’intervista all’autore di Rossella Pera dopo la recente sentenza di assoluzione della Cassazione: “La Cassazione nega la trattativa Stato-mafia. Salvatore Sechi la ribadisce”. Nell’intervista “lo storico sardo conferma quanto la Cassazione ha appena negato: cioè l’esistenza della Trattativa Stato-mafia”. “Negare l’esistenza della trattativa tra settori dello Stato (come il Ros dell’Arma dei Carabinieri) e Cosa Nostra nel biennio 1992-1993 non corrisponde alle vicende e ai documenti esistenti. Di qui la curiosità con cui attendo le motivazioni del diverso giudizio della Cassazione”.La documentazione a disposizione dei giudici della Suprema Corte non è diversa, secondo il prof. Sechi, da quella esaminata dai magistrati delle ultime due Corti d’Appello di Palermo (una, presieduta dai giudici Pellini\Anania, ha assolto tutti gli imputati; l’altra, presieduta dai giudici Montalto\Brambille, li ha condannati). Malgrado queste due sentenze radicalmente diverse, i numerosi stuoli di giudici dei due processi concordano, dice Sechi, sul fatto che la trattativa c’è stata Protagonisti ne furono i comandanti del Ros (Generale Antonio Subranni e Colonnello Mario Mori), un ministro della giustizia come Giovanni Conso e anche lo stesso capo dello Stato Oscar Luigi Scalfaro. Ovviamente esistono tracce e documenti di tali interventi volti a mitigare le condizioni dei mafiosi detenuti nei penitenziari, a cominciare dall’abrogazione del carcere duro, una richiesta precisa e tenace di Cosa Nostra. Se, invece, si pretende -ha dichiarato il prof. Sechi-che sia stata firmata un’intesa formale, come un contratto, tra Stato e mafia, ovviamente questo non esiste. Con terroristi e criminali ovunque a trattare sono sempre non i vertici, ma apparati dello Stato, le loro ombre, che agiscono a cortine abbassate, in maniera ambigua”.
_________________
Il lasso di tempo trascorso dalla prima stesura dell’insieme di saggi e interventi diversi – che ho raccolto in questo volume La Mafia non è finita dalla trattativa con lo Stato all’arresto di Messina Denaro (1993-2023)[1] ha visto allinearsi due importanti sentenze della Corte d’assise d’appello del Tribunale di Palermo.
Il processo di secondo grado della trattativa Stato-mafia, del 23 settembre 2021, era presieduto dai giudici Angelo Pellino e, a latere, Vittorio Anania[2]. In data 6 agosto 2022 emise un verdetto di assoluzione dall’accusa di aver minacciato “il corpo politico dello Stato” nei confronti dei principali protagonisti (precedentemente condannati) della trattativa Stato-mafia. Si trattava di alti ufficiali dell’Arma dei carabinieri (il Ros) come i generali Antonio Subranni e Mario Mori, il colonnello Giuseppe De Donno, e uno dei fondatori di Forza Italia, Marcello dell’Utri. Nelle quasi tremila pagine di motivazioni furono, invece, ribadite le pesanti condanne, con qualche correzione, nei confronti del braccio mafioso (Leoluca Bagarella e Antonio Cinà).
In data 19 luglio 2018, il verdetto della seconda Corte d’assise di Palermo era stato come un guanto rovesciato, cioè ben diverso. Nel Palazzo di Giustizia del capoluogo siciliano fu depositata la sentenza dei giudici Alfredo Montalto e, a latere, Stefania Brambille. Nel monumentale testo (di 5252 pagine) venivano sanzionati tutti i coimputati in divisa e senza, compreso Massimo Ciancimino con l’eccezione di Nicola Mancino e Giovanni Brusca (quest’ultimo per prescrizione del reato[3].
Entrambe furono precedute da una decisione molto importante che c’è il malvezzo di dimenticare. Mi riferisco all’udienza preliminare, in data 7 marzo 2013, in cui il procuratore capo di Palermo, Piergiorgio Messineo, esaminati tutti gli aspetti dell’inchiesta e interrogati testimoni e collaboratori di giustizia, decretò il rinvio a giudizio degli imputati.
Un magistrato indipendente, esperto di processi di mafia, di preparazione giuridica riconosciuta, aveva lastricato la strada alla celebrazione di un processo che sarebbe durato dieci lunghi anni. Non era per nulla scontato. Fu allora che si creò il pool formato da Nino Di Matteo, Vittorio Teresi, Francesco Del Bene e Roberto Tartaglia destinato ad arrivare fino a sentenza.
La trattativa Stato-mafia c’è stata
Malgrado gli esiti penali diversi e opposti, le due sentenze hanno in comune un episodio fondamentale. Esso è oggetto di (ancora oggi non sopite) furibonde polemiche.
Si documentava e argomentava che la trattativa tra lo Stato e la criminalità mafiosa organizzata al suo massimo livello (Totò Rina e Bernardo Provenzano), c’era stata, eccome. Non era più un opinabile ludo cartaceo, ma realtà accreditata in sede giudiziaria.
Confermava quanto il grande capo di Cosa Nostra aveva dichiarato, secondo le intercettazioni delle sue confabulazioni col compagno di detenzione Alberto Lorusso, cioè di non avere mosso nessun passo di danza, perché fu lo Stato a farlo, cioè a “cercarlo”. Di qui, aggiungeva, un comportamento inevitabile: “Io al governo dovevo vendere i morti” di cui aveva cominciato a riempire le strade. Era l’inizio del negoziato e l’investimento da parte sua nella semina di cadaveri eccellenti.
Anche il capo dello Stato, Giorgio Napolitano, nella audizione del 28 ottobre 2014 al Quirinale è stato esplicito nel ricordare che già nel 1993 le più alte cariche dello Stato erano convinte che la politica mafiosa degli attentati e delle stragi corrispondeva a una precisa strategia ricattatoria dei corleonesi per strappare benefici dallo Stato.
A riconoscerla, a suo modo e indicando un bersaglio politico preciso (gli ex comunisti), è anche un noto leader (e testimone) politico democristiano legato a Giulio Andreotti. Egli si dice, e lo scrive, “convinto che, se trattativa c’è stata, l’hanno fatta alcuni ambienti della magistratura, con la copertura politica del PDS di Achille Occhetto e Luciano Violante”[4].
Ne segue una datazione temporale, il 1993. È l’anno in cui al Vicariato e nel centro archeologico di Roma, alle spalle degli Uffizi in via dei Georgofili a Firenze e a Villa Reale a Milano furono fatte esplodere delle bombe, colpendo (anche a morte) persone e opere d’arte.
In questa affermazione, che è sottesa a una requisitoria politica, Paolo Cirino Pomicino dichiara di essere mosso dalla necessità di “mettere in fila alcuni fatti, definitivamente acclarati e documentati”[5]. La mise au point è una rassegna abbastanza circostanziata dei legami tra il PCI e la magistratura.
Nel 1993, nella settimana della Domenica delle Palme, le procure di Napoli e Palermo accusarono di concorso esterno in associazione mafiosa la DC e l’ultimo governo Andreotti, nelle persone dello stesso premier, Antonio Gava, Vincenzo Scotti, Vincenzo Meo, Paolo Cirino Pomicino. Trent’anni dopo furono tutti assolti, ma i magistrati firmatari dell’avviso di garanzia, con l’eccezione di Giancarlo Caselli (Giovanni Melillo, Franco Roberti, Paolo Mancuso) fecero una gran carriera, compresa quella parlamentare. A farli eleggere nelle proprie liste fu l’ex PCI[6].
Non furono i soli se si dà uno sguardo ai nomi che emergono dagli atti del Parlamento, dei comuni e delle regioni. Per fare gli esempi dei più noti si trattò di Gerardo D’Ambrosio, Antonio Di Pietro, Michele Emiliano, Gianrico Carofiglio, Silvia Della Monica, Alberto Maritati.
Tutti i magistrati che godettero dell’elezione in Parlamento, nelle regioni o in altre sedi istituzionali erano pubblici ministeri, nessuno giudicante.
Si tratta di un indizio sensibile sulla linea seguita, consapevolmente o di fatto, da Achille Occhetto e Luciano Violante. Per la conquista del potere politico sembrano aver optato per l’uso dell’artiglieria pesante, vale a dire le corti giudiziarie.
La presenza (e penetrazione) pervasiva dei magistrati, fin dentro le istituzioni di ogni ordine e grado nella storia italiana del dopoguerra, alimenta un’ipotesi di ricerca che lo storico non può preventivamente escludere.
II PCI, e non la DC, “vero partito della mafia”?
A spiegare di che cosa i mafiosi potevano dirsi grati con gli ex comunisti sarebbero i comportamenti parlamentari di questi ultimi. Non credo, però, che l’accumulazione di elementi probatori sulla politica di contenimento-negazione di benefici alla criminalità mafiosa in carcere, seguita dal PDS, possa far venire meno l’allusione (diffamatoria oltre ogni limite) dominante nei mass media su
“una mafia contigua al governo e alla Democrazia cristiana, contro un opposizione comunista vittima di questa presunta alleanza scellerata”[7].
Al contrario della Dc, com’è noto, i comunisti non sono stati una forza di governo in Sicilia e neanche sul territorio nazionale, salvo che dopo le elezioni del 2015 – e in alcune regioni, come l’Emilia Romagna, la Toscana e l’Umbria, anche prima di questa data – hanno goduto di consensi così vasti da poter suscitare l’interesse della mafia a stabilire con essa scambi o alleanze[8].
Ciò detto, è significativo quanto si può derivare dall’analisi dei comportamenti di voto dei parlamentari ex comunisti nei confronti dei provvedimenti legislativi assunti per la lotta alla mafia.
È difficile assumerli come prove. Costituiscono, però, sicuramente “gravi e inquietanti indizi politici” su cui avrebbe dovuto indagare la Commissione parlamentare antimafia. Invece si guardo bene dal farlo. Mi limito a quattro episodi.
Il primo si riferisce al settembre 1989, quando fu emanato il decreto Andreotti-Vassalli. Era l’inizio di una forte legislazione antimafia.
Prevedeva l’allungamento del periodo di carcerazione preventiva a coloro che erano imputati di associazione mafiosa e una serie di misure a favore dei pentiti.
Durante il dibattito alla Camera sulla sua conversione in legge, due dirigenti come Anna Finocchiaro e Luciano Violante furono estremamente indisponibili e duri. Le loro dichiarazioni contrastarono la proposta di trattenere in carcere, nelle more dalla condanna in appello, i boss già condannati nel maxiprocesso.
Nello stesso 1989 il gruppo parlamentare comunista oppose una strenua resistenza contro il decreto-legge Vassalli che prolungava la carcerazione preventiva per 38 camorristi e mafiosi. Messi in carcere da Falcone e Borsellino rischiavano di essere liberati per decorrenza dei termini.
Fu anche l’occasione per assestare una massiccia randellata al governo DC-PSI.
Il secondo voto prendeva di mira, rigettandola, l’estensione ai mafiosi, mediante l’articolo 41-bis, del carcere duro.
Concepito e applicato inizialmente a carico dei militanti delle Brigate rosse, dal governo Andreotti nel giugno 1992, col decreto Martelli-Scotti (vale a dire dopo la strage di Capaci in cui perirono Giovanni Falcone, la moglie e la scorta) venne esteso ai mafiosi. Ma il Parlamento si mostrò “riottoso”. Come ha ricordato l’ex magistrato e ora onorevole Roberto Scarpinato,
“non voleva approvare il 41-bis definendo forcaioli e giustizialisti coloro che lo proponevano. Non fu, quindi, una vittoria della politica, ma fu una vittoria dello Stato, della società civile. E una legge sporca di sangue e non si può definire una vittoria della politica”[9].
L’obiettivo di contenere, se non di eliminare, questo modo di espiare la pena è ancora oggi, è bene tenerlo presente, una delle priorità dell’esercito corleonese in rotta nelle prigioni di Stato. A ragione, è stato ricordato che la campagna stragista di Totò Riina e Bernardo Provenzano aveva preso di mira:
la legislazione antimafia che, dal 1989 in poi, il governo Andreotti aveva messo in atto sia con l’allungamento della carcerazione preventiva per mafiosi, camorristi e ‘ndranghetisti, sia con la legislazione sui pentiti. Le bombe di Roma, Firenze e Milano erano legate a due richieste: la riduzione del carcere duro (il 41-bis) e, più importante, la concessione ai mafiosi – come recitava il “documento” del luglio 1992 agli atti del Senato – della libertà e di una nuova identità, attraverso i programmi di protezione [10].
In terzo luogo, non poteva mancare il ricordo del fuoco di sbarramento che da parte della sinistra comunista (di concerto con quello dei compagni di strada della Rete, segnatamente Alfredo Galasso e Leoluca Orlando) e di quella giudiziaria nel novembre 1991 venne scatenato sia contro l’istituzione della Direzione investigativa antimafia, sia contro lo stesso Giovanni Falcone che l’aveva ideata e si era proposto di capeggiarla. Non ci si fece mancare neanche l’occasione, nell’intervento di Orlando, di accreditare la proposta come un provvedimento addirittura gradito a Cosa Nostra.
Più noto, perché risulta il più citato dalla saggistica è quanto ebbe luogo col governo presieduto dall’ex governatore della Banca d’Italia Carlo Azeglio Ciampi. Il PDS ne fu il maggiore azionista. Accolse anche la decisione del ministro della Giustizia Giovanni Conso di revocare il carcere duro a tre centinaia di mafiosi.
Ancora più impressionante e grave fu quanto avvenne nella gestione dei programmi di protezione. La manica larga usata ha permesso a molte migliaia di mafiosi di limitare a pochi anni la presenza in carcere e tornare liberi.
Di questa misura si avvantaggiarono, sembra incredibile ricordarlo, gli stessi killer di Giovanni Falcone, di sua moglie e della sua scorta. Lo Stato di diritto venne, dunque, ridotto a una farsa.
Con tale risultato, si riuscì a doppiare lo scempio commesso nella vicenda che vide imputato, arrestato, condannato e poi liberato come assolutamente innocente, il giornalista televisivo Enzo Tortora. I magistrati che se ne occuparono, privandolo di anni di libertà e infliggendogli grandi sacrifici e sofferenze, furono promossi fino a scalare, senza intoppi, le posizioni apicali della carriera giudiziaria.
Nel difendere privilegi e diseguaglianze castali la corporazione dei magistrati non ha eguali, anche grazie alla complicità delle massime autorità politiche dello Stato (dal Consiglio superiore della magistratura alla presidenza della Repubblica).
Alla conturbante politica di liberalizzazione (sconti di pena, vantaggi premiali eccetera), il Parlamento nel 1999 dovette porre un freno. Lo fece condizionando l’accesso ai benefici premiali allo sconto di un terzo della pena, in carcere. Era un vincolo minimo.
Ai fatti prima elencati se ne possono aggiungere altri due.
Negli anni 1989-93 non erano mancati collegamenti, se non li si vuole chiamare “buoni rapporti”, tra esponenti di Cosa Nostra da una parte, investigatori e uomini dei servizi (italiani e stranieri) dall’altra.
Un episodio eclatante fu il rapporto riservato col boss “pentito” Totuccio Contorno, ad opera del prefetto Domenico Sica (ex magistrato e poi Alto commissario antimafia) e del capo della Criminalpol Gianni De Gennaro.
Si può negare una certa analogia col secondo episodio, vale a dire il contatto stabilito tra il generale Mario Mori e Vito Ciancimino?
Questa opinione, formulata da Cirino Pomicino, anticipa quella dei giudici Pellino e Anania, cioè che i rapporti prima citati “possono inquadrarsi in un lavoro di intelligence per colpire la mafia”[11].
È la teoria diventata una sorta di paradigma giudiziario del “buon fine”, del compromesso, dell’interesse superiore”, del “male minore” eccetera, al quale si sarebbero ispirati gli uomini in divisa dell’Arma dei carabinieri e i politici che cercarono accomodamenti e scambi con i criminali più sanguinari.
Si può dire che questi ultimi includono, insieme ai molto noti, e spesso qui citati, anche quelli reclutati e promossi dai governi di in carica quando si verificarono quelle circostanze?
L’ex premier, già prima della sua full immersion nella vita politica, si sarebbe adoperato per garantire la necessaria sicurezza alle reti e agli uffici di Mediaset, come pure alla vita dei propri congiunti da violenze di ogni tipo in Sicilia.
Nel cercare di puntualizzare le responsabilità nei rapporti con la mafia si è finito per suggerire un’interpretazione, che è più di un’ipotesi, di carattere politico.
Non solo si proclama, non astenendosi dal citare una serie i fatti, che “la mafia in Sicilia e nel Paese è stata da sempre, fin dall’inizio, contro la Dc”[12], ma si fa un bel salto in alto col dire che sarebbero stati gli ex comunisti ad aver avuto un interesse prevalente, se non esclusivo, ad avviare un negoziato con Cosa Nostra[13].
Di questa impostazione storiografica, mi sono limitato a offrire una sintesi, lasciando che gli altri protagonisti chiamati in causa (Luciano Violante, Achille Occhetto e Walter Veltroni) possano motivare le ragioni, documentandole adeguatamente, del loro probabile dissenso dalla narrazione qui riportata.
Nell’esaminare la trattativa Stato-mafia lascia, nondimeno, interdetti (e maldisposti verso investigatori superficiali e poco coraggiosi) un’omissione prolungata nel tempo. Lo si può chiamare, benevolmente, una sorta di inveterato silenzio (simile a quello da cui vengono circondati gli “intoccabili”).
Della trattativa tra pezzi dello Stato può non aver saputo niente un personaggio colto, attento, informato, autorevole e insieme potente come l’ex capo della Polizia Giovanni De Gennaro?
Obiettivo: negare l’esistenza della trattativa
La misurata cautela di Pomicino nel trascinare gli ex comunisti sul banco degli accusati per complicità con la mafia ha pochi riscontri nel dibattito di (e su) quegli anni. Non ci si trattenne dallo scrivere che era stata “una boiata pazzesca” sostenere l’esistenza di un rapporto di dare e avere tra due contraenti, uno immerso nel buio dell’illegalità, e l’altro addetto a stroncarla. È quanto fecero organi di stampa (grandi e piccoli) di ogni diretta, e indiretta, osservanza berlusconiana o in preda a un introverso sentimento di autonomia.
Non mancò chi, attraverso un esame delle date, contestò addirittura l’origine di queste danze funebri avviate dallo Stato di diritto. Per il quotidiano online fondato e diretto da Luca Sofri, Il Post, esisterebbero dei dubbi, più volte espressi, sulla reale esistenza della “trattativa”. Non sarebbero stati reperiti documenti o altre fonti scritte che ne attestino l’esistenza, ma solo testimonianze rese molti anni dopo da ex mafiosi e persone a suo avviso scarsamente affidabili.
Nel giugno 1992, quando i ROS avviarono l’apertura del negoziato con lo Stato, il 41-bis non esisteva ancora. Dopo la morte di Giovanni Falcone (23 maggio 1992), il governo ne aveva previsto l’introduzione per l’8 giugno 1992. Subirà dei ritardi anche per il fatto che in Parlamento molti erano indisponibili ad approvarlo.
L’orribile carneficina di via D’Amelio, cioè l’uccisione di Paolo Borsellino e della sua scorta[14], fu l’evento che servi ad accelerarne l’approvazione in Parlamento. In cambio della fine della strategia stragista, secondo i magistrati dell’accusa, politici e carabinieri avrebbero offerto l’attenuazione del carcere duro per i mafiosi che si trovavano in prigione.
Rispetto a quelli de Il Post (che comunque prospettavano dei problemi che meritavano un approfondimento), nei giornalisti de Il Foglio non mancò anche della perspicacia. Intuirono, infatti, predisponendo una difesa durata quasi trent’anni, che il negoziato dello Stato con killer professionisti come Totò Rina, Bernardo Provenzano, Giovanni Brusca, Matteo Messina Denaro eccetera, prendeva una direzione ben precisa come ipotizza l’articolo de Il Post dell’aprile 2018[15].
Qualcuno, nei dintorni, l’aveva temuto e insieme profetizzato:
“La Trattativa Stato-mafia è una minchiata, non c’è niente di niente [.]. Una spaventosa messinscena il cui obiettivo è mostrificare il presidente della Repubblica, calunniare Berlusconi (.]”.
Fu la voce calda e stentorea di Giuliano Ferrara[16].
La strategia politica dei corleonesi non è immobile, ma si muove, diciamo pure che evolve. Ci fu all’inizio una passione per un vecchio sogno politico della Sicilia, il federalismo. A esso si sostituì un calcolo, e un investimento, più concreto – da parte di tutti i boss – nel movimento politico all’epoca partito di maggioranza.
Una volta formato, nel 1994, il primo governo con Silvio Berlusconi non ricorrerà più al canale dell’Arma dei carabinieri, ma a una trattativa che passò attraverso differenti vie.
Di qui la necessità di minimizzare, relativizzare, non ammettere, con ogni mezzo, a cominciare da un’insonne e tenace campagna “negazionista” quanto era avvenuto: cioè che lo Stato aveva, in misura assai pericolosa, riconosciuto come soggetto contraente legittimo una banda criminale, Cosa Nostra appunto. Il suo ulteriore rafforzamento ne fu una gravissima conseguenza.
Il silenzio su di essa è ormai una linea di condotta della stampa di ogni rango. Ne è un esempio recentissimo, mentre scrivo, quanto si può leggere per la penna di uno dei maggiori protagonisti [17].
Calogero Mannino sollecita il negoziato
A far avviare la trattativa (dai suoi ufficiali di grado minore Mario Mori e Giuseppe De Donno) fu il generale Antonio Subranni, comandante del vertice dei ROS. A sollecitarla furono le lamentele e l’angoscia provenienti dal ministro Calogero Mannino.
I carabinieri l’avevano informato che contro di lui era stato programmato a Palermo un attentato. La macchina esecutiva era pronta a entrare in funzione appena avesse rimesso piede nel capoluogo siciliano. Ma a esserne messi a parte, presso la segreteria politica di Roma del ministro e la residenza romana di Vito Ciancimino, dove si incontrarono più volte, furono due uomini dello Stato (un alto funzionario del SISDE, Bruno Contrada, e il capo dei ROS, il generale Antonio Subranni) e successivamente il giornalista del Corriere della Sera Antonio Padellaro[18]
Subranni fra la strage di Capaci e quella di via D’Amelio autorizzò il colonnello Mori e il capitano De Donno a dialogare con Totò Riina. A lui (insieme a Bernardo Provenzano) i Ciancimino padre (Vito) e figlio (Massimo) fecero pervenire il contenuto delle richieste dello Stato che alcuni alti funzionari pensarono di rappresentare.
Quando si resero conto del livello raggiunto dalla trattativa si evitò di farne un resoconto ai vertici della magistratura e dell’Arma dei carabinieri. Si preferì la strada meno maestra di confidarsi con autorità istituzionali. Mi riferisco alle dottoresse Liliana Ferraro e Fernanda Contri e a Luciano Violante.
Il generale Subranni ne avrebbe ragguagliato (non per iscritto, ma informalmente) il ministro della Giustizia Giovanni Conso. A sua volta quest’ultimo venne tenuto sotto forte pressione dal capo dello Stato.
Oscar Luigi Scalfaro era convintissimo che il carcere duro andasse mitigato per lanciare ai boss un messaggio positivo, cioè di disponibilità a concordare un’intesa per porre fine alle mattanze.
Nei confronti di Luciano Violante, Paolo Cirino Pomicino muove dei rilievi per nulla leggeri e assai inquietanti. Non avrebbe permesso a Vito Ciancimino (che gliene fece esplicita richiesta nell’ottobre 1992, anche su sollecitazione del generale Mori) di deporre presso la Commissione parlamentare antimafia da lui presieduta. Nel corso di essa, l’ex sindaco di Palermo avrebbe potuto fornire informazioni preziose per l’arresto di Totò Riina.
Per la verità, erano già state anticipate da Mori al magistrato torinese Giancarlo Caselli, prima che andasse a Palermo come procuratore.
Vito Ciancimino venne, però, arrestato. E Violante non rese più possibile l’audizione, fissata in precedenza, anche se lo stato di detenzione dell’amministratore corleonese, grande amico di Bernardo Provenzano, non costituiva un impedimento a riproporla. Com’è noto, la Commissione da lui presieduta godeva degli stessi poteri assegnati all’autorità giudiziaria.
“Era forse così devastante quel che Ciancimino voleva dire?”
si è chiesto Paolo Cirino Pomicino[19]
Non dispongo di elementi né per confermare, né per escludere quanto il parlamentare ed ex ministro democristiano afferma, cioè che
“l’incontro Mori-De Donno-Ciancimino servi (…) a dare notizie specifiche per come catturare Totò Riina tanto che prima ancora che Caselli andasse a Palermo Mori lo incontrò a Torino per illustrargli le indicazioni ricevute”.
Nella primavera e nell’estate del 1993, dopo l’aggressione ai musei e alle opere d’arte di Roma, Firenze e Milano si ha l’attuazione di quanto il senatore del PDS, Lucio Libertini, aveva registrato – traendolo da uno scritto anonimo in un’interrogazione parlamentare del luglio 1992.
Dando attuazione ai programmi di protezione, secondo i dati elaborati dal senatore di Napoli, si provvide a scarcerare fior fiore di criminali delle tre maggiori unità (mafia, camorra e ‘ndrangheta). Nei dieci anni successivi raggiungeranno il vertice impressionante di 10 mila.
Facendo un bilancio si può dire che trovarono applicazione le due richieste che erano all’origine della disseminazione omicidiaria di bombe a Roma, Firenze e Milano. In primo luogo la mancata proroga al 41-bis di esponenti non minori della criminalità organizzata, e l’eliminazione dalla testa del DAP di chi, come Nicolò Amato, pur non condividendola, disciplinatamente l’aveva fatta applicare.
In che modo un uomo gentile, pieno di dubbi e di paure, quale viene descritto Giovanni Conso, poté assumere questi due gravi provvedimenti senza disporre di ogni possibile copertura e garanzia necessarie?[20]
In secondo luogo, la legislazione premiale sui pentiti estende i benefici (più libertà e nuova identità), avviando un processo di svuotamento delle carceri di migliaia di condannati a decine di anni di reclusione (è il caso dei killer di Giovanni Falcone), addirittura con sentenze passate in giudicato.
Dopo l’ottobre 1993 non risuona più nel territorio nazionale il rumore sordo delle bombe. Dunque, la stagione delle stragi era finita.
Una “via giudiziaria al socialismo”?
Sbaraccato il governo Amato, i suoi principali affossatori (Achille Occhetto, Luciano Violante e La Repubblica di Eugenio Scalfari) diventano i garanti della nascita e della durata del governo guidato dall’ex presidente della Banca d’Italia, Carlo Azeglio Ciampi.
Corrisponde a un pregiudizio politico o a una domanda storiograficamente legittima chiedersi se la maggioranza dei dirigenti ex comunisti (esclusi Gerardo Chiaromonte, Giorgio Napolitano e Massimo D’Alema) scelsero “la via giudiziaria al socialismo”? Accodandosi alla politica di devastazione istituzionale seguita all’azione di Mani pulite[21], decisero di lastricare l’accesso al governo e in generale al potere, facendosi traghettare per la scorciatoia giudiziaria?
È impressionante il numero dei pentiti di mafia e di camorra che vennero scarcerati in seguito alla politica “buonista” di Giovanni Conso e della legge 82-1991 (sulla premialità per i pentiti). Tra il 1995 e il 2007 ben 4500 detenuti saranno destinatari di misure alternative al carcere; e 6500 saranno quelli rimessi in libertà.
L’interrogativo può essere reso più esplicito con parole più nette:
Né Conso, né Ciampi, men che meno il ministro dell’Interno Nicola Mancino, insomma, avrebbero potuto ridurre il carcere duro a trecento mafiosi e avviare, con i programmi di protezione, la liberazione di alcune migliaia di mafiosi, se non lo avesse deciso la forza politica che, pur senza propri ministri, teneva in vita quel governo[22].
Di fronte a questo esito positivo, e probabilmente insperato, Totò Riina decise di alzare il tiro e mettere a punto i termini dello scambio. Avrebbe posto fine a delitti e massacri in cambio dell’adozione di misure correttive su carcere duro, pentitismo, sequestro dei beni mafiosi. In particolare si chiese l’abolizione dell’ergastolo, l’ammorbidimento del 41-bis, la chiusura dei supercarceri dell’Asinara e di Pianosa, la modifica della legge Rognoni-La Torre sulla confisca e il sequestro dei patrimoni mafiosi eccetera.
Alla fine, rendendosi conto – su consiglio di Bernardo Provenzano e Vito Ciancimino – che questo era puro delirio negoziale, Riina si limitò a redigere un “papello” (come verrà chiamato) contenente dodici proposte.
Ma non bisogna dimenticare quanto il mondo editoriale, legale, parlamentare e giornalistico si ostina a obliterare.
Intendo dire che la trattativa ha sempre avuto un duplice volto. Per un verso attenuare le sofferenze e i disagi dei detenuti (in primo luogo perché veniva impedito l’esercizio del comando e neutralizzata l’autorità dei capi, i boss, sul popolo mafioso); e, per un altro verso, non vanificare la nuova intesa politica di fronte al crescente orientamento dell’opinione pubblica che a livello politico si sarebbe espresso in un movimento espressione di quell’orientamento: Forza Italia.
I vecchi referenti di Cosa Nostra vennero bruciati nel 1991.
Rina si rassegnò, schiumando di rabbia, a prendere atto che la Dc (nelle persone in primo luogo di Giulio Andreotti e dei suoi luogotenenti Salvo Lima e Ignazio Salvo) era stata straordinariamente impotente o debole. Non era riuscita, in Cassazione, il 30 gennaio 1992, né a confermare Corrado Carnevale alla testa della prima sezione penale, né a modificare le molte e pesanti sentenze di condanna del maxiprocesso (1986-1987).
Pertanto, l’indicazione di voto dell’apparato mafioso cessava di essere indirizzato verso la DC. Per la verità, già nelle elezioni politiche del 1987 la scorta di voti controllata da Cosa Nostra era stata veicolata sulle liste socialiste e radicali, disertando la DC, che era stata il porto tradizionale di ancoraggio della politica mafiosa.
Riina e la centralità della politica
Non ha, però, alcun senso, trattandosi di due “stragisti”, liquidare la linea di condotta di Totò Riina come malata, ossessionata da una vocazione imperturbabilmente omicidiaria, al solo fine di privilegiare quella di Bernardo Provenzano.
Questa è una semplificazione e una falsificazione.
Il capo dei boss ha sempre pensato che senza il controllo del governo e dell’amministrazione pubblica, cioè dello Stato, il destino di Cosa Nostra sarebbe stato segnato. Sul punto, sin dalla fine del 1991, aveva fatto presente ai suoi collaboratori e alleati: “Bisogna fare la guerra per poi fare di nuovo la pace”.
Addirittura si era premurato di esprimersi su Giulio Andreotti in questi termini:
“Ma come? Tu prima ti prendevi i nostri voti e poi ci mandi a dire con Salvo Lima che non vuoi più sentire parlare di noi? E allora poi noi abbiamo cominciato”[23] , a far fare la fine del tonno (l’inizio del nuovo corso stragista) a Falcone, Lima, Salvo, e a minacciare di farne fare la prova allo stesso implacabile magistrato Nino Di Matteo.
Non si può trarne la conseguenza che Totò Riina fosse un sanguinario dedito alle vendette personali. In realtà in lui, anche quando stilava il verdetto di morte di un uomo dello Stato, ha sempre prevalso la vocazione del capo, cioè di fare gli interessi della banda criminale, di salvaguardare il controllo di un esteso territorio sottratto allo Stato, di cui ha dimostrato essere il sovrano indiscusso. E la consapevolezza che la sfera politica, il rapporto con i suoi protagonisti andava mantenuto, e curato, ha sempre dominato il suo comportamento.
Il suo grande ricatto è consistito in una serie di equazioni che sono state riassunte così:
“Uccidere per trattare. Spazzare via i traditori auspicando che altri referenti si facessero avanti. Esportare fuori della Sicilia la strategia del terrore. Seminare panico nel Paese. Instaurare un patto politico mafioso con soggetti politici nuovi di zecca”[24].
Chi può negare che fra il febbraio del 1992 e il 1994 sia stata attuata tale strategia?
L’accurato e voluminoso accumulo di materiale probatorio da parte dei giudici Alfredo Montalto e Stefania Brambille consente di collocare al loro posto date e protagonisti.
Voglio dire che il 12 marzo 1992, con la prima vittima della politica stragista scatenata da Totò Riina (l’ex sindaco di Palermo e parlamentare europeo Salvo Lima), si era dato fuoco alle polveri, col rischio di avere come conseguenza l’innesco di un processo di destabilizzazione politica.
A rendersene conto furono il ministro dell’Interno Vincenzo Scotti e il capo della Polizia Vincenzo Parisi (dal 1987 al 1994). Con grande senso di responsabilità resero pubblica la lista dei bersagli eccellenti con la quale Cosa Nostra intendeva, mediante esecuzioni sommarie, dare vita a una grande mattanza: il premier Giuliano Amato, i ministri Salvo Andò, Calogero Mannino, Carlo Vizzini e lo stesso figlio di Andreotti, oggetto di un possibile sequestro.
Ebbene, la ferma denuncia che Vincenzo Scotti portò in Parlamento fu sopraffatta dal sarcasmo del suo governo e del Parlamento. L’incoscienza fu pari all’assoluta sottovalutazione della volontà della mafia di farsi sentire.
Il povero Scotti, che era già personalmente incerto e debole, fini circondato da un giudizio di inaffidabilità. Anche il dovere di rispettare una regola statutaria della Dc lo indusse a dare le dimissioni.
Siamo nel bel mezzo del governo Amato, e la strada per l’accesso al Viminale viene lastricata per Nicola Mancino, gradito al capo dello Stato Oscar Luigi Scalfaro.
Come si è visto, il Quirinale fu molto attivo, diciamo pure “invasivo”, nel curare una linea che finiva per favorire la ricerca di un’intesa, di un qualche scambio con la criminalità per cercare di piegarne la durezza.
Qualcosa di molto significativo era nel frattempo cambiato.
Era chiaro che a trattare affari di ogni valore e liceità con la più potente cupola criminale da circa un secolo e mezzo in inesausta attività, non sarebbero stati più solo lo stalliere Vittorio Mangano (condannato anche per estorsione e traffico di droga) e un’altra vecchia conoscenza politica di Cosa Nostra, ma un grande imprenditore milanese sceso in politica.
[1] Salvatore Sechi, La Mafia non è finita dalla trattativa con lo S6tato all’arresto di Messina Denaro (1993-2023), Firenze, goWare edizioni, 2023, 207 p. Le pagine qui riprodotte sono tratte dall’epilogo alle pp. 154-168.
[2] Si veda “Trattativa Stato-mafia: le motivazioni della sentenza della Corte di assise di appello di Palermo”, Giurisprudenza penale, 6 febbraio 2023.
[3] Si veda “Trattativa Stato-mafia: depositate le motivazioni della Corte di assise di Palermo”, Giurisprudenza penale, 6 febbraio 2023. La rivista ospita un commento di Giuseppe Amarelli, “La sentenza sulla trattativa Stato-mafia: per il Tribunale di Palermo cucci i protagonisti sono responsabili del delitto di minaccia a un corpo politico dello Stato di cui all’art. 338 c.p.”, al quale si deve un secondo intervento, “Il processo sulla trattativa: analisi e critica di una sentenza ‘storica””, Cassazione penale, 2019, 1499 ss. A uno dei maggiori penalisti italiani è riferibile una nota critica nel merito: Giovanni Fiandaca, “La trattativa Stato-mafia non è reato tipico, ma reato sostanziale”, Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2018, 2181 ss. Nota pubblicata successivamente in un inserto del quotidiano Il Foglio.
[4] 151 Si veda Paolo Cirino Pomicino, La repubblica delle giovani marmotte, prefazione di Giuliano Ferrara, Torino Utet, 2015, p. 187 e per un approfondimento i capitoli XII e XIII del saggio più recente, Il grande inganno. Controstoria della Seconda Repubblica, prefazione di Ferruccio De Bortoli, Torino, Lindau, 2022, pp. 121-133.
[5] Paolo Cirino Pomicino La repubblica delle giovani marmotte, op. cit. alla nota 4, p. 188.
[6] Paolo Cirino Pomicino, Il grande inganno., op. cit. alla nota 4, pp. 11-112
[7] Il grande inganno, Ibidem, p. 130.
[8] La penetrazione in Emilia è al centro della relazione, per l’apertura dell’anno giudiziario, del procuratore generale reggente di Bologna, Lucia Musti. Cfr. “Anno giudiziario, Musti: ‘In Emilia-Romagna la mafia ormai è radicata’”, La Repubblica, 23 gennaio 2022; Centro di documentazione Cultura della Legalità Democratica, Mafia e criminalità in Toscana. Documentazione ufficiale. Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, s.d.; sull’Umbria la nuova relazione del ministero degli Interni al Parlamento, realizzata attraverso la Direzione Investigativa Antimafia (DIA).
[9] Si veda “Scintille in Senato tra Scarpinato e Renzi sul 41-bis. Il senatore M5s: ‘Faccia tosta’. Il leader di Iv: ‘Si vergogni'”, Tgcom24, 1° febbraio 2023.
[10] Si veda la ricostruzione, con aspetti anche di testimonianza, di Paolo Cirino Pomicino, La repubblica delle giovani marmotte, op, cit. alla nota 4, p. 194.
[11] La repubblica delle giovani marmotte, ibidem, p. 189.
[12] Paolo Cirino Pomicino, Il grande inganno…, op. cit. alla nota 4, p.114.
[13] Il grande inganno, Ibidem. Le pagine 111-134 che comprendono i capitoli intitolati “Mafiosi e camorristi: bugie e omissioni” e “Il grande depistaggio”.
[14] Si veda “Le condanne per la ‘trattativa Stato-mafia””, Il Post, 20 aprile 2018.
[15] Questa previsione è stata anticipata dalla saggistica che, a parte i cedimenti al fuoco del pregiudizio politico, ha saputo meglio adunare gli elementi disponibili e ricavarne conclusioni mi pare non diverse da quelle prima di Antonio Ingroia e ora di Alfredo Montalto. Mi riferisco a Marco Lillo e Marco Travaglio, Padrini fondatori. La sentenza sulla trattativa Stato-mafia che battezzò col sangue la Seconda Repubblica, Roma, PaperFirst, 2018, 646 p.
[16] Nicola Di Matteo e Saverio Lodato, Il Patto sporco e il silenzio, Milano, Chiarelettere, 2022, 240 p. [il passo citato è a p.104]. Il giornalista romano è citato, insieme ad altri “negazionisti” come Pino Arlacchi, Enrico Deaglio, Giuseppe Sottile, Andrea Marcenaro, Giorgio Mulè ed Eugenio Scaltari.
[17] Giuseppe Sottile, “L’invincibile mafia”, Il Foglio, 12 febbraio 2013, p. v, secondo il quale, ad alimentare questo mito di una Cosa Nostra perennemente vittoriosa, sarebbero toghe in carriera e talk show, mentre a una solitudine e a una sofferenza inenarrabili sarebbero stati condannati i magistrati palermitani che i boss si preoccuparono soprattutto di arrestarli. Non c’è che dire, una grandissima semplificazione.
[18] Sull’intervista rilasciata, tre anni dopo, da Antonio Padellaro al Corriere della Sera cfr. Giuseppe Pipitone, “Trattativa, Padellaro: Nel ’92 Mannino sentiva di essere nel mirino della mafia”, Il Fatto Quotidiano, 9 gennaio 2014.
[19] Paolo Cirino Pomicino, La repubblica delle giovani marmotte, op. cit. alla nota 4, p. 192.
[20] La repubblica delle giovani marmotte Ibidem, p. 195.
[21] Si vedano le riflessioni critiche degli opinionisti del Corriere della Sera (dal già citato Giovanni Bianconi a Goffredo Buccini, Il tempo delle Mani pulite, Roma-Bari, Laterza, 2021, 256 p.): Mattia Feltri, Novantatré. L’anno del terrore di Mani pulite, Prefazione di Giuliano Ferrara, Venezia, Marsilio, 2016, 320 p., e Alessandro Bernasconi (a cura di), Mani pulite. Governo dei giudici, “pensiero unico” 1992-2022, Milano, Luni editrice, 2022, 240 p., schierati su posizioni sensibilmente diverse da quelle di Gianni Barbacetto, Peter Gomez e Marco Travaglio, Mani pulite. La vera storia. Per chi non c’era, per chi ha dimenticato, per chi continua a rubare e a mentire, nuova edizione, Roma, Chiarelettere, 2022, 912 p.
[22] Paolo Cirino Pomicino, La repubblica delle giovani marmotte, op. cit. alla nota 4, p. 196.
[23] Nicola Di Matteo e Saverio Lodato, Il Patto sporco e il silenzio, op cit. alla nota 16, p. 48.
[24] Nicola Di Matteo e Saverio Lodato, Il Patto sporco e il silenzio, ibidem, p. 78.