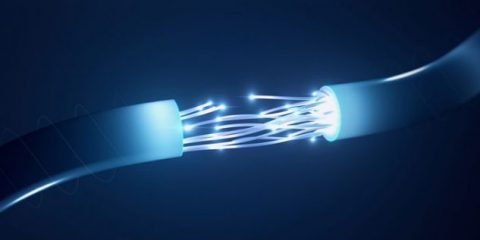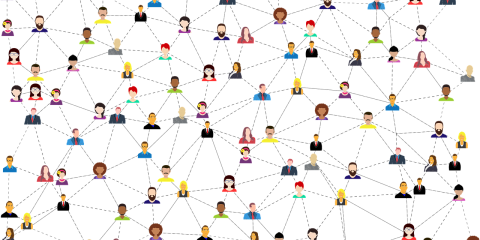Quanto è accaduto in Italia sul tema della rete unica di telecomunicazioni è una magnifica metafora dello stato del Paese, delle sue dinamiche politiche, dello stato dell’industria, del ruolo dei sindacati, della consapevolezza dei consumatori.
Le telecomunicazioni hanno rappresentato uno degli assi portanti dell’industria italiana, coltivando da sempre un rapporto preferenziale con il potere.
In Italia, la SIP prima e Telecom Italia dopo (come fu ribattezzata con la privatizzazione europea del settore a metà degli anni Novanta) hanno rappresentato un riferimento importante anche per lo sviluppo delle competenze tecnologiche del nostro Paese.
Telecom Italia era ai vertici delle telecomunicazioni mondiali (rientrava tra le prime cinque società di telecomunicazioni al mondo) operava in decine di Paesi, contribuiva in modo cospicuo al PIL del Paese, aveva il laboratorio CSELT di Torino che era una piccola Silicon Valley ante litteram nel cuore dell’Europa, era infine particolarmente considerata dalla politica che aveva attenzione e rispetto per l’intero settore.
Negli anni Novanta la privatizzazione e l’uscita dello Stato dalle telecomunicazioni. Inizia la parabola discendente del settore in Italia
Per la verità, nel silenzio assoluto degli osservatori dell’epoca, la privatizzazione degli anni Novanta delle telecomunicazioni trovò nel governo italiano uno dei peggiori esecutori europei. Presidenti del Consiglio e ministri delle Finanze come Romano Prodi, Massimo D’Alema e Giuliano Amato, si rivelarono più realisti del re ed adottarono acriticamente la soluzione dell’uscita dello Stato dalle telecomunicazioni, fatta eccezione per il cosiddetto “nocciolino duro” pubblico, una presenza pubblica irrisoria e inferiore all’1% dell’azionariato. Al contrario in Francia e Germania i rispettivi Stati decisero sì di privatizzare gli operatori monopolisti nazionali di tlc, ma mantenendo quote azionarie importanti del 25-30% circa.
Si arrivò così alla fine degli anni Novanta. Era intanto esploso il fenomeno internet, che faceva prevedere cambiamenti strutturali in ogni settore. L’aspettativa fu talmente pompata che, con l’inizio del decennio successivo, lo scoppio della “bolla internet” sembrò mettere in discussione quel paventato futuro tecnologico che la privatizzazione delle telecomunicazioni e l’avvento di internet avevano annunciato. Le regole emotive del mercato sembravano indicare la via maestra nel ritorno al passato, all’economia “del cemento” piuttosto che dei bit, ovvero delle cose concrete che si toccano con mano.

In Italia questo coincise con un ritorno in grande stile di Silvio Berlusconi al potere. L’opera di demolizione delle telecomunicazioni nazionali, avviata dai governi Prodi, D’Alema e Amato fu ulteriormente perfezionata a partire dal 2001 dai due governi Berlusconi che coprirono l’intera legislatura sino al 2006. Le telecomunicazioni erano già indebolite dall’azione dei precedenti governi che avevano deciso di allentare l’attenzione sulle politiche industriali del settore, che tanto avevano peraltro contribuito alla crescita economica del paese. Con l’arrivo di Berlusconi al governo nel 2001, era inevitabile che il focus sulle telecomunicazioni si spostasse sulla vecchia televisione, il settore prevalente di business del premier. Per cinque lunghi anni non si parlò più di telecomunicazioni.
E la cosa non cambiò con il ritorno di Romano Prodi nel 2006, un governo molto provvisorio, che fece giusto i bandi di gara per il WiMax. Nel 2008 Berlusconi ritornò al governo senza alcun cambio di scenario. L’allora ministro Paolo Romani si disinteressò sostanzialmente di qualsivoglia politica industriale verso le telecomunicazioni. Si arrivò così al governo di Mario Monti del 2011 che si guardò bene dal trattare le telecomunicazioni e la stessa cosa accadde con il successivo governo guidato da Enrico Letta, che tenne la scena appena per un anno circa, per fare spazio al successivo governo guidato da Matteo Renzi.
In sostanza, per tre lustri era stata cancellata in Italia qualsivoglia politica industriale del settore, nonostante la crescente competizione tra operatori. Da canto suo, l’azione dell’autorità di regolazione del settore, AgCom, invece di difendere equamente le imprese del settore da un lato e i consumatori dall’altro, adottò, facendo vanto di tale inopportuna scelta, la scelta di dare maggior peso alle prerogative dei consumatori. E ciò portò al varo di regole che indussero gli operatori a fronteggiare la concorrenza facendo a gara tra loro a chi abbassasse di più i prezzi al pubblico dei servizi. Il risultato fu che i servizi di telecomunicazione italiani divennero quelli a più basso costo d’Europa. Fu un risultato di cui AgCom andò impropriamente fiera, ma che invece generò un graduale impoverimento del settore. Le telecomunicazioni videro ridursi i margini oltre ogni pessimistica ipotesi. E, come si sa, a margini bassi non vi sono più possibilità di investimenti in ricerca e sviluppo né di investimenti di crescita ed espansione per il settore, il che determina inevitabilmente (al contrario di ogni aspettativa) l’abbassamento dei livelli di qualità dei servizi offerti ai consumatori. Esattamente ciò che successe sul mercato italiano delle telecomunicazioni.
Il tracollo di Telecom Italia. Dall’assalto dei finanzieri all’arrivo di Telefonica e poi di Vivendi, soci industriali predatori
Va anche detto che agli accadimenti sopra sommariamente riportati fece da contraltare il cambiamento di ruolo e di peso di Telecom Italia. Da società modello a livello mondiale, gradualmente si spogliò di tutti i gioielli che aveva costruito nel corso dei decenni. Un impoverimento aziendale avviato con l’ingresso di Roberto Colaninno a fine anni Novanta e rinnovato nella breve era di Marco Tronchetti Provera. Telecom Italia non era più quella di prima e non lo sarebbe più stata. A quel punto si presentò l’opportunità di poter avere un socio industriale di calibro internazionale. Fu valutato così l’ingresso della spagnola Telefonica. Ma in breve si capì che dietro all’operazione manovravano le banche, preoccupate di non poter rientrare delle esposizioni accumulate da Telecom Italia nel corso degli anni di ridimensionamento. È questo il contesto in cui arrivò Vivendi, gruppo francese di prim’ordine, molto forte nel mercato delle televisioni, ma che paradossalmente, prima di entrare in Telecom Italia si era spogliato di ogni impegno nelle telecomunicazioni francesi. Si capì subito che all’interesse verso le telecomunicazioni italiane da parte di Vivendi (in un contesto che fremeva per la ormai prossima sovrapposizione di telecomunicazioni e televisione) era fortemente orientato a chiudere un accordo rilevante con il gruppo Mediaset di Berlusconi, da sempre oggetto di interesse da parte di Vivendi. La presenza di Vivendi in Telecom Italia non è stata facile
Dal 2015 non è riuscito ad avere un rapporto franco con il governo e ad un certo punto sembrava fosse in una tale condizione di isolamento da non dialogare né con la politica, né con le autorità di regolazione, né con l’Europa. Uno stato di isolamento senza precedenti per il vertice di un’azienda così rilevante ma posta in condizioni di criticità per effetto di due elementi pesanti come macigni e per i quali occorrerebbe invece dialogare con tutti:
a) un enorme debito (a fronte di un fatturato in costante contrazione),
b) una consistenza di personale non più sostenibile (circa 45 mila dipendenti, un numero troppo elevato per essere giustificato).
La nascita di Open Fiber e il Piano Banda Ultra Larga (BUL) del Governo Renzi
Qui si innesta il tema della rete unica.
Un tema che non nasce con il dibattito dell’ultimo anno, ma che affonda le sue radici nel lontano 2008, quando si cominciò a parlare della possibilità di unificare gli sforzi di investimento in un’unica infrastruttura.
Se ne parlò per anni, sino all’epoca del governo Renzi, con il premier che cercò di convincere Telecom Italia a cedere la rete, mantenendo i servizi. Vivendi non accennò neanche al dialogo, ancorché ad un avvio di possibile negoziazione.
Fu in quel contesto che nacque Open Fiber, un nuovo modello di operatore di telecomunicazioni connotato da due caratteristiche:
- costruire una rete esclusivamente in fibra ottica, con architettura FTTH (Fiber-to-the-Home, ovvero la fibra direttamente a casa del consumatore)
- operare con un modello “wholesale-only”, ovvero vendere l’accesso alla rete non ai clienti finali, ma agli operatori che a loro volta lo offrono al consumatore.
La nascita di Open Fiber scardina il modello preesistente delle telecomunicazioni italiane.
Open Fiber comincia a vincere le gare di assegnazione dei fondi destinati alla banda ultra larga, assegnati con il varo del Piano BUL (Banda Ultra Larga) da parte del governo di Matteo Renzi e così al vecchio rame comincia ad affiancarsi, in modo inarrestabile, la fibra ottica con tecnologia Fiber-to-the-Home (FTTH).
La scelta europea a favore degli operatori all’ingrosso (Wholesale-only)
Ma intanto stava cambiando anche il contesto europeo.
Nel dicembre 2018 entra in vigore il Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche che prevede un ruolo privilegiato per gli operatori “Wholesale-only” come Open Fiber.
Lo schema a cui l’Europa vuole giungere è chiaro: assicurare al continente nell’arco di pochi anni una copertura della rete in FTTH, ovvero al livello più avanzato di tecnologie.
Sorgono ovunque in Europa operatori “Wholesale-only” e diventa anche chiaro il contesto concorrenziale: evitare le competizioni infrastrutturali, affidarsi a un fornitore unico (appunto il “Wholesaler-only”) il compito di cablare e vendere l’accesso alla rete a tutti, evitando qualsiasi disparità di accesso.
Ma il modello “Wholesale-only” evita anche le incongruenze insostenibili di vendite all’ingrosso agli operatori concorrenti effettuate dagli incumbent, i vecchi monopolisti, che usano il doppio canale commerciale, vendendo banda ai concorrenti e poi facendo loro concorrenza presso il consumatore finale.
Open Fiber inizia a decollare, innanzitutto vincendo le gare e avvia la lunga marcia di cablatura del Paese con una moderna rete in fibra ottica sino a casa del consumatore (FTTH).
Il pronunciamento del Parlamento italiano
Nel dicembre 2018, il Parlamento italiano approva una mozione per una trasformazione della rete di telecomunicazioni connotata da tre caratteristiche:
- una rete unica,
- sotto il controllo pubblico,
- secondo il modello “Wholesale-only”.
Telecom Italia, intanto diventata TIM, avvia timidamente connessioni in tecnologia FTTH, ma si impegna massicciamente nelle connessioni FTTC (Fiber-to-the-Cabinet, ovvero l’armadietto di strada), che non viene considerata come connessioni in fibra dagli standard dell’Unione europea.
Gli effetti della pandemia mentre il governo Conte punta alla rete unica ma in capo a TIM, operatore verticalmente integrato, controllato dalla francese Vivendi e con il 75 per cento di azionisti esteri
Infine arriva la pandemia. La rete assume un ruolo ed una importanza che nessuno gli avrebbe riconosciuto sino a poco tempo prima.
Il mondo intero entra in difficoltà e tutte le nazioni, Europa compresa, corrono ai ripari, con iniziative di sostegno finanziario. A marzo 2020 l’Unione europea decide misure straordinarie per sostenere le economie nazionali più esposte. Si capisce subito che all’Italia spetta la fetta più ricca di prestiti dall’Unione europea.
Parte l’operazione “rete unica”.
L’assioma viene subito dichiarato e presentato come privo di qualunque alternativa ragionevole. Il mondo, si sostiene, sarà sempre più esposto a emergenze che interromperanno le attività e ci costringeranno a casa.
In un contesto del genere la rete diventa fondamentale per ogni attività. Quindi occorre avere una rete forte e valida, capace di affrontare emergenze del genere e per questa ragione appare del tutto fuori luogo immaginare una qualunque competizione infrastrutturale che disperderebbe energie.
Il disegno è chiaro, TIM dovrebbe inglobare Open Fiber, fare una rete unica e non disperdere investimenti.
Naturalmente il postulato non viene visto di buon occhio non solo da Open Fiber, quanto anche dagli altri operatori, in primis Vodafone, WindTre e Sky Italia (che è ormai diventato un operatore di telecomunicazioni a tutti gli effetti).
Ciononostante la macchina si è ormai mossa e sembra inarrestabile.
La rete unica può essere anche un ottimo affare. I miliardi del Recovery Fund serviranno infatti anche per costruire una rete moderna e se ci sarà una rete unica le assegnazioni delle risorse in arrivo saranno fatte a beneficio dell’unico soggetto in campo, quello che nascerà dalla fusione tra TIM e Open Fiber, o meglio dalla confluenza di quest’ultima in TIM.
Nella tarda primavera del 2020, l’atmosfera tra i parlamentari di tutti o quasi i gruppi politici è senza tentennamenti: “Ormai hanno deciso tutto e sono tutti d’accordo”. E si, perché nel sistema politico italiano la regola è proprio questa: “Se siamo tutti d’accordo, qualunque cosa si può fare e se a Bruxelles dicono che non rispettiamo le regole, diciamo che noi siamo tutti d’accordo e che non si discute null’altro”.
Eppure non erano tutti d’accordo. Il piccolo punto di disaccordo, rivelatosi poi decisivo, fu rappresentato da una mozione dell’on. Alessio Butti (Fratelli d’Italia), depositata nel settembre 2019, che ricalcava semplicemente quanto lo stesso Parlamento aveva approvato nel dicembre 2018: una rete unica, pubblica e “wholesale-only”. Al contrario, il resto o quasi del mondo politico era per una rete sì unica, ma non pubblica, perché nelle mani di TIM, società peraltro controllata da un principale azionista come Vivendi con il 24 per cento, e con il 75 per cento complessivamente in mano ad azionisti esteri.
In tal caso l’Italia avrebbe avuto una rete unica che avrebbe violato almeno due regole dell’Unione europea, trattandosi:
- di una rete unica costituita su basi monopolistiche (e non “wholesale-only”),
- in capo ad un operatore verticalmente integrato come TIM.
A luglio 2020, nonostante i tentativi di insabbiamento da parte della maggioranza, la mozione di Butti arrivò in Parlamento e fu oggetto di discussione per due giorni. Fu un’occasione di confronto aperto, che fece emergere posizioni differenziate nei partiti ed un chiaro invito alla riconsiderazione del problema da parte dello stesso Sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico Gian Paolo Manzella, che reclamò maggiore trasparenza e la necessità di un percorso parlamentare per un argomento così rilevante.
Intanto sui media l’argomento aveva conquistato da settimane le prime pagine dei giornali, con uscite pressoché quotidiane.
Nel frattempo si erano sempre fatte più forti le prese di posizioni e le stesse azioni del governo in favore della rete unica (il premier Giuseppe Conte ed il ministro al Ministero dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri, in primis).
Il forcing del secondo governo Conte
Agli inizi del mese di luglio del 2020, il ministro Gualtieri convocò d’urgenza l’Amministratore Delegato di ENEL, Francesco Starace, che non aveva fatto mistero di non credere per nulla alla rete unica, invitandolo a trovare una forma di accordo con TIM, per facilitare la confluenza rapida di Open Fiber in una rete unica in capo a TIM. Starace non diede seguito ad alcunché.
Quindi il gruppo promotore della rete unica dovette ricorrere ai ripari. E qui si registrò un atto del tutto irrituale. Nel corso del Consiglio di Amministrazione di TIM del 4 agosto 2020, il Consiglio venne interrotto da una telefonata del ministro Gualtieri.
La cornetta venne passata al premier Giuseppe Conte che chiese di interrompere ogni decisione, in attesa di iniziative del governo a favore della rete unica. Un atto irrituale e di dubbia liceità. Perché? Perché TIM è una società privata, quotata in Borsa e il governo non può intromettersi in affari che non lo riguardano. Naturalmente tutto ciò avvenne nel silenzio assoluto di media e osservatori, tranne rarissime eccezioni. E nel silenzio più assoluto di Consob, l’autorità che dovrebbe tutelare il risparmio degli italiani.
Il governo Conte decise allora di cambiar cavallo, puntando sull’iniziativa di Cassa Depositi e Prestiti, piuttosto che insistere nel sollecitare l’Amministratore Delegato di ENEL ad un improprio accordo con TIM (un accordo del genere poteva esser infatti previsto tra TIM e Open Fiber e non tra l’operatore di telecomunicazioni e uno solo dei due azionisti di Open Fiber).
In pochi giorni si cambiò rotta e a fine agosto 2020, TIM e Cassa Depositi e Prestiti sottoscrissero un Memorandum of Understanding finalizzato alla realizzazione della rete unica entro il primo trimestre 2021. E già, perché nel frattempo il governo diede lo sfratto ad ENEL da Open Fiber. Si cercarono velocemente acquirenti per il passaggio di quota e si fece avanti il fondo australiano Macquarie, già impegnato in altre importanti partite in Italia. A dicembre venne infine deciso il via libera di ENEL alla cessione a favore di Macquarie.
Il resto è cronaca di queste ultime settimane.
La caduta del governo 5S-PD spezza i giochi. Tutto si ferma in attesa del nuovo governo.
L’allineamento del governo Draghi alle regole di competizione dell’Unione Europea
Con l’insediamento di Mario Draghi è tutta un’altra musica. Viene riaffermato il principio dell’allineamento dell’Italia alle regole di competizione dell’Unione europea. La rete unica, così come era stata pensata, vacilla prima e poi si inceppa. Anche per effetto di una campagna di controinformazione sul tema in contrasto alla narrativa sostenuta dalle principali testate nazionali, che non hanno mai espresso alcun dubbio sulla plausibilità del progetto in capo a TIM.
Intanto va a maturazione l’accordo di cessione della quota ENEL in Open Fiber e tutto procede come da copione: ENEL venderà a Macquarie il 40 per cento e cederà il restante 10 per cento della sua quota del 50 per cento in Open Fiber a Cassa Depositi e Prestiti (CDP). La ripartizione proprietaria della Open Fiber del futuro sarà pertanto divisa al 60 per cento e al 40 per cento tra CDP e Macquarie.
Il nuovo governo a guida Draghi mette intanto mano al PNRR, il cui testo è stato consegnato all’Unione europea il 30 aprile 2021. La stesura del Piano, nella parte relativa alla rete, non manca di esplicitare chiari riferimenti alle esigenze di concorrenza che devono caratterizzare il settore, in linea con le indicazioni di Bruxelles.
In corso di stesura del PNRR, nella versione curata dal nuovo governo, si chiarisce anche, dietro le quinte ed informalmente, che non un centesimo può andare alle aziende per assegnazione diretta. Tutte le assegnazioni si faranno rigorosamente con appositi bandi di gara europei. Quindi anche la rete non si sottrarrà a questa regola. Uno stop alle aspettative di mesi che puntavano sulle possibilità irrinunciabili di un Eldorado a favore del titolare della appena costituita rete unica.
Ma non è l’unico stop. Ora si intravedono anche le circostanze previste per l’immediato futuro.
Il governo dovrà fare la mappatura delle cosiddette “Aree Grigie”, escludendo le aree in cui gli operatori dichiareranno di essere disponibili ad investire. Per tutte le altre il governo dovrà emanare i bandi di gara. E chi concorrerà dovrà sottostare alle regole dei bandi europei, che per definizione assegnano un punteggio privilegiato ai concorrenti che siano “Wholesale-only” come Open Fiber.
Il che vuol dire che non ci sarà pressoché storia. Quasi tutte le aree messe a gara saranno prevedibilmente assegnate a Open Fiber. Il che vorrà dire che entro il 2026, ovvero con un anticipo di quattro anni rispetto allo scadenzario che l’Unione Europea ha dato per l’Europa, l’Italia disporrà di una rete ultra moderna con connessioni FTTH e integrazioni in FWA e 5G-FWA su sostanzialmente l’intero Paese.
L’impostura della rete unica: una storia politicamente chiusa. Le decisioni si spostano a Bruxelles, ma in Italia lo scontro continuerà.
A questo punto il tema della rete unica sembra definitivamente accantonato, ma questo non vuol dire che non accadrà nulla di controverso.
Continuerà prevedibilmente la campagna stampa e continuerà lo scontro dei campi avversi, che non sono solo due aziende di telecomunicazioni.
Dietro TIM c’è uno schieramento che è ben più rilevante delle gesta del suo amministratore delegato. Certo si possono fare solo supposizioni. Ma di sicuro continuano a essere a favore della rete unica in capo a TIM apparati bancari italiani, che si trovano fortemente esposti nei confronti di TIM, e con essi sono facilmente rintracciabili interessi legati al principale azionista che è Vivendi.
La Francia sta giocando da anni una partita geopolitica di predominanza sull’Italia, certo non solo per la conquista del polo della distribuzione alimentare (oggi in mano a Carrefour e Auchan), ma per battaglie ben più rilevanti che riguardano il controllo di importanti soggetti di mercato, da Generali a Mediobanca. La partita della rete è quindi una partita ben più ampia di quanto non appaia.
E sul versante opposto avremo uno schieramento fatto da coloro che tengono ad una rete pubblica sotto il controllo nazionale, come avviene per tutte le altre infrastrutture critiche del Paese. E come avviene in tutti i Paesi europei.
Di questo schieramento non fa parte il governo nel suo complesso, ma solo una parte di esso. E si, perché le spaccature tra schieramenti sembra essere il motivo ricorrente che accompagna le prese di posizione sulla rete unica.
Si registrano sul tema vistose spaccature in seno ai partiti, particolarmente nel Partito Democratico (che ha rinunciato a prendere pubblica posizione per evitare di doversi spaccare in pubblico) e nel Movimento5Stelle (dove coesistono i proclami a favore della presenza pubblica, ma con un leader, Conte, che è stato uno dei principali artefici del progetto rete unica in capo a TIM).
Vi è poi una forte spaccatura tra maggioranza nel suo complesso e opposizione (il partito di Giorgia Meloni ha mantenuto coerentemente la stessa posizione in tutta la vicenda) ed una sostanziale spaccatura anche in seno al governo, con Draghi e una parte del governo da una parte e un’altra parte del governo con posizioni opposte.
Ciò che più conta, e di cui si ha oggi piena consapevolezza, è che ogni decisione verrà posta nelle mani di Bruxelles. Sarà la Commissione Europea che dovrà valutare la cessione della quota ENEL a Macquarie e dell’altra quota a CDP. Poi non è escluso che la Commissione si debba esprimere anche su altre operazioni oggi al vaglio delle autorità nazionali, come quelle relative a Fiber Cop. Ma non abbiamo dubbi sul fatto che la Commissione Europea sceglierà per il meglio, con l’obiettivo di difendere e tutelare la concorrenza tra imprese e i diritti dei consumatori.
La partita, in sostanza, è politicamente chiusa, ma gli schieramenti avversi sono ancora sul campo di battaglia e c’è da giurarci sul fatto che continueranno a darsele di santa ragione ancora per alcuni mesi.