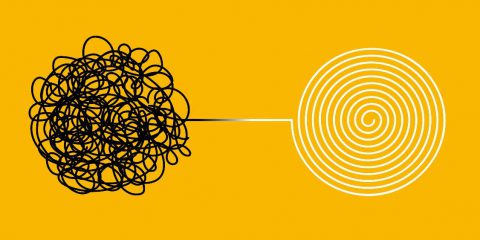Il dossier sugli Stati Uniti si conclude con un confronto a più voci “Cinque domande sul futuro degli Stati Uniti d’America” rivolte da Bruno Somalvico ad alcuni amici colleghi ed esperti collaboratori di Democrazia Futura alle quali hanno risposto Massimo de Angelis, Antonio Di Bella, Giampiero Gramaglia, Erik Lambert, Giacomo Mazzone, Andrea Melodia, Gianfranco Pasquino, Carlo Rognoni e il giornalista e massmediologo italo americano Dom Serafini, che ringraziamo vivamente. Ne emerge un quadro di giudizi molto articolato, con diverse interpretazioni relative ai cinque argomenti affrontati, inerenti alla crescita del divario fra élite e popolo, la natura particolare del sistema elettorale statunitense, l’impatto della globalizzazione sul centro e sulle periferie, il presunto venir meno di alcuni principi fondamentali e le conseguenze della “marcetta sul Campidoglio” sulla società americana dei prossimi anni. Qualunque siano le risposte sui singoli punti, tutti sembrano confermare che la crisi che investe gli Stati Uniti d’America confermi la sua profonda spaccatura in due, mantenendo sullo sfondo quello spettro di una guerra civile che 156 anni dopo la fine della guerra di secessione conclusasi nel 1865, non è mai stato completamente debellato e come tale sembrerebbe destinato a rimanere intatto nelle coscienze dei cittadini statunitensi ancora per molto tempo.
Domanda. La crescita del divario fra élite e popolo favorita anche dal ruolo rivestito dalla comunicazione virale nei social media va vista dopo il voto del 3 novembre come una crisi di crescita della democrazia e di partecipazione ai suoi riti anche da parte di chi non appartiene all’establishment tradizionale, o come un mero moltiplicatore delle fratture in atto prodotte anche dalla frammentazione della sfera pubblica e dalle post verità?
Massimo De Angelis
Sta crescendo senz’altro una frattura tra élite e popolo. Essa ha profonde origini economiche, sociali e culturali. Non c’è dubbio che è fondamentale il ruolo dei grandi gruppi Agfa che condizionano pesantemente il modello di sviluppo dell’attuale cosiddetto turbocapitalismo. Basti pensare allo stravolgimento del commercio prodotto da Amazon o quello produttivo dovuto a Google. Sul piano della formazione economico sociale questo ha prodotto la crisi dei colletti blu che ha responsabili: innanzitutto Clinton e la sua apertura del Wto che ha consentito a paesi come la Cina di invadere i mercati occidentali potendo comprimere a volontà il costo del lavoro e la vita dei lavoratori occidentali. Sul piano socioculturale una immigrazione fuori controllo e il trionfo del politically correct non ha portato a una evoluzione dei costumi ma a un loro stravolgimento. La causa è soprattutto nella rapidità e perentorietà per nulla dialogica dei processi informativi-culturali imposte dalla élite. alla base del fenomeno. Basti pensare alla gabbia crescentemente autoritaria del politically correct. La loro è una linea che trascura totalmente quella che si può definire ecologia umana e sociale. Si aggiunga infine che in tutto ciò i mass media appaiono per lo più il megafono dell’establishment piuttosto che della gente e quindi non vengono più ascoltati. In conclusione, assistiamo, da un lato, ad una precarizzazione cre scente, ad un’anomia culturale (come scriveva Antonio Negri la trasformazione del popolo in una moltitudine nomade), dall’altro a una voglia anch’essa crescente di omologare le masse attraverso una comunicazione unidimensionale; dall’altro ancora, per contraccolpo, a una radicalizzazione anche in questo caso sempre più crescente, che giunge sino alle tristi forme di suprematismo, rovescio della medaglia grottesco del politically correct. In tutto ciò i social sono a un tempo luogo della comunicazione più becera ma anche presidio della libertà contro la spinta a una tirannia della maggioranza direbbe Alexis de Tocqueville che è poi in realtà tirannia di élite relativamente ristrette.
Antonio Di Bella
I recenti fatti americani approfondiscono a mio modo di vedere la separazione fra élite e popolo. La decodificazione degli avvenimenti politici ed economici che fino a oggi era assegnata al sistema dei media è un meccanismo che ha perso affidabilità da parte di ampi strati della popolazione. Donald Trump ha etichettato come nemici tutti i principali organi di informazione, dalla carta stampata alle televisioni. Il suo è un processo di disintermediazione portato all’estremo nel quale si rivolgeva direttamente ai suoi lettori attraverso i social media. Processo che si è interrotto bruscamente quando è stato espulso da Twitter e dagli altri social per porre freno al numero di menzogne propagate dall’ex presidente. Nel grande pubblico degli elettori e dei fedeli di Trump tutto quello che scrivono i giornali e le televisioni – definiti mainstream – è falso. E’ molto difficile e ci vorrà molto tempo prima che il sistema dei media riconquisti la fiducia del grande pubblico.
Giampiero Gramaglia
Non sono sicuro che quanto avviene negli Stati Uniti, e non solo, rifletta una crescita del divario fra “élite” e “popolo”. Penso, piuttosto, che il crinale sia fra “informati” e “disinformati”, dove i secondi una volta erano consci di esserlo, mentre adesso si credono informati perché nutriti dall’informazione online ‘acchiappa allocchi’, che spesso ne coltiva le frustrazioni e ne lusinga le ambizioni, livori più che ardori. Certo, i due spartiacque spesso corrono paralleli, quando non si sovrappongono; e sono stati resi più netti dall’aggravarsi delle diseguaglianze per effetto della globalizzazione. E non sono neppure sicuro che stiamo assistendo a una crescita della democrazia: la farneticazione sui social sta all’affabulazione della democrazia come la superstizione sta alla religione, ci sono punti di contatti, ma non sono la stessa cosa. Forse, però, è il caos primordiale di ogni rivoluzione, di cui poi resta qualcosa di positivo: la Rivoluzione francese moltiplicò i giornali e le decapitazioni, ma gettò i germi di società democratiche e solidali.
Giacomo Mazzone
Non credo si sia in presenza di un divario élite-popolo, secondo i canoni classici della storiografia. Penso invece che si stia assistendo alle conseguenze combinate di digitalizzazione e di globalizzazione, che stanno portando alla distruzione della classe media negli Stati Uniti. Un fenomeno globale certo, ma che negli USA – in assenza degli ammortizzatori sociali del welfare europeo e degli ammortizzatori propri dei paesi in via di sviluppo (famiglia, comunità, tribù) e in presenza di un’economia fortemente “connessa” – assume proporzioni gigantesche. Nel capitalismo digitale, la linea di comando sociale ed economica è cortissima e non ha bisogno di tanti livelli intermedi: l’intelligenza artificiale sostituisce la classe media. Cosi come nell’economia digitale il vincitore in un settore tende a prendere tutto il mercato, non più ad essere il primo di un gruppo di soggetti più o meno comparabili. La pauperizzazione della classe media, la rottura della promessa d’integrazione, del contratto sociale statunitense e perfino dell’american dream mettono ai margini della società un numero crescente di cittadini. Rabbiosi perché sono consapevoli di cosa hanno perso, ma anche manipolabili perché non sanno perché l’hanno perso, né per colpa di chi l’hanno perso. I social media sono lo strumento privilegiato di questi soggetti emarginati e svolgono lo stesso ruolo che le “dicerie dell’untore” svolgevano in altre epoche prerivoluzionarie. Ma oggi come allora è facile per chi voglia soffiare sul fuoco orientare la rabbia verso nemici immaginari ma plausibili. La rilettura di due opere come il 1984 di George Orwell e La rumeur d’Orléans di Edgar Morin è fortemente consigliata.
Andrea Melodia
Non credo che si tratti di spiegazioni alternative dei fenomeni in corso. Il divario tra élite e popolo deriva, credo, dal maggiore accesso a informazioni di ogni genere da parte di una popolazione che, anche per colpa della difficoltà nell’adattarsi al cambiamento da parte dell’istituzione scolastica, non ha avuto modo di maturare strumenti di analisi sufficienti alla complessità scientifica e a quella sociale. Incapaci di gestire il dubbio e di esercitare il successivo discernimento, si va alla ricerca di certezze introvabili e ci si imbatte nella identificazione di un nemico da abbattere. L’evoluzione tecnologica è avvenuta troppo in fretta, tutto il resto è in ritardo. Anche i media mainstream sono stati abbandonati a sé stessi invece di fare formazione degli adulti. Le élite hanno la responsabilità di questa e altre distrazioni, tra cui una gestione del sistema finanziario che fa a pugni con il senso del reale, penalizza la gestione etica delle imprese e premia furbizia, immoralità e corruzione. Siamo in una fase di transizione nella quale la democrazia ha corso e correrà rischi gravi, ma mi pare che qualche forma di consapevolezza stia maturando: in fondo i sovranisti stanno annaspando, in Europa come in America.
Gianfranco Pasquino
Difficile dire con certezza che il divario fra élite e popolo sia cresciuto Certamente sono cresciute le diseguaglianze economiche e si stanno accentuando quelle sociali e culturali. Però, non è una crisi di “crescita” della democrazia. Ė un segnale potentissimo con radici profonde negli Stati Uniti, mai una democrazia orientata all’eguaglianza. Fortemente competitiva, piuttosto meritocratica, non sufficientemente desiderosa né capace di garantire opportunità, gli USA hanno, solo in parte, però, preso atto di problemi che non sanno risolvere. Lo dirò così, seccamente: un Afro-Americano alla Casa Bianca per otto anni e gli Afro-Americani vivono in una delle peggiori fasi della loro storia. Black Lives Do not Matter. C’è moltissimo da fare.
Carlo Rognoni
C’era una volta l’America”: è uno dei titoli de La Stampa all’indomani dell’assalto di alcune centinaia di energumeni della destra americana al Congresso, assalto incoraggiato e benedetto da Donald Trump. Ho trovato questo titolo a nove colonne il più azzeccato per almeno due motivi: prima di tutto coglieva in sintesi il grandissimo cambiamento prodotto dall’amministrazione Trump sulla democrazia degli Stati Uniti; e poi raccontava di un mondo che credevo di conoscere, che ho conosciuto e che mi sembrava essere stato tradito. Ho vissuto due anni in America tra un College della Pennsylvania e alcuni giornali di New York, in cui ho fatto pratica giornalistica. Ero convinto che nulla avrebbe potuto scalfire la solidità della democrazia americana. E dunque quello che è accaduto con l’assalto al Congresso mi ha colto del tutto impreparato. Mi ha profondamente sconcertato. Per un anno ho vissuto in una famiglia repubblicana, gente perbene, seria, autenticamente democratica. Diversi da noi europei? Si, certo. E tuttavia invidiabili per le profonde convinzioni democratiche che li animavano. Sulla storia delle élite c’è un bellissimo libro di David Rothkopf intitolato Superclass, che secondo Joseph Stiglitz, premio Nobel per l’economia, è “un’appassionante e rigorosa analisi della ricchezza e del potere che decidono la politica internazionale e l’economia del mondo in cui viviamo”. Quello a cui abbiamo assistito non mi sembra proprio un esempio della crisi di crescita della democrazia e della partecipazione ai suoi riti. E’ figlio della comunicazione virale nei social media? Anche. Ma soprattutto a me sembra il segno più drammatico della crisi della politica. La debolezza dei partiti, la frammentazione, il prevalere della post verità, la debolezza del sistema scolastico.
Dom Serafini
La crisi va vista analizzando diversi elementi: la perdita dell’elettorato dei colletti blu da parte del Partito Democratico che si è spostato troppo a sinistra. La radicalizzazione del Partito Repubblicano che ha preso i centristi e fatto aumentare il supporto degli estremisti. La globalizzazione che ha tolto posti di lavoro in fabbrica a persone non messe in grado di reinventarsi con altri impieghi. Nonostante tutto, la democrazia ha retto anche al tentativo di colpo di stato. Ora i democratici devono comunicare con un linguaggio comprensibile agli elettori centristi che rappresentano il 70 percento dell’elettorato statunitense. Esempio: la maggior parte degli elettori non conosce il significato di “socialismo”, pertanto lo vedono come un pericolo, senza che si rendano conto che “Social Security” (pensione federale universale) e “Medicare” (assistenza sanitaria federale universale per i pensionati) non sono altro che forme di socialismo e guai a chi le tocca!
Domanda. Il sistema elettorale statunitense tiene? O il lungo e complesso meccanismo che porta all’elezione (selezione dei candidati nelle primarie, successiva scelta fra i candidati in due tappe: elezione a suffragio universale dei grandi elettori rappresentanti dei singoli stati e infine elezione del presidente da un collegio elettorale ristretto) necessita di qualche modifica? Per evitare lo strappo di Trump che aizza i propri elettori prima contro il simbolo dell’establishment Hillary Clinton poi contro i brogli elettorali va cambiato qualcosa?
Massimo De Angelis
Gli Stati Uniti sono uno Stato federale che come tale non può che inviare al Congresso i rappresentanti dei singoli Stati. Mi sembra assai più funzionale e democratico di quello della Unione europea. Mi pare che, complice anche il Covid-19, siano nati problemi riguardanti la formazione delle commissioni scrutatori amplificate dalla massa abnorme di voto postale provocato anche dal Covid-19. Credo che il sistema abbia bisogno di essere riformato a questo livello e, volendo, non dovrebbe essere cosa troppo complicata.
Antonio Di Bella
A mio parere il criticato sistema elettorale americano è in realtà riuscito a sopportare uno dei più difficili momenti della sua storia. Il sistema di controlli incrociati a livello locale federale messo a dura prova dalle pressioni anche i legali della presidenza Trump ha sostanzialmente retto grazie in particolare a degli onesti funzionari repubblicani che hanno anteposto il valore della costituzione alla spinta del proprio capo partito.
Giampiero Gramaglia
E’ inutile porsi la questione, perché il sistema elettorale degli Stati Uniti non sarà modificato, nel breve tempo. Può però darsi che esso modifichi il panorama politico: la sconfitta di Donald Trump conferma che i repubblicani sono ormai minoranza nel Paese, anche quando fanno il pieno dei voti di ‘rednecks’ e fondamentalisti, suprematisti e razzisti, oltre che degli ‘anti-governo’ ex Tea Party – tutte ‘constituencies’ fuori dal solco di Abramo Lincoln -. Nelle otto elezioni presidenziali svoltesi dal 1992, i repubblicani sono stati maggioranza una sola volta, nel 2004 – e ci volle l’11 Settembre perché ci riuscissero -, pur avendo conquistato la presidenza tre volte. Può darsi che questo li induca a darsi assetti e/o posizionamenti diversi; o può darsi che un’osmosi dei voti degli ispanici dai progressisti ai conservatori riequilibri il quadro. E, comunque, l’ancoraggio federale del sistema elettorale statunitense è, a mio avviso, un dato positivo.
Giacomo Mazzone
Non essendo un esperto di sistemi elettorali, ma di media, mi limito ad una sola constatazione. Il potere dei social media di influenzare un’elezione in maniera determinante esiste solo dove il risultato si decide per un pugno di voti (come nel caso degli swinging states) e dove the First past the post, cioè dove chi vince prende tutto (come nel caso dei grandi elettori). L’attuale sistema elettorale statunitense presenta entrambe queste caratteristiche e quindi, per sua natura, se non verrà modificato, resterà esposto al rischio di manipolazioni via social media. Forse sarà questo aspetto ad essere regolato, prima ancora di riformare il sistema elettorale.
Andrea Melodia
Il sistema elettorale americano risale all’epopea western, diligenze e treni a vapore. Funziona come allora, almeno per la parte relativa ai rapporti tra Stati e Unione. Fa perdere tempo, ma nel complesso non mi pare sia crollato e trovo improbabile che venga modificato a breve. A ben vedere una modifica non da poco c’è stata, negli Stati, con il voto postale e quello elettronico.
Gianfranco Pasquino
Il problema si chiama voter suppression e ricomprende sia tutte le modalità usate dalle maggioranze repubblicane negli Stati e nella Corte Suprema per rendere difficile/impossibile agli Afro-Americani e ai Latinos il semplice esercizio del diritto di voto sia le odiose pratiche del gerrymandering. Però, qui è anche il caso di sottolineare che negli Stati Uniti a differenza di qualsiasi altra democrazia al mondo, il denaro influenza in maniera potentissima tutti i procedimenti elettorali, prima, e tutte le politiche pubbliche, dopo. Grazie alla sentenza della Corte Suprema del 21 gennaio 2010 “Citizens United versus Federal Election Commission” il potere dei grandi ricchi è stato istituzionalizzato in maniera devastante
Carlo Rognoni
Anche gli Stati Uniti hanno bisogno di un ripensamento e di un cambiamento dei meccanismi istituzionali. Non solo l’Italia. Il sistema elettorale americano – così come il sistema italiano – mostra tutte le sue contraddizioni e incapacità di mettere in campo governi duraturi e capaci realmente di interpretare la realtà, che con la rivoluzione digitale, con l’intelligenza artificiale, sta cambiando.
Dom Serafini
In quest’ultimo caso dell’elezione di Biden dobbiamo osservare come il presidente abbia vinto sia con i voti popolari sia con quelli dei grandi elettori. Cosa che non era successo a Donald Trump nel 2016 quando aveva vinto solo grazie ai voti dei grandi elettori. Quindi il sistema può funzionare, ma rimane sempre un “se”, che potrebbe essere eliminato togliendo i grandi elettori. Per evitare che gli stati più popolosi creino una democrazia a svantaggio delle minoranze, disponiamo di una protezione. Quella assicurata dall’elezione indistintamente di due senatori per ogni stato, indipendentemente dal numero di abitanti.
Domanda. Gli effetti della globalizzazione sul ridisegno del centro e delle periferie degli Stati Uniti d’America. Che responsabilità rivestono le nuove élite tecnologico tecnocratiche che controllano le piattaforme nel favorire la frammentazione dell’opinione pubblica e la reazione sovranista di ceti medi e rurali sempre più emarginati e soggetti a fenomeni di pauperizzazione?
Massimo De Angelis
Il problema non è la divaricazione tra ceti rurali impoveriti e urbani più benestanti. La maggiore miseria è concentrata nelle grandi città dove vincono i progressisti. La frattura città campagna che ha radici antiche è soprattutto culturale (come ad esempio anche in Francia o Gran Bretagna) e andrebbe governata con equilibrio e non parteggiando per l’una o per l’altra o tentando di uniformare forzosamente l’una all’altra. Come dicevo il problema principale è in un modello di sviluppo guidato dai grandi gruppi e legato alla globalizzazione che sta desertificando (deominizzando) aree crescenti del pianeta, anche nei Paesi più sviluppati.
Antonio Di Bella
Certamente il sogno di una globalizzazione economica portatrice di effetti solamente positivi è svanito… E i leader democratici in America in tutto il mondo devono sicuramente fare autocritica per non avere previsto o per avere sottovalutato gli effetti negativi di questo processo di delocalizzare e produrre in luoghi del pianeta dove il costo del lavoro è irrisorio ha fatto impennare i profitti di molte grandi aziende e altresì vero che ampi strati della popolazione meno abbiente in seno alle civiltà industrializzate ha pagato un duro prezzo. La complicità delle élite politiche con quelli che spesso sono grandi finanziatori e sicuramente un tema ineludibile.
Giampiero Gramaglia
Credo che quelle che vengono definite nella domanda “le nuove élites tecnologico-tecnocratiche che controllano le piattaforme” si pongano un solo obiettivo: fare soldi. Che questo passi attraverso la polverizzazione della verità, la frammentazione dell’opinione pubblica, i fermenti sovranisti o – magari – le chimere utopiche della democrazia partecipata non gliene importa nulla: certo, una volta che sono diventati così ricchi che di più neppure serve, Bill Gates, Jack Dorsey e persino l’egocentrico Mark Zuckerberg possono concedersi esami di coscienza, ma i loro azionisti continueranno a reclamare profitti.
Erik Lambert
Non sono in gioco né le nuove élite né la globalizzazione nella trasformazione del dibattito pubblico attraverso i social: ci sono le vecchie élite (quelle che Trump denunciava come il “deep state”) e un effetto boomerang. Come lo ricordavano Jack Goldsmith (ex Assistant Attorney General sotto George W. Bush) e Andrew Woods (professore di diritto alla University of Arizona, specialista della cybersecurity) in un articolo molto apprezzato in The Atlantic (“Internet Speech Will Never Go Back to Normal”), già dagli anni Novanta il governo degli Stati Uniti (o meglio lo State Department in primis) hanno concorso alla non-regolazione e alla promozione di una “libertà d’espressione all’americana”, intese entrambe come elementi fondamentali di Internet. Questa politica ha come fondamento l’idea che gli Stati autoritari siano destinati a crollare una volta confrontati con piattaforme digitali portatrici dei valori americani e come tali destinate a promuovere rivoluzioni democratiche in tutto il mondo. Successivamente, al contrario, abbiamo potuto constatare l’esistenza di un effetto-boomerang: questi valori tanto auspicati non erano per nulla intrinseci alla tecnologia. Quella che avrebbe dovuto essere una rivoluzione democratica, anche negli Stati Uniti è diventata una rivoluzione populista e demagogica.
Giacomo Mazzone
Con il Millennium Act due democratici, Al Gore e Bill Clinton, hanno posto le basi per un rinascimento americano, portando di nuovo imprese statunitensi a divenire campioni mondiali. Questo è avvenuto ampliando la giurisdizione USA a tutto il mondo attraverso Internet, e mettendo da parte rispetto dei diritti umani e regole antitrust (divenute obsolete davanti all’economia digitale). Ciò ha consentito a questi nuovi campioni globali di crescere a dismisura nel mondo, ma anche di distruggere il tessuto connettivo del paese che li ha allevati e fatti crescere. Il problema del break-up ovvero dello smembramento dei giganti di Internet si porrà negli USA con forza crescente, cosi come si pose nel XIX secolo coi monopoli dell’acciaio, del petrolio e nel XX con quelli delle telecomunicazioni.
Andrea Melodia
La colpa soggettiva maggiore dei social media è quella di voler guadagnare troppo. Oggettivamente devono essere regolati a livello globale e comunque trovo giusto che stiano provando a farlo da soli, visto che nessuno ha il coraggio di farlo come si dovrebbe. Spero che l’Europa possa svolgere un ruolo di suasion forte sugli Stati Uniti per arrivare a una regolamentazione. Credo sia un problema grave quanto quello della privacy e del prelievo fiscale sui loro guadagni.
Gianfranco Pasquino
L’opinione pubblica si frammenta da sé. Solo le società molto tradizionali sono relativamente coese o forzosamente compattate. Le opinioni pubbliche contemporanee sono “naturalmente” frammentate. Neanche le élite tecnologico tecnocratiche sanno come dominarle e nessuno sa come ricomporle. Qualcuno pensa che le opinioni pubbliche scomposte sono più manipolabili. Non ne sarei sicuro. Quelli che vivono nel Wyoming non si fanno influenzare da quelli che vivono nel Bronx e quelli di Affrico la pensano molto diversamente da quelli di Zagarolo.
Carlo Rognoni
Le nuove élite tecnologico tecnocratiche si stanno impossessando dei nostri pensieri, stanno condizionando il nostro agire quotidiano, e tutte le democrazie occidentali hanno bisogno di riscoprire il dovere di interventi equilibrati ma sapienti. Qualche tempo fa – ispirandomi dalla lettura di un libretto di Michele Mezza – mi è capitato di scrivere: “La macchina capitalistica non è fatta di ferro e sudore, ma di calcoli e di saperi … uno spettro si aggira per il mondo, il non partito. E di conseguenza la non democrazia e anche la non politica. Il linguaggio di questa nuova storia è l’informazione.Il modello del partito al tempo della rete è “un partito momentaneo”. E un partito momentaneo è un’organizzazione che orchestra le differenze per creare occasionali masse critiche. Si sbriciolano le identità di massa e si affermano pulviscolari istinti individuali. Oggi non è la catena di montaggio l’emblema della produzione sociale quanto la portabilità delle relazioni sociali veicolate e ordinate dallo smartphone”.
Dom Serafini
Naturalmente, la globalizzazione, i paradisi fiscali e la lotta contro le mancata responsabilizzazione dei vertici delle banche (tutti elementi che concorrono a ridurre i posti di lavoro e gli introiti fiscali) contribuiranno a ridisegnare profondamente gli Stati Uniti, sul piano sociale e politico. Per quanto riguarda la frammentazione, questa potrebbe essere ridotta responsabilizzando le singole imprese in modo che non facciano pubblicità su queste piattaforme, e scoraggiando le piattaforme ad accettare pubblicità da imprese che finanziano gli estremisti. E gli esempi non mancano.
Domanda. Vengono meno i principi fondamentali che hanno funto da collante per gli Stati Uniti? E’ finito anche dopo il melting pot anche il salade bowl, ovvero il piatto comune che teneva insieme la società multirazziale in nome dei principi jefferssoniani?. O vengono meno solo i valori politicamente corretti dell’era obamiana?. No, we can’t.
Massimo De Angelis
Proseguendo il discorso l’attuale modello di sviluppo mondiale è impietoso nel produrre una crescente deominizzazione e distruzione sociale soprattutto nelle aree del mondo più deboli. Lo vediamo in Sud America e in Asia ma qualcosa di almeno altrettanto tragico immagino avvenga in Africa dove i nostri occhi poco vedono. L’effetto è una spinta drammatica a migrazioni sempre più socialmente insostenibili. Con grave sofferenza naturalmente di chi deve migrare, sradicato come una pianta dalla propria terra senza sapere se ne troverà un’altra dove piantare radici, ma producendo inquietudine e sofferenza anche in quelle popolazioni chiamate ad accogliere (specie in quelle più deboli e quindi costrette a convivere in prima persona negli stessi quartieri e luoghi spesso con gravi problemi di integrazione culturale, di sicurezza, di tutela dell’occupazione).
La linea umanitaria è senz’altro fondata e in certo senso deve costituire il punto di partenza purché si sia ben avvertiti che il sostegno indiscriminato all’immigrazione oltre che da gruppi criminali locali è prodotto proprio dalla logica dei grandi gruppi capitalistici mondiali che hanno interesse a concentrare le moltitudini e a desertificare socialmente luoghi per poter procedere allo sfruttamento delle risorse naturali. (penso in particolare all’Africa subsahariana e aal’Amazzonia). Cruciale è dunque una politica di controllo dell’immigrazione che è stata negli ultimi decenni abbandonata. Si aggiunga a proposito del melting pot che, come notava già decenni fa Samuel Huntington, è cambiato un carattere fondamentale dell’immigrazione. Prima un afghano che emigrava negli Usa tagliava tutti i ponti con la madrepatria e quindi l’integrazione era un processo sicuro e irreversibile. Oggi può parlare tutti i giorni con parenti e amici in Afghanistan e può tornare lì anche tutti gli anni. Questo cambia tutto. Last but not least anche dal punto di vista del terrorismo.
Antonio Di Bella
Certamente c’è un vento impetuoso di ampie fette di popolazione stanca della correttezza politica fine a sé stessa. Quello che teme un’ampia fetta della popolazione che ha votato Donald Trump è una sorta di egemonia culturale e addirittura etica che stabilisce a priori ciò che è corretto e che espelle sostanzialmente dal dibattito del paese chi non è d’accordo con questi principi. E’ un conflitto delicato e problematico ma che non può essere ignorato
Giampiero Gramaglia
Tre americani su quattro (e nove elettori di Trump su dieci) non hanno gli strumenti lessicali e culturali per capire questa domanda, che potrebbe giusto giusto accendere dibattiti nella Manhattan di Woody Allen: formule come ‘melting pot’ e ‘salade bowl’ e riferimenti ai ‘principi jeffersoniani’ sono concetti che, al solo esprimerli, ci riconducono al ‘divide’ fra “informati e disinformati”.
Come fa sorridere chi leggeva nella presidenza Trump la “democrazia jacksoniana”, quasi che dietro le decisioni del magnate ci fosse una elaborazione ideologica.
Giacomo Mazzone
In un’economia dove l’ascensore sociale si è rotto, l’integrazione non può più funzionare, e chi è rimasto intrappolato ai piani bassi, prima o poi muoverà all’assalto di chi, in assenza dell’ascensore, torna a casa usando l’elicottero. Ricostruire una classe media, usando l’intelligenza artificiale per distribuire ricchezza sociale (e non per creare profitti esentasse estero-su-estero), è possibile. C’è solo bisogno di una volontà politica forte in questo senso. Se mancherà il coraggio di farlo, ci penserà prima o poi la rivolta sociale. E’ solo questione di tempo.
Andrea Melodia
Questo è un problema enorme, occorre passare dal politically correct normativo o di moda alla interiorizzazione dei valori fondamentali di uguaglianza. Credo che a lungo andare ci si arriverà. Certo è più facile farlo con i newyorkesi che con gli allevatori del dairy belt, il problema è sempre quello delle fonti di informazione.
Gianfranco Pasquino
Quei principi fondamentali vanno riesaminati, ripensati, ridefiniti. Non saprei più a chi attribuire la lenta sovversione di quei principi, ma certo i Democratici del Sud sono stati molto influenti e alcuni presidenti repubblicani a partire da Reagan hanno fatto del loro peggio. Credo che sia sempre possibile cambiare e migliorare. La questione è quanto tempo e quali costi e soprattutto chi. Yes, some of us will.
Carlo Rognoni
Melting pot e salad bowl resteranno – nonostante tutto – i punti di forza, le caratteristiche indiscutibili dell’America, anche di quei 74 milioni di americani che hanno votato Trump per la seconda volta. Nel giorno dell’insediamento del nuovo presidente Joe Biden ne abbiamo avuto una conferma. Bianchi, neri e gialli sono una presenza forte, sono una carta di identità dell’America migliore.
Dom Serafini
Il vantaggio che offre l’America (a differenza dell’Europa) è che quando, ad esempio, arriva un emigrato dall’America Latina, “José” diventa subito “Joe” e “Juan” diventa “John”, tanta è la voglia di integrarsi al più presto possibile. Aiuta anche un sistema giuridico che tende a non tollerare atteggiamenti giustificati dalle usanze delle proprie etnie di provenienza. Ad esempio, un autista immigrato quando investe un pedone non può giustificarsi dietro al fatto che nel suo paese non vi siano né i semafori né le strisce pedonali.
Domanda. La “marcetta sul Campidoglio” – come è stata definita in un commento su una testata televisiva nazionale italiana – e il suprematismo bianco sono un fenomeno marginale tragicomico a sostegno di un uomo ridicolo o una tragedia shakesperiana di una società americana che non ha ancora elaborato il lutto dell’11 settembre? E che non accetta di condividere le regole della globalizzazione con le altre grandi potenze?
Massimo De Angelis
Né l’uno né l’altra. Si tratta di un grave episodio, che si dovrebbe cercare di dimenticare non soffiando sul fuoco della spaccatura nazionale come per quattro anni hanno fatto i democratici. Un partito democratico che, similmente a quanto avviene in Italia, pensa di costruire i propri successi e di consolidare la democrazia demonizzando gli avversari politici anziché curarsi di interpretare il malessere di quei pezzi di società che a lungo essi hanno rappresentato ma evidentemente in modo sempre meno credibile (Middle class e working class). Quel partito punta sui grandi gruppi tecnologici-finanziari e sul disagio multietnico ma questa non è una base solida sulla quale costruire una società equilibrata. Benedetto Croce diceva che senza classe media manca alla società la spina dorsale. Credo abbia ancora ragione. E perciò credo che anche negli Stati Uniti la linea politico-culturale trumpiana preceduta da quella dei tea party non è destinata ad essere archiviata, né sarà possibile a Joe Biden ricostruire la sbandierata unità nazionale.
Antonio Di Bella
L’assalto al Campidoglio viene letto in maniera diametralmente opposta nel corso del dibattito sull’impeachment dell’ex presidente Donald Trump. Secondo l’accusa democratica si tratta di una vera e propria insurrezione sollecitata da Trump è messa in atto da gruppi di suprematisti organizzati militarmente. Al contrario la difesa repubblicana minimizza la gravità dei fatti giudicandola una manifestazione esecrabile ma non pianificata. C’è del vero in tutte e due le ricostruzioni. Quel che preoccupa a mio parere è il rapporto privilegiato e ambiguo che Trump ha sempre mantenuto con i gruppi suprematiste che fino ha pochi anni fa vivevano i margini della società civile e che dopo Trump hanno enorme visibilità e cittadinanza nel dibattito politico. Come uno stregone che evoca spiriti difficili poi da controllare Trump ha risvegliato un pezzo di America profonda razzista e violenta. Sarà difficile far tornare nella bottiglia lo spirito che abbiamo visto così attivo il 6 gennaio al Campidoglio.
Giampiero Gramaglia
Definire “una marcetta” l’assalto al Campidoglio del 6 gennaio è come ironizzare sulla ‘marcia su Roma’ (prima di misurarne le drammatiche conseguenze): fenomeni che, se sottovalutati, fermentano e avvelenano un’intera società. Con l’aggravante che i rivoltosi del 6 gennaio non erano Arditi reduci – delusi – da una guerra tragica, ma facinorosi senza passato che affidano alla violenza il riscatto dalla frustrazione dei loro fallimenti: pericolosi, perché solo quello sanno fare, convinti che tutti i problemi hanno una soluzione semplice.
Giacomo Mazzone
Donald Trump– come prima di lui Silvio Berlusconi in Italia- ha applicato alla politica i principi del marketing: nulla più, nulla meno. L’affondamento rapido di status sociale (prima ancora che di ricchezza) di una larga parte della popolazione, ha scongelato pezzi di elettorato dalle tradizionali appartenenze (operai=voto democratico) e aperto nuovi mercati ai filibustieri della politica, pronti a promettere tutto a tutti. Trump si è rivolto all’America bianca e suprematista per affinità elettive, ma soprattutto perché era il blocco più grande disponibile sul mercato elettorale. Se fossero stati gli ispanici, forse, avrebbe puntato su di loro. Il problema, quindi, non sono i suprematisti bianchi, ma il disagio sociale che spinge l’ex classe media, nella battaglia contro il presunto “nemico esterno” (quello che gli “ruba il lavoro”), a considerare i marciatori di Capitol Hill “alleati” solo perché hanno la pelle dello stesso colore.
Andrea Melodia
Fermo restando che il suprematismo bianco è una teoria razzista del tutto squallida e insopportabile, direi che sarebbe somigliata a una “marcetta” se non ci fossero scappati i morti, e sarebbe stata una tragedia se fosse finita in modo peggiore. Si sono visti aspetti degli estremismi che si possono legittimamente analizzare. In sintesi, è stato un momento di sfida alla democrazia molto serio, al limite del ridicolo per alcuni personaggi coinvolti, ma ha generato anticorpi e si è evitato che degenerasse. È stata fondamentale la capacità di chiudere in giornata, appena liberata Capitol Hill, la decisione sul voto elettorale degli Stati.
Gianfranco Pasquino
Non penso che protagonista sia il lutto dell’11 settembre. A mio parere la globalizzazione non c’entra quasi niente. Siamo di fronte al vero, grande, irrisolto problema americano. Gli Stati Uniti nascono e prosperano sulla schiavitù. Il suprematismo bianco che, in parte economico e sociale in parte culturale, non è mai venuto meno. Permea ampi settori non soltanto dei bianchi delle classi popolari. Il suo superamento non avverrà abbattendo statue, ma attraverso un profondo ripensamento culturale e soprattutto grazie a cambiamenti demografici che sono già in corso. Quella marcetta sul Campidoglio ad opera delle faccette bianche è qualcosa di tremendamente politico da non dimenticare. Una scena gravissima con radici profonde (e 74 milioni di voti).
Carlo Rognoni
Dobbiamo sperare in Joe Biden, nella sua politica internazionale e nazionale. Dopo John Fitzgerald Kennedy è il secondo presidente degli Stati Uniti cattolico. Non dimentichiamo soprattutto che è stato vicino a Barak Obama. E che al suo fianco c’è una vice-presidente di colore Kamala Harris che potrebbe perfino diventare – come scrivono tanti commentatori – il futuro presidente degli Stati Uniti. Dimenticare Donald Trump è un dovere se si vuole che ci sia di nuovo l’America. Va cancellato il titolo “C’era una volta l’America”. E va sostituito da un altro: “l’America ritorna”. Speriamo.
Dom Serafini
Va subito detto che a marciare sono stati in 25 mila (lo stesso numero della Marcia su Roma). Ad invadere il Campidoglio sono stati in 500 circa (secondo la mia stima), occupanti che non avevano nulla da perdere (buona parte aveva anche precedenti penali). Il significato di quanto avvenuto il 6 gennaio 2021 va ricercato nella voluta mancanza assoluta di prevenzione in termini di intelligence: non ci voleva molto per fermare questi 500 scalmanati molto prima che salissero le scale del nostro Campidoglio