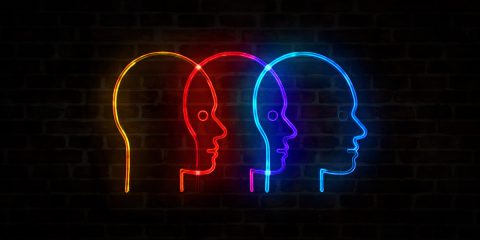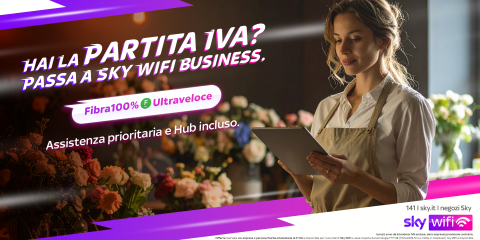Italia

1. Dall’agorà all’anomalia italiana.
“Ma che fortuna!”. Me lo ha detto un amico, con il sorridente cinismo tipico dei giornalisti, quando ha letto il titolo del nostro convegno, annunciato quasi nelle stesse ore in cui è esplosa la vicenda delle intercettazioni telefoniche tra dirigenti Rai e Mediaset. La risposta -lasciando da parte l’inquietante connotazione del concetto di “fortuna” per i giornalisti- è stata evasiva e prudente: “Forse è la dimostrazione -ho risposto, con un po’ di imbarazzo- che stiamo nuotando dentro il flusso della modernità…”.
Battute a parte, il titolo che il Corecom FVG si è dato, “Media e politica, tra controllo, complicità e conflitto”, forse è un po’ cattivo, può essere considerato scontato, addirittura banale, ma ha colto il senso del tempo.
E’ un argomento, infatti, che deve essere chiarito e dibattuto, per cercare di capire e conoscere la realtà in cui viviamo (che è fatta di parole e di immagini, ma anche di fatti e realtà, che i media dovrebbero cercare, “ordinare” e raccontare, meglio se garantendo una pluralità di punti di vista).
Il nostro vero obiettivo, grazie alla preziosa collaborazione con la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Trieste, è quello di rivolgerci soprattutto ai giovani per cercare di capire -assieme a loro- l’intreccio sempre più stretto che esiste tra il mondo della comunicazione e quello della politica.
Un intreccio che è antico quanto la civiltà occidentale, che esiste da più di 2500 anni, che è nato dentro l’agorà, dentro la piazza che ospitava -fin dall’inizio, uno accanto all’altro- la politica, il mercato e l’amministrazione della giustizia nei processi pubblici.
Un intreccio che è diventato potentissimo da quando abbiamo iniziato ad abitare il “villaggio globale”, da quando i mezzi di comunicazione di massa, prima la stampa ed ora la televisione, sono diventati dei veri e propri “poteri”, che si affiancano e/o contrappongono a quelli tradizionali (legislativo, esecutivo e giudiziario) con il compito di formare/informare l'”opinione pubblica”.
Un intreccio che in Italia è particolarmente “intimo”, grazie (o a causa) del duopolio televisivo Rai-Mediaset, più volte segnalato dalla stessa Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM). Il duopolio televisivo sembra intersecarsi in modo profondo e quasi inestricabile con il mondo della politica. Questa -a mio avviso- è solo la versione più recente di una anomalia italiana che ha sempre condizionato la “merce informazione”.
2. Un mercato “bizzarro”.
Il mercato del settore audiovisivo italiano è perlomeno “bizzarro” (direbbero i francesi).
I mercati televisivi in Italia -ha detto Corrado Calabrò, presidente dell’AGCOM, il 24 luglio 2007 presentando la Relazione annuale 2007- “sono ancora caratterizzati da una concentrazione elevata. Nel 2006, la raccolta pubblicitaria televisiva dei primi due gruppi, Mediaset (55%) e RAI (29%), è stata pari all’84%”.
L’Italia è “anomala” in Europa anche perchè la raccolta pubblicitaria televisiva ha un ruolo preponderante (53%) rispetto alla carta stampata (32%).
Pubblicità significa soldi, finanziamenti, ma anche potere, visto che -sempre secondo il presidente Calabrò- è il “principale mezzo di comunicazione, con circa l’85% della popolazione italiana che guarda la televisione ed un consumo medio che è ancora di circa quattro ore al giorno”.
In sostanza la “magna pars” del sistema informativo italiano si appoggia sul duopolio televisivo Rai-Mediaset, due colossi economici, che producono informazione, cultura ed intrattenimento, anche se il peso, il ruolo e le funzioni dei due colossi sono asimmetrici.
La Rai, che svolge per definizione e tradizione “servizio pubblico” (ma anche le televisioni private e soprattutto quelle locali, che raccontano il territorio, svolgono un “servizio di interesse generale”), ha ricavi per 2.539 milioni di euro (canone 1.483 e pubblicità 1.056), mentre quelli di Mediaset sono di 2.267 milioni (pay 36 e pubblicità 2.228), su un totale di ricavi di tutte le emittenti televisive di 6.805 milioni di euro (compresa SKY, con 1.450 milioni di euro, La 7 con 137 e tutte le altre tv locali e Fastweb con 415 milioni di euro). Bisogna ricordare anche che la Rai ha più di 10.000 dipendenti, mentre Mediaset sfiora i 6.000 occupati (fonte, Il Sole-24 ore su elaborazione Iem in base a dati AGCOM).
Per svolgere il “servizio pubblico”, la Rai incassa un canone che copre più della metà del fatturato, ma il canone in Italia -anche questa è un’anomalia- è il più basso tra i principali paesi europei (dati anno 2001): Italia 92; Francia 117; Gran Bretagna 161; Germania 194 (“La TV in Europa” di Pasquale Rotunno, Rubettino editore, 2003).
In sostanza il canone alla Rai, garantito in cambio di precisi impegni e standard produttivi, dovrebbe liberare il servizio pubblico dal ricatto del mercato e dalla dittatura dell’audience. Ma questo è vero solo in parte, viste le diffuse polemiche sulla omologazione tra Rai e Mediaset (indipendentemente dalle intercettazioni telefoniche).
Il canone, anzi, sembra diventato il guinzaglio che il Parlamento e il Governo tengono in mano per controllare (o “vigilare”) il servizio pubblico. La politica -nella migliore delle ipotesi- chiede ampie fette di visibilità, magari accontentandosi dell’insostenibile serie di “figurine” di personaggi politici citati e mostrati per pochi fotogrammi nei telegiornali -rischiando la pubblicità subliminale- che ottengono l’unico risultato di frazionare qualsiasi ragionamento o discorso coerente, mortificando la funzione di sintesi e divulgazione dei giornalisti.
3. Politica e “bulimia mediatica”.
Apparire, essere riconosciuti, meglio ancora, diventare “famosi”.
E’ l’aspirazione di (quasi) tutti: avere almeno un quarto d’ora di notorietà nella vita.
Siamo diventati “post moderni” sull’onda della vera grande promessa che il profeta pop (popolare? populista?) Andy Warhol ha elargito a tutti e alla quale pochi sembrano disposti a rinunciare (una delle scorciatoie più sicure per conquistarsi il “quarto d’ora di celebrità” è quella di essere un “presunto colpevole” in qualche fatto di cronaca nera, essere scagionato e poi è facile entrare nello star system di Fabrizio Corona, Porta a Porta o Matrix: è capitato ad Azouz Marzouk per la strage di Erba e a Patrick Lumumba dopo l’assassinio di Meredith Kercher, e l’estrema deriva è stata toccata in questi giorni, quando un autista ubriaco, Marco Ahmetovic, che ha ucciso 4 giovani, è diventato testimonial di “Linearom”).
Ma l’ansia di apparire, che pure è umanamente comprensibile, per chi fa politica rischia di diventare una specie di ossessione, anche se, per certi aspetti, può essere considerata quasi un’esigenza professionale, vista la spirale che lega il consenso alla notorietà e quindi ai voti. Ma da almeno tre lustri, in Italia, dalla fine delle ideologie forti, dopo Tangentopoli e dopo il referendum che ha aperto le porte al sistema elettorale maggioritario (corretto), la politica si è “personalizzata”, ha scoperto la centralità della “persona” (“maschera” per i latini) e del leader, meglio se telegenico (una volta bastava fosse carismatico).
E così, farsi vedere (soprattutto in televisione), a tutti i costi e in qualsiasi occasione è diventata una necessità primaria.
Per questo motivo molti politici (questo discorso -l’esperienza che abbiamo al Corecom FVG lo conferma- è vero soprattutto a livello nazionale, perché le forme della comunicazione a livello periferico e locale sono più “normali”) sembrano affetti da una sorta di “bulimia mediatica”, hanno bisogno di continue dosi di apparizioni televisive per essere sicuri di esistere.
Probabilmente l’aspetto più doloroso dell’uscita dal palcoscenico della politica (piuttosto raro in Italia) è proprio legato alla rinuncia di una visibilità pubblica che si vorrebbe prolungare all’infinito. La visibilità televisiva diventa, così, la fonte dell’eterna giovinezza, come dimostra la consacrata immortalità di Mike Bongiorno, più che mai paradigma della comunicazione televisiva (intuito da Umberto Eco già nel 1964, quando non sembrava esserci una terza via tra apocalittici ed integrati).
4. Le regole dimenticate.
Da qui, senza entrare in discorsi troppo ampi e complessi, nasce l’esigenza di garantirsi una visibilità costante, meglio se in televisione, per apparire più spesso possibile e dovunque, anche in programmi che di “politico” non hanno proprio nulla.
E qui bisogna fermarsi un momento, per precisare e riflettere.
Per tenersi lontani dal facile qualunquismo, che condanna tutto e tutti, è essenziale essere precisi: quando si ha qualche cosa da dire, quando ci sono i fatti, le decisioni da prendere, finanziamenti da dare o da togliere a qualcuno, è sacrosanto che chi governa (dalla maggioranza e dall’opposizione) abbia la possibilità di intervenire, spiegare, dialogare, magari anche polemizzare (meglio se rispettando le regole della buona educazione). Questo è -o dovrebbe essere- il rapporto corretto tra politica ed informazione. Troppo spesso, però, le cose vanno diversamente, perchè le opinioni e le polemiche anticipano o emarginano i fatti.
Ci sono stati momenti in cui l’affollamento di politici all’interno dei contenitori televisivi più svariati, anche nel servizio pubblico, è stato esorbitante. Gli esempi non mancano, come nel caso della trasmissione “Quelli che…”, edizione 2006, nella quale venivano invitati dei parlamentari (meno noti) in una sorta di parodia dell’Isola dei famosi, giocata applicando una parodia della “par condicio“. Probabilmente erano tutti contenti: la conduttrice, i parlamentari (diventati un po’ più famosi), il pubblico che applaudiva. Quasi nessuno, però, si è ricordato che esiste un “atto di indirizzo” della Commissione parlamentare di vigilanza dei servizi radiotelevisivi (11 marzo 2003) in cui si raccomanda -al servizio pubblico, sul quale ha specifica competenza- di evitare «la presenza di esponenti politici nei programmi di intrattenimento» in modo di non dare «la sensazione che il carattere pubblico del servizio consista nella simbiosi con la politica». L’unica eccezione alla regola è concessa nel caso che questo o quel politico abbia «particolare competenza e responsabilità» sugli argomenti trattati (è ovvio che in Italia è quasi impossibile trovare qualcuno che non sia competente di calcio).
Allora è davvero un Paese “bizzarro” quello in cui le regole ed autorevoli “atti di indirizzo” prima vengono promulgati e poi restano dimenticati in un cassetto. A quanto pare siamo ancora il Paese delle “grida” manzoniane, perché sotto la solennità delle regole non ci sono sanzioni per chi contravviene, ma poi -se le regole non vengono applicate- tutti sono autorizzati a lamentarsi della “volgarizzazione della politica” (il Corecom FVG ha mandato una segnalazione formale su questo caso, ma non ha avuto risposta).
5. La televisione “facile” e potente.
Nel sistema televisivo italiano (a livello nazionale) è sempre più difficile capire chi controlla chi. Sono i media a svolgere il ruolo di “cani da guardia” (dei cittadini verso il potere) o è la politica a “vigilare” sui media? Anche qui il discorso è straordinariamente complesso.
Innanzi tutto bisogna ricordare la profondissima differenza tra la televisione (il medium più visto e meno credibile, secondo una recente indagine dell’Osservatorio Demos-Coop) e i giornali e più in generale la carta stampata (la radio meriterebbe un discorso a parte mentre la rete è un “nuovo mondo” da esplorare).
I giornali, bene o male (pur percependo consistenti finanziamenti pubblici), stanno sul mercato: ogni giorno bisogna alzarsi, andare all’edicola, chiedere questa o quella testata e soprattutto pagarla. Leggere un giornale è sempre il risultato di una scelta ed è comunque faticoso, necessita di uno sforzo fisico e di un impegno critico.
La televisione è più “facile”. E’ sempre pronta (alcuni la tengono sempre accesa perché “fa compagnia”) e apparentemente non costa. Quasi sempre davanti alla televisione ci si rilassa, ci si lascia andare e l’unico sforzo è quello di digitare sul telecomando per fare zapping. E’ questa “facilità” che rende la televisione potentissima e potenzialmente pericolosa (è, più o meno, la tesi di Karl Popper). Proprio per questo bisognerebbe essere attentissimi a distinguere in modo rigoroso l’informazione (nerbo del “servizio pubblico”) dall’intrattenimento. Ma sta accadendo proprio il contrario. Informazione ed intrattenimento si sovrappongono e confondono (dando vita al famigerato “infotaitement”), diventando sempre più “volgari”, nel continuo e spasmodico adescamento del pubblico. Non sorprende, quindi, se le trasmissioni più “credibili” sul piano dell’approfondimento sono quelle comiche e satiriche (Striscia la notizia e le Iene, secondo l’indagine dell’Osservatorio Demos-Coop).
Ma attenzione, forse stiamo guardando il passato. I giovani -secondo un’ampia indagine su “Giovani e Media”, realizzata dal Corecom FVG in collaborazione con l’istituto di ricerca SWG- si stanno allontanando clamorosamente dalla televisione, restano vicini alla radio, leggono ancora i giornali per gli approfondimenti, e poi navigano e comunicano soprattutto nella rete (web). Eppure -a mio avviso- non ci libereremo tanto facilmente della “vecchia e cara” televisione generalista. Certo, siamo vicini ad una clamorosa rivoluzione tecnologica: chi se lo potrà permettere avrà la tv “on demand” (a pagamento) e si costruirà il proprio palinsesto in base ai propri interessi. Nel 2012 avremo il digitale terrestre che risolverà tutti i nostri problemi moltiplicando i canali a disposizione (ma l’Unione Europea non ne è convinta, tanto che incombe una pericolosa e costosissima procedura d’infrazione). Ma il vero rischio è che la “vecchia e cara” televisione generalista diventerà sempre più la televisione dei poveri e dei vecchi (sicuramente dei “poveri vecchi”), che non hanno i soldi per accedere ai servizi a pagamento e/o non controllano le nuove tecnologie.
E’ quindi preoccupante che ci sia una continua osmosi tra chi fa informazione e chi fa intrattenimento, tra quando si parla di cose serie (informazione) e quando si gioca, si scherza e ci si diverte.
Il concetto di “osmosi” diventa fondamentale per interpretare il duopolio televisivo italiano, inevitabilmente destinato all’omologazione e all’entropia “grazie” allo scambio continuo -tra Rai e Mediaset- di presentatori, di soubrette, di direttori di telegiornali, di quiz, di pacchi della fortuna e di reality. C’è poco da sorprendersi, alla fine, se tutto sembra uguale.
6. Il trionfo della cronaca nera.
Ma le cose -se possibile- sono ancora più complicate. Chi fa informazione e si prende sul serio e al tempo stesso guarda all’andamento dell’audience (i direttori dei telegiornali lo fanno costantemente) sembra aver trovato la strada maestra: puntare sulla cronaca nera (più è nera meglio è, tanto che lo stesso Presidente della Repubblica Napolitano, recentemente, ha richiamato i giornalisti alle loro responsabilità).
Ecco, allora, che un avvenimento clamoroso nella storia nazionale, come la decapitazione della cupola mafiosa in Sicilia dopo l’arresto dell’ultimo capo dei capi, senza spargimento di sangue, frutto di tanta pazienza, sacrifici ed intelligenza, diventa una notizia di quarta fila perché viene “coperta” dall’omicidio di una povera ragazza inglese a Perugia, che ancora -purtroppo- domina pezzi importanti dei nostri telegiornali. (Personalmente, invece, avrei voluto abbracciare quei poliziotti mascherati che esultavano per la cattura di Lo Piccolo).
Lo Stato, forse, ha iniziato a sconfiggere un mostro criminale che ha eroso e violentato pezzi del nostro Paese , ma pochi se ne sono accorti.
Dall’altra parte ci sono autorevoli esponenti politici che hanno chiesto la sospensione di una “fiction” televisiva che ricostruisce 40 anni di potere mafioso, facendo nomi e cognomi, dando un volto alle decine di morti tra forze dell’ordine e magistrati, bella e tesa sul piano formale, rigorosa sul piano narrativo (“Il capo dei capi” su Canale 5). C’è un Ministro della Repubblica, affiancato da alcuni deputati della Regione Sicilia, che si è permesso di “entrare” nel palinsesto Mediaset affermando che il programma faceva cattiva pubblicità alla Sicilia ed era “diseducativo” perché poteva indurre i giovani all’emulazione (William Shakespeare, che ha scritto Macbeth, sarà accusato di essere responsabile di tutte le violenze nel mondo…?).
Anche questo episodio dimostra che c’è un rapporto anomalo (o almeno bizzarro) tra media e politica in Italia. (Personalmente, quel serial, lo porterei nelle scuole per farlo “leggere” come un libro di testo e farei imparare a memoria agli studenti i nomi di Falcone e Borsellino, del generale Dalla Chiesa, di Boris Giuliano, Cassarà, Pio La Torre e tantissimi altri).
Il trionfo della cronaca nera si conferma nel modo di raccontare una realtà “fatta a pezzi” e rimontata per fare audience. Accade quando, dentro una manifestazione composta da migliaia di persone che si comportano civilmente e magari anche allegramente, si incuneano poche decine di violenti. Quasi tutta l’informazione e le immagini si concentrano sugli incidenti, mentre le motivazioni di migliaia di cittadini che partecipano pacificamente a un corteo, per definizione “non fanno notizia” (è successo, almeno in parte, al corteo di Alleanza Nazionale contro il Governo Prodi, al corteo di Genova, che voleva denunciare le violenze esplose, nelle strade e nelle caserme, al G8 del 2001). Come dire che senza violenza e senza cronaca nera è difficile “fare notizia” (forse si tratta solo di “pigrizia” da parte di chi fa informazione: la cronaca nera è “facile” e rende tanto a livello di audience).
Anche il Governo si fa dettare l’ “agenda” politica dalla cronaca nera. Come si spiega, altrimenti, la proposta iniziale di un iter -lungo e complesso- di proposta di legge per il “pacchetto sulla sicurezza”, che subito dopo il terribile omicidio di una signora romana diventa un decreto legge immediatamente esecutivo? L’emergenza prima non esisteva? Oppure un singolo gravissimo caso di cronaca nera (negli stessi giorni ci sono state altre donne violentate ed altri omicidi, sempre di donne, che non hanno fatto massa critica a livello informativo), che ha colpito l’opinione pubblica, ha cambiato i tempi della politica?
7. La giusta distanza.
Il sistema televisivo nazionale, quindi, ha molteplici asimmetrie.
Mediaset è un grande gruppo privato che opera all’interno di una concessione pubblica e fa il proprio mestiere con la logica del mercato. Certo, il fatto che il suo proprietario sia il leader della principale forza politica italiana (seconda la logica neo proporzionale), crea qualche problema di “conflitto d’interesse”, ma pare che l’argomento non interessi più di tanto gli italiani (anche se la ricerca dell’Osservatorio Demos-Coop dice il contrario).
Ma il vero problema rimane il servizio pubblico. Ci sono sempre stati, alla Rai, autorevoli giornalisti che avevano ed hanno il proprio “azionista di riferimento”, partiti o correnti di partiti, dimenticando che gli unici veri azionisti sono gli utenti che pagano il canone. Più in generale il servizio pubblico dovrebbero garantire in modo rigoroso ai cittadini -come ribadisce l’AGCOM (l’ultimo richiamo è dell’8 novembre 2007) e in base alla legge vigente (“Testo unico della radiotelevisione”, d.lgs n. 177/2005)- il “pluralismo, l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità dell’informazione”.
Tutti dicono, adesso, che bisogna far fare alla politica “un passo indietro” rispetto al sistema televisivo pubblico, ma non si capisce quando e come. Per quanto riguarda il duopolio, che raccoglie quasi il 90% del mercato pubblicitario, invece, il problema è come garantire il pluralismo e la concorrenza in un sistema bloccato.
Il ministro Gentiloni, in parte incalzato dall’Unione Europea, ha fatto delle proposte, che possono essere giuste o sbagliate o da correggere, ma anche qui non si capisce se hanno un sapore politico (ridimensionare la potenza comunicativa dell’ex leader dell’opposizione) o una finalità economica (per garantire la concorrenza davvero si può mettere un limite del 45% alla crescita di un’impresa che fonda il 98% delle sue entrate sulla pubblicità? Non sarebbe più corretto porre dei limiti “a monte”, cioè limitare il duopolio delle frequenze, e poi lasciare che vinca il migliore?).
Comunque, fino all’altro ieri, le proposte Gentiloni erano state prudentemente accantonate.
Adesso, dopo le intercettazioni tra dirigenti Rai e Mediaset, sono ritornate all’ordine del giorno, ma di nuovo non si capisce se il caso “Rai-Mediaset” sia uno scandalo scoperto da Repubblica, un tentativo di occupare la Rai da parte di Prodi (Libero, 23 novembre 2007), una opera di sciacallaggio (Corriere della sera, 23 novembre 2007) o una “panna montata per danneggiare il clima di dialogo che si stava creando”, come sostiene Carlo Rossella, direttore di Canale 5 nel 2005 (Il Giornale del 22 novembre 2007).
Si fa fatica a capire.
Forse sarebbe un atto di civiltà e di coerenza con le norme europee se la politica italiana riuscisse a prendere “la giusta distanza” dai media e in particolare dal sistema televisivo.
Così la qualità potrebbe ritornare, dopo il lungo esilio nelle periferie notturne, al centro dei palinsesti e magari garantire davvero il “pluralismo, l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità dell’informazione” che sono stati promessi ai cittadini.