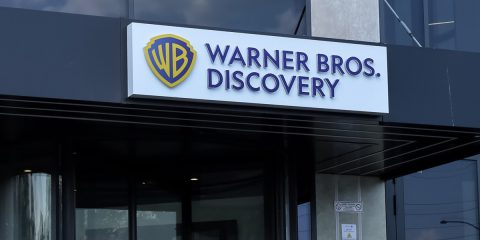Un paio di settimane fa Netflix ha festeggiato i suoi primi dieci anni italiani.
Nata nel 1997 per fare concorrenza a Blockbuster, quando arriva in Italia l’azienda è già un gigante dell’intrattenimento VOD con solide radici negli USA e nel nord Europa. Il suo sbarco è annunciato e accolto come una rivoluzione senza ritorno e il mantra è uguale ovunque. Il nuovo protagonista del mercato avrebbe fatalmente sostituito i vecchi, e con quali effetti, neanche a dirlo: il palinsesto e la “linea editoriale” condannati ad un ineluttabile e rapido declino; la vecchia tecnologia trasmissiva via etere terrestre destinata a cedere il passo allo streaming; niente più vincoli di orario; basta appuntamenti settimanali con i programmi preferiti; binge watching per tutti. Insomma, a ognuno la sua tv: lo dicevano allora (e lo ribadiscono in larga misura ancora oggi), economisti, tecnologi, esperti di marketing, sociologi.
Sono passati dieci anni e bene ha fatto Netflix a celebrarsi con tanto di udienza in Quirinale, conferenza stampa al Ministero della cultura e festa grande allo GNAM (il Museo nazionale di arte moderna di Roma, affittato per l’occasione con grande fasto). E bene ha fatto il co-CEO Ted Sarandos a ricordare che Netflix “tra il 2021 e il 2024 ha generato oltre 1,1 miliardi di valore aggiunto sull’economia italiana, collaborando con oltre 30 società di produzione e creando più di 5500 opportunità di lavoro tra cast artistico e personale tecnico”.
Il video diffuso dall’azienda per l’occasione, prodotto con sapienza inimitabile, in grado di percorrere in 4 intensissimi minuti dieci anni di successi, è una accattivante lettera d’amore all’Italia e agli italiani, con le location (Torino, Palermo, Roma, Bari, Napoli, Venezia, Firenze) che diventano luoghi del cuore, capaci di evocare ed esaltare radici culturali, identità, patrimoni artistici, senso comune, appartenenze.
E come non ricordare che con Netflix, in questi anni, sono via via arrivati Disney, Paramount, Warner Bros, Prime tv, Dazn e quant’altro. E davvero per alcuni milioni di italiani, forse dieci, forse quindici, è cambiato tutto nella fruizione dei contenuti video e nel concetto stesso di intrattenimento. Nessun dubbio su questo.
E però gli italiani in età scolare sono circa 56 milioni, e dunque bisognerà cominciare a distinguere: per molti di loro la rivoluzione annunciata da Netflix dieci anni fa si è effettivamente compiuta, ma per almeno altrettanti, ma probabilmente di più, è passata di lato e non si è punto avvertita. Anche questo va detto, e non per negare quanto di nuovo è accaduto nel sistema televisivo italiano in questi ultimi dieci anni (sarebbe sciocco solo pensarlo), ma per avere una fotografia più realistica del paese, visto e considerato che i consumi televisivi (e i consumi in genere) sono la spia di dinamiche più strutturali e possono aiutarci a cercare risposte sullo stato di salute profondo della popolazione.
Proviamo a riflettere su qualche cifra. A ottobre 2017 la platea televisiva serale (nel prime time 20.30-22.30) era composta da circa 25 milioni di italiani (dati Auditel). A settembre 2025 questa stessa platea è di 17,6 milioni. En passant, oltre il 70% di essa era e resta appannaggio di RAI e Mediaset. Negli otto anni in questione, la tv free to air ha dunque perso per strada oltre 900mila spettatori l’anno, e lo stesso “duopolio” si è ridimensionato, molto più RAI (che passa da 9.3 milioni a 5,9 milioni) che Mediaset (da 8,4 a 7,0 milioni).
Vista da qui, la rivoluzione effettivamente c’è stata. Soprattutto se si pensa che nel frattempo, in questo arco temporale, la piattaforma satellitare ha toccato il suo picco di circa 5 milioni di abbonati e gli streamer sono cresciuti vorticosamente.
Ma vediamo qualche altro numero. Nel mentre che la piattaforma satellitare ha smesso di crescere, i numeri di Netflix in Italia hanno cominciato a rallentare, al punto che a partire da novembre 2022 abbiamo assistito ad una ibridazione del modello di business con l’offerta di abbonamenti a costo più ridotto, ma con la pubblicità.
E ritornando alle audience, come ricorda Studio Frasi analizzando su Tivù di settembre 2025 l’ultima stagione televisiva, “il peso dei diciotto broadcaster e dei 121 canali monitorati da Auditel (quindi non Netflix, e nemmeno Disney per intenderci) è ancora 4,5 volte superiore al resto dell’offerta televisiva”.
Se si osservano le cose dal punto di vista della raccolta di risorse (cfr. Relazione Agcom 2025, pp. 52-53), si evince che, nonostante la significativa ascesa dei ricavi di Netflix, Dazn, Amazon e Disney – il che fa del mercato televisivo italiano un mercato più plurale – quasi il 70% delle risorse complessive resta appannaggio di RAI, Sky e Mediaset. E se poi si va a guardare il dettaglio della distribuzione dei ricavi tra free e pay si scopre qualcosa di ancora più interessante, ossia che il rapporto di forze tra “vecchia” e “nuova” tv in termini di raccolta di risorse è rimasto sostanzialmente immutato nell’ultimo quinquennio. Nel 2020 la tv in chiaro raccoglieva infatti ricavi per 4,4 miliardi di euro (57,7% delle risorse) e la tv a pagamento per 3,2 miliardi (42,3%). Nel 2024 tale proporzione non è sostanzialmente mutata, nel senso che la tv in chiaro raccoglie quasi 5 miliardi di ricavi (56,3%) e quella a pagamento 3,9 miliardi (43,7%). Ciò che è radicalmente cambiato è semmai l’equilibrio interno ai ricavi da tv a pagamento, con un ribaltamento delle posizioni in un breve arco di anni e con l’offerta online che nel 2023 ha consumato il sorpasso sul satellite e nel 2024 vale il 55,4% delle risorse pay. Come a dire che l’incremento dei ricavi televisivi da parte delle grandi piattaforme di streaming è avvenuto in Italia a danno della pay tv satellitare, piuttosto che dei “vecchi” broadcaster free to air.
Ancora qualche altro dato per ragionare sulla televisione del futuro, almeno qui in Italia. Dazn cresce negli ascolti, chiude regolarmente la giornata calcistica con una somma di spettatori ormai stabilmente attestata oltre i 5 milioni di utenti, e però nelle prime 5 giornate di campionato solo 4 eventi (su 50) hanno superato la soglia del milione di ascolti. Sky, per parte sua, esulta per il milione e più di spettatori della diretta di Roma-Inter del 19 ottobre. Poi però arriva l’ennesima trasmissione in replica dell’eterno Montalbano e fa 3 milioni di ascolti su RAI 1. Per non dire che ogni sera in oltre dieci milioni si dividono tra La ruota della fortuna su Canale 5 e Affari tuoi su RAI 1.
Riflettere su questi dati non significa né negare l’evidenza dell’avanzata imponente della tv via streaming, né immaginare che questo processo possa subire inversioni di rotta. Insomma, indietro non si torna. E però questi dati inducono a riflettere sulle particolari caratteristiche sociali di questo processo di transizione, e su come e in che misura esso – e tutti i processi di innovazione tecnologica in genere – abbia effetto sulla totalità della popolazione italiana, e con quali conseguenze per chi resta indietro.
Se economisti e tecnologi non sono obbligati a soffermarsi sulle dinamiche di ordine socioculturale che accompagnano tali processi; chi ha nelle mani il governo delle cose ha il dovere di farlo. E per farlo è utile ragionare su alcuni macro-dati e alcune macro-tendenza di altro genere.
Dal 2015 l’inverno demografico italiano ha compiuto ulteriori passi. Secondo i dati ISTAT nel 2015 sono stati iscritti all’anagrafe 486mila bambini (tasso di natalità 1,36). Nel 2024 i nuovi nati sono stati 370mila, ossia -24% (tasso di natalità 1,18) L’effetto di questa dinamica, coniugato con la lieve ulteriore espansione della speranza di vita, velocizza il processo di invecchiamento della popolazione: nel 2015 gli over 65 erano 13,4 milioni, pari al 22% della popolazione; nel 2025 gli over 65 sono 14,6 milioni, pari al 24,7% della popolazione. Siamo il paese più vecchio d’Europa e quello con la più elevata età mediana (46,8 anni).
Nel 2015, sempre secondo i dati ISTAT, 4,6 milioni di persone (7,6% della popolazione), erano in stato di povertà assoluta e 8,3 milioni (13,7% della popolazione) si trovavano in stato di povertà relativa. Dieci anni dopo i poveri assoluti sono cresciuti di oltre un milione di unità (5,7 milioni) e i poveri relativi sono saliti a 8,7 milioni. In sintesi, nel 2015 avevamo circa 13milioni di individui in stato di bisogno, ora sono un milione e quattrocentomila in più.
Nel 2015 l’indice DESI (Digital Economy and Society Index), appena introdotto dalla Commissione UE per monitorare i processi di digitalizzazione in Europa, posizionava l’Italia al venticinquesimo posto su ventotto. Nel decennio trascorso l’Italia ha compiuto significativi passi avanti su molti fronti, ad esempio in tema di digitalizzazione della PP.AA. e delle PMI, e tuttavia, quanto ad alfabetizzazione digitale tra i cittadini, l’Italia resta retroguardia (ventiduesimo posto nella UE a 27), con solo il 45,8% delle persone che dispongono di un set di conoscenze di base (contro una media UE del 55,6%) idonee a consentire un pieno esercizio dei diritti di cittadinanza (Rapporto ISTAT 2025, pag.82).
Siamo un paese che invecchia più velocemente di altri; con persistenti e crescenti sacche di povertà e i cui abitanti faticano a tenere il passo con i processi di innovazione. Un paese in cui gli stessi dati ministeriali (si veda Minicifre della cultura 2024) fotografano un’Italia a consumi culturali zero per larghe fasce di popolazione (6 cittadini adulti su dieci non leggono un libro l’anno, e va peggio per teatri e concerti). Al di là delle vulgate dispensate dai governi di turno, i numeri raccontano questo. E le risultanze dell’ultima indagine Agcom sui fabbisogni di alfabetizzazione mediatica e digitale non fanno che fornire al riguardo ulteriori conferme.
Il fatto che la rivoluzione televisiva preconizzata dieci anni fa non si sia compiuta nelle dimensioni e con la velocità che molti immaginavano ha molto a che fare con questi dati. Se sei anziano, o se sei povero o, peggio, se sei anziano e povero, e magari vivi al Sud, difficilmente le statistiche ti ritroveranno tra gli abbonati a un servizio streaming.
Tre anni fa, in un volume curato assieme a un gruppo di autorevoli amici e pubblicato proprio da Il Mulino, scrivevo a proposito del mercato televisivo che “il processo di switch tecnologico sarà meno lineare di quanto abitualmente viene descritto e più complesso e lungo di quanto comunemente si pensi; non ci sveglieremo bruscamente un mattino in un nuovo contesto tecnologico prodotto dall’azionamento di un interruttore. Assisteremo piuttosto a un lento e progressivo sviluppo (…). In definitiva, per quanto del tutto consapevoli che un processo di sostituzione tecnologica è prepotentemente in atto, possiamo ancora coltivare qualche dubbio sulla velocità e la univocità del percorso”.
Le ragioni per cui facevo una simile previsione erano strettamente legate ai fattori e ai trend di cui ho sommariamente fatto cenno. Non mi pare siano alle viste scarti o velocizzazioni. La rivoluzione della tv è un fatto acquisito per una significativa porzione di popolazione italiana. Ma ne restano fuori milioni di anziani, di poveri e di analfabeti digitali. Tirarli dentro ai processi di innovazione tecnologica è compito della politica.
In un paese che ha evidenti problemi di tenuta dei livelli di istruzione, cultura e alfabetizzazione della popolazione e che, per ragioni geopolitiche largamente indipendenti dalla propria volontà, deve incrementare in primis le spese militari, sarebbe quanto mai necessario destinare risorse crescenti a scuola, cultura e istruzione.
Non farlo (ne ho scritto tempo fa qui), ignorando i trend che ci vedono arrancare in Europa su tutti gli indicatori rilevanti al riguardo, significherebbe condannare quote crescenti di popolazione ad una condizione di marginalità e di analfabetismo funzionale che avvilisce le persone e ne riduce la capacità di esercitare pieni diritti. E questo è un problema per la stessa tenuta, in Italia e in Europa, di una democrazia troppo a lungo data per scontata, e che appare oggi fragile come mai.
Detto questo, si è vero, lo streaming ha reso la televisione molto più divertente e fruibile. E quindi buon compleanno Netflix e auguri tv del futuro.