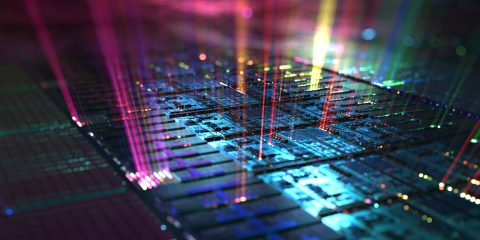Italia

#PAdigitale è una rubrica settimanale a cura di Paolo Colli Franzone promossa da Key4biz e NetSquare – Osservatorio Netics. Per consultare gli articoli precedenti, clicca qui.
Cosa direste se foste il CEO di una grande banca e se vi accorgeste che ciascuna delle vostre oltre ventimila filiali sparse lungo la penisola avesse i suoi server, i suoi applicativi, la sua infrastruttura di rete?
Voi direte: “ma dai, non esiste una situazione così!”.
E’ vero: non esiste. In banca.
Esiste, però, nella pubblica amministrazione: quasi 4.000 data center, quasi 60.000 server. Un’infrastruttura IT che costa non meno di 1,7 miliardi di Euro all’anno su una spesa complessiva ICT della PA italiana (compresa IVA – che per la PA è un costo – e compresi i costi interni) pari a 9,2 miliardi circa.
Il piano di razionalizzazione dei data center pubblici, voluto fortemente dagli allora Ministri Passera e Profumo e riconfermato come prioritario dopo il “cambio della guardia” a Palazzo Chigi, nasceva dalla banalissima considerazione che non avesse nessun senso tenere in piedi una siffatta infrastruttura (peraltro caratterizzata da una certa obsolescenza) e che fosse necessario lavorare al suo consolidamento creando (o riusando, laddove esistenti) data center condivisi tra le varie amministrazioni.
Un’ovazione. In pubblico.
Perché poi, in privato, anche il CIO del Comune di Rocca Cannuccia ti dice: “No, vabbè, ma io mica ci rinuncio al mio server, ai miei dati”.
E’ l’esatto opposto del “NIMBY” (“Not In My Backyard”): tutti vogliono “possedere”, toccare con mano, scatolotti metallici contenenti bit. Come se il valore fosse rappresentato dal peso dei server, dalla quantità di terabytes.
In totale assenza di contezza rispetto al tema della sicurezza, ma anche della spesa energetica conseguente alla conduzione di cotanto antiquariato informatico.
Questa strana forma di feticismo tecnologico ci ha fatto dimenticare il “vero” valore di un sistema informativo: la capacità di accedere al dato e trasformarlo in informazione. Che, nella società interconnessa odierna, diventa anche capacità di condividere (in “dare” e in “avere”, si badi bene!) questi benedetti dati.
Salvo poi disperarsi quando il buontempone di turno lancia il cyber attacco a Rocca Cannuccia, e tutto va a farsi benedire.
Salvo poi dire “Gesù, il backup!” quando lo stanzino eretto a “data center” (farsi un giro nei piccoli Comuni per credere) si allaga e il server va in ammollo.
In alcuni (non tantissimi, sia ringraziato il Cielo!) enti della PA italiana sopravvivono mainframes e minicomputer le cui sigle possono generare commozione in un’ipotetica casa di riposo per capi CED ottantenni. Macchine che vengono tenute in vita combattendosi pezzi di ricambio trovati chissà dove, il cui costo di conduzione a volte supera abbondantemente il costo di sostituzione.
Il tutto in nome di una sorta di accanimento sulla proprietà del dato, sulla difesa a spada tratta di un generico “potere” derivante dal controllo dell’infrastruttura.
Ed ecco che il “piano data center” rischia di incartarsi non tanto per ragioni di fattibilità reale, quanto piuttosto a causa della miopia di qualcuno (non pochi, purtroppo) di questi paladini del backyard.
Mai come in questo caso, la parola chiave è “cultura”. Un gap culturale non banale tra i CIO della PA (non solamente locale, si badi bene) che ancora non sembrano capaci di gettare alle ortiche il camice bianco da Capo CED per andare a interpretare un ruolo decisamente più strategico all’interno delle rispettive amministrazioni.
Vale forse la pena di stanziare qualche fondo da destinare a un profondo lavoro di formazione dei CIO pubblici, con l’obiettivo di disintossicarli dalla sindrome del backyard.