
Salvatore Sechi nel suo mini saggio “Il comunismo emiliano: variante storica della socialdemocrazia”, svolge un’approfondita disamina su una ricerca della Fondazione Gramsci di Bologna, a cura di Luca Baldissara e Paolo Capuzzo, pubblicata per i tipi de Il Mulino con il titolo Il comunismo in una regione sola? Prospettive di storia del Pci in Emilia Romagna. Fra le varie osservazioni e note a margine lo storico sardo osserva come: “Il Pcd’I nacque e si sviluppò legando, per un lungo periodo di tempo, il tema pervasivo della violenza a bisogni e momenti diversi: dalla lotta al fascismo, alla guerra di Spagna, alla Resistenza; dai rapporti con la classe operaia ai ceti non facili del mondo contadino; dalla salvaguardia della propria unità intessuta di solitudine e isolamento all’esigenza, stabilita dal VII congresso dell’Internazionale nel 1937, di creare alleanze ampie, non ideologicamente conformi, ma utili dando la priorità all’antifascismo. Ha che fare con la violenza lo stesso controllo dei militanti, l’educazione alla disciplina, la lotta per colpire spie e disertori, ed isolare o emarginare chi deborda nell’estremismo e nel farsi vendetta da sé. Saranno le vicende delittuose, i molti episodi di giustizia sommaria, legati al “triangolo della morte” (compreso tra le province di Modena, Reggio Emilia, Bologna, Ravenna e Ferrara) nel 1947-1948 a segnalare come il mito della rivoluzione sovietica e l’esempio di Stalingrado, non trovando se non una parziale soddisfazione negli atti di governo del Pci avesse riaperto un varco nella base del partito a radicalismi e strascichi puramente vendicativi. Una sorta di risposta alle moltissime violenze subite nel 1919-1920. Il partito ebbe un disegno anti-capitalistico e un modello che – non esclusivamente, ma in molta parte dei suoi dirigenti- è stato a lungo assimilabile a quello di Lenin e dei bolscevichi. In Urss non pochi leader, diventati comandanti militari, commissari politici e poi dirigenti di partito o anche (ma meno) amministratori, erano vissuti anche lungamente. Poiché nel volume non ce n’è traccia, mi chiedo come sia possibile che da essi non sia pervenuta una memoria o una parola di critica del libero arbitrio nell’esercizio della violenza dominante nella patria della dittatura del proletariato”.
###
In Emilia Romagna, al Pci è riuscito il disegno, e l’operazione, in cui era fallito – secondo Giuliano Procacci, in un intervento sul settimanale del Pci Rinascita – il partito bolscevico: cioè la conversione da partito di lotta armata, clandestino e settario in partito di massa, quindi popolare e tendenzialmente legalitario.
E’ un aspetto, quest’ultimo, che in Urss e nei paesi dell’Europa Orientale, di Cuba e della Cina non è mai emerso. L’esteso territorio infracontinentale, infatti, è stato dominato dall’impianto del feroce modello del dispotismo sovietico. Con gli accordi dell’agosto 1939 tra i ministri degli esteri Joachim von Ribbentrop e Vjaceslav Molotov, al patto, di durata decennale, di non aggressione tra Hitler e Stalin fu annesso un «protocollo aggiuntivo» segreto sulla spartizione dell’Europa orientale[1], Era niente più che un progetto neo-coloniale di invasione e divisione delle spoglie.
Col primo il regime politico creato nell’inverno 1917 da Lenin ha in comune la forma politica del comando. Nel totalitarismo Stato e società e civile perdono sempre più le differenze e scemano fino quasi a scomparire le autonomie di cui avevano goduto, dando vita a una società, se non proprio pluralista, non di rado aperta, come quella dell’età dei governi liberali.
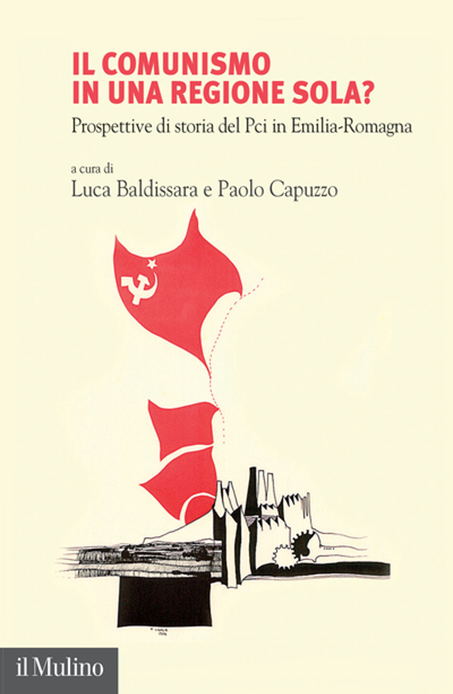
Nell’intera mappa dell’Europa sovietizzata per il dissenso, l’opposizione, la libertà di organizzazione e di stampa, non esistono i margini che sono propri di uno Stato di diritto.
Non solo dal punto di vista dell’opzione dei socialisti italiani ed europei per la democrazia politica di segno liberal-democratico, non mi pare sia mai stato avviato a superamento quello che rimane l’osso duro, l’elemento differenziante dei comunisti dai socialisti, cioè la teoria e la pratica del riformismo.
Soprattutto in Emilia Romagna, dove nacque ed ebbe il massimo radicamento, questo aspetto (con variazioni continue sul lessico) è stato mantenuto vivo, sulla base di un’esperienza di governo che ha coperto il lunghissimo periodo che dal 1948 arriva ad oggi.
Da Palmiro Togliatti a Enrico Berlinguer non si lasciò perdere nessuna occasione per attribuire a questa esperienza di governo regionale un valore, anzi una vera e propria funzione di portata nazionale. Era il modello di Stato e di società nazionale che il Pci proponeva all’Italia.
Di qui la correttezza del dubbio da Luca Baldissara e Paolo Capuzzo affidato al titolo dell’importante (al di là di singole precisazioni e divergenze su diversi punti) raccolta di saggi che hanno curato per conto della Fondazione Gramsci di Bologna[2].
Alla fine il Pci muore dopo essere stato anche una forza di governo, a livello locale e a livello nazionale. Dalle coalizioni centriste dirette dalla Democrazia cristiana furono create ogni sorta di difficoltà e paralisi attraverso l’azione persecutoria dei magistrati con continui processi di origine politica e un ventaglio di forme di sabotaggio nelle scelte amministrative ad opera di prefetture e questure. Su di esse si soffermano i saggi di Federico Creatini e soprattutto, direi, di Toni Rovatti che introduce nella narrazione storiografica sul PCI la categoria di “uso consapevole della forza”[3].
Il Pci muore senza aver fatto-fortunatamente-nessuna rivoluzione che cambiasse la natura degli uomini, com’è sempre stato, invece, nelle intenzioni dei rivoluzionari di destra e di sinistra.
La “rivoluzione” emiliana
In Emilia Romagna sono rimaste sostanzialmente intatte, malgrado assai sensibili cambiamenti, le stesse condizioni di ineguaglianza, il lavoro nero e precario, la ristrettezza degli spazi e i diritti di libertà, l’accesso discriminato alle conoscenze e alla trasparenza, la grande pena di vivere per i cittadini più fragili. Spesso, questi, sono valori e prassi rimaste sulla carta, evocazioni confinate in un contesto quasi libertario. Ovviamente nulla hanno a che fare né col dispotismo comunista e anche non molto con la stessa socialdemocrazia.
Negli ultimi trent’anni, almeno in Occidente ad essere precisi, il fenomeno osservato all’inizio del dopoguerra, cioè il contenimento e anzi la progressiva riduzione delle disuguaglianze, è una retta ormai sospesa tra interruzione e inversione.
Tra gli anni Settanta e Ottanta questa tendenza invertita avrebbe dato luogo addirittura a un nuovo modello produttivo[4]. Si affiancò alla globalizzazione e alla polarizzazione crescente delle società occidentali, cioè al ripensamento progressivo del modello economico fiorito dopo la grande crisi. L’ampio contributo di Bruno Settis[5] e i riscontri di altri collaboratori (Roberto Ventresca[6], lo stesso Baldissara[7], Andrea Ventura[8], Toni Rovatti e Federico Creatini prima citati, eccetera) ne sono una testimonianza.
L’insolvenza fiscale: colpa-pregiudizio
Per giustificare l’inizio di questo contenimento/crisi del cosiddetto “modello emiliano” non mi pare abbia senso rifugiarsi nel riandare a un’ormai secolare inadempienza[9], la realtà della diffusissima insolvenza fiscale (e anche, per alcuni, dell’occupazione fuori dei controlli legali). Infatti il contributo del Pci, durante i governi che ha sostenuto o di cui è stato parte, all’adozione di una politica di redistribuzione dei redditi che avesse come asse portante la creazione o il diverso uso di strumenti per incrementare sensibilmente gli obblighi tributari o contrastare severamente la diffusa evasione, è una riforma non fatta. Non si può dire abortita, anzi diciamo pure mai coerentemente ed energicamente tentata.
Non disponendo, a differenza della Svezia, dei poteri per varare una riforma fiscale ha finito purtroppo per accogliere, con rassegnazione ora sdegnosa ora paciosa, le diverse forme di indebolimento dello Stato di diritto prima citate. Nelle Giunte comunali nella città di Bologna del secondo dopoguerra guidate da Giuseppe Dozza (1946-1956) a perorarla fu l’assessore, di origine friulana, Paolo Fortunati[10], un docente universitario formatosi nella cultura fascista del corporativismo più radicale e passato al Pci durante la clandestinità.
L’ambizioso progetto di riforma dell’imposizione fiscale perseguiva l’obiettivo del contenimento e riduzione dei molti tributi esistenti. Si fondava sull’estensione del principio della progressività e assumeva fondamentalmente la distinzione istituzionale tra Stato ed enti locali.[11]
Lo scontro su questo terreno della gestione tributaria, fu opera della Dc, che, in tema di imposte dirette e indirette come di esenzione degli strati popolari più fragili, avanzò delle proposte innovative. Si deve, infatti, al leader democristiano Giuseppe Dossetti, nelle elezioni comunali del 1956, il coraggio di bollare come “tutt’altro che rivoluzionaria” la politica dell’amministrazione comunista guidata da Dozza nel 1956. Entrarono così, grazie alle riforme prospettate nel suo Libro bianco[12], a far parte del “modello emiliano” anche l’istituzione dei quartieri, del decentramento e l’avvio di una politica originale di partecipazione popolare attraverso i consigli circoscrizionali.[13] Il Pci le riprese anche se finiranno spesso ridotte per lo più a cantare i salmi e la gloria della politica estera comunista.
In realtà a entrare in crisi, a livello generale e non solo in Emilia Romagna, sono priorità come quella prima richiamata della redistribuzione del reddito. Tanto il ceto dei capitalisti quanto i principali strati sociali beneficiari di tale politica sembrano rifuggire dalla leva redistributiva per almeno due ragioni.
In primo luogo perché si consuma in una forma di rinnovato incremento dello statalismo, cioè non coinvolge come soggetti sociali i protagonisti. E’ quanto avvenne nel Regno Unito quando i costi a carico del bilancio pubblico per l’elargizione da parte di Tony Blair di sussidi e di mutui a milioni di giovani e a certi settori economici non furono più ulteriormente sostenibili sul piano finanziario. Affondano in questa evaporazione del budget dello Stato le vittorie elettorali di Margareth Thatcher.
In secondo luogo, bisogna dire che più dell’arricchimento (relativo, trattandosi di un aumento dei redditi) interessano altri valori ai quali il socialismo (britannico e anche italiano) hanno tradizionalmente guardato in ritardo e con una punta di diffidenza. Mi riferisco a valori non negoziabili come l’ambientalismo, il clima, i diritti civili eccetera, attraverso i quali si intendeva (e si intenderebbe da parte di Elly Schlein) far passare la marcia per l’emancipazione.
Come ha detto Fabrizio Barca
“era necessario un cambiamento strutturale nei rapporti di potere all’interno della società e nelle modalità di produzione […]. Questa è una delle ragioni della crisi della socialdemocrazia nel senso di Tony Judt”[14].
Il capitalismo (che con la fondazione nel 1919 del Comintern si era voluto non correggere, ma abbattere principalmente a mano armata) non ha avuto ragione di tremare. E, per la verità, neanche di dispiacersi più di tanto. Finirà per essere un privilegio il poter fare accordi con i comunisti dell’Emilia-Romagna che si sono progressivamente rassegnati a denunciare, ma non sanzionare, infedeltà, omissioni e abusi in materia di pagamento delle tasse.
Nelle province emiliano-romagnole la fine del comunismo non è avvenuta, almeno finora, alimentando l’inizio di possibile processo di regressione. La deriva delle rivoluzioni non di rado dà luogo a collassi, declini, catastrofi. Importante è saperne cogliere tempestivamente i segnali di scollamento e di erosione.
E’ quanto ha fatto da Lugano, sul piano dell’analisi dei marxismi e delle politiche (compresa quella di non facile decifrazione di Pietro Ingrao) proposte dal Pci, uno studioso tanto acuto quanto volutamente umbratile, Paolo Favilli. Al pari dei suoi collaboratori, non ha cercato di esibirsi come un prosseneta nei canali televisivi, ma ha affidato le riflessioni storiografiche più radicali alla tessitura di libri[15].
Da quelli più noti si possono ricavare tre grandi premonizioni. Una di carattere generale sulla difficoltà esplicativa del presente ad opera del vecchio prontuario togliattiano-molto più che gramsciano-del marxismo;in secondo luogo l’estenuazione–nullificazione,ad opera di un pungente Leonardo Paggi, dell’alternativa storicamente rappresentata in seno al Pci da Pietro Ingrao; in terzo luogo il dibattito interno alla Direzione nazionale (ridotto da un suo membro,Fabio Mussi,ad un vero e proprio Miserabilismus) in cui si è consumato, più che non sfibrato, il gruppo dirigente del Pci[16].
L’Emilia- Romagna: lo State Building del Pci
Il comunismo che ha avuto per teatro l’Emilia Romagna (e un rosario di altre regioni: Toscana, Umbria, Marche, fuori del radar questo volume) ha esaurito il suo fascino di esperimento solitario. E’ stato oggetto di una mitizzazione persistente dal momento che venne assunto come prospettiva nazionale. Si può dire figlia non solo dell’abilità propagandistica dei comunisti di vendere al meglio il proprio (peraltro unico) prodotto dell’obiettivo di una costruzione statale perseguita da Gramsci.
Direi, infatti, che esce in qualche misura di scena questo aspetto di fronte alla grande circostanza di un Pci limitatosi a distillare il po’ di riformismo (vale a dire di cambiamenti importanti ma non radicali) che nei suoi programmi aveva lungamente esecrato. Ad opera di protagonisti come Amedeo Bordiga, Antonio Gramsci e Palmiro Togliatti fino a un apostata incredulo e improbabile come Enrico Berlinguer.
Nella narrazione, non di rado assai autoreferenziale, della storia dei comunisti soprattutto dell’Emilia Romagna, il limite costituito dall’aver introdotto delle correzioni di alcune plateali diseguaglianze nelle comunità amministrate si è sempre voluto attribuirlo all’incapacità di potere fare di più, cioè di non disporre di una maggioranza per governare autonomamente.
Se il “comunismo in una regione sola” assomiglia al volto della socialdemocrazia europea (direi non di quella più avanzata come la Svezia, ma più cauta e misurata della Danimarca e della Norvegia), la tendenza è a rimettere in auge un refrain scontato e forse anche patetico.
L’impotenza del massimalismo socialista
Si esaurisce, infatti, l’analisi (e il processo) scaricando tutto su un solo imputato, cioè l’inettitudine, quando non il tradimento, degli stessi leader socialisti. Antico debordante livore di un passato-che-non-passa, anche se il tono di Baldissara – Capuzzo e dei loro collaboratori non serba niente o soltanto poco delle scorie anche pesantemente diffamatorie del passato.
Con i massimalisti serratiani insediati fino alla testa all’Avanti!, e nell’inverno 1919 con l’ascesa alla segreteria del PSI di un irriducibile profeta di sventure (sul destino del capitalismo post-bellico) come il forlivese Nicola Bombacci (finito nella Repubblica Sociale Italiana)[17],avevano minacciato e atterrito molto, ma osato pochissimo. Il rafforzamento del parlamento (un obiettivo sempre negato addirittura sin dopo le elezioni del novembre 1919) e il modo di produzione fondato sul capitale uscirono sempre abbastanza indenni dagli attacchi mossi dai socialisti di estrema sinistra al regime economico prevalente nei luoghi di produzione e di dominio nelle imprese e nella società.
Ma il clima di intimidazione e paura creato dai massimalisti portò al ripudio della tradizione del gradualismo riformista. Venne accolta, anche con un richiamo statutario, una parola d’ordine come “Fare come Lenin in Russia”. Il Psi, infatti, col congresso di Bologna del 1919 aderiva alla Terza Internazionale e adottava la falce e martello circondato da spighe di grano nel suo simbolo. Ad essere ricalcato anche graficamente fu quello adottato dai bolscevichi. Dunque, un’infatuazione politica e ideologica assoluta.
Dalla loro azione programmatica è tratta anche l’opzione per la violenza come mezzo di lotta politica. Il principio è che si deve “spingere il Proletariato alla conquista violenta del potere politico ed economico”, che dovrà essere affidato interamente ai Consigli degli operai e dei contadini. Non le vecchie differenze, ma le nuove convergenze tra socialisti italiani e bolscevichi per qualche grumo di anni balzano in primo piano. Prima e dopo la diffusione del Covid, in sintesi dopo più di un secolo ormai dalla fondazione, il Pci lascia in Emilia Romagna un quadro con molte ferite crepe.
Rallentamento-cedimento del “modello emiliano”
Non poche le città in cui temi cruciali come l’assistenza sanitaria (una volta un fiore all’occhiello) l’occupazione, la tenuta delle piccole e medie imprese, la formazione professionale, i diritti delle donne e delle famiglie eccetera si stabilizzano in un equilibrio tendenzialmente precario. Non fanno passi in avanti o registrano lesioni, quando non palesano un’inflessione negativa.
Emblematica è la testimonianza di un noto docente di economia nell’ateneo di Parma (consigliere del premier Romano Prodi dal 1996 al 1999 con incarichi di rango molto elevato presso la Commissione europea di Bruxelles), Franco Mosconi. Il suo saggio[18] non ha meritato alcun richiamo nel corpo di questo lavoro collettivo sul Pci, per la verità bibliograficamente molto ricco.
Mosconi è molto tempestivo e fermo nel mettere in guardia contro la creazione di stereotipi che degradano verso le facili glorificazioni in cui i comunisti (e non solo essi, per la verità) si sono identificati e direi anche cospicuamente compiaciuti scrivendo che
«Non c’è oggi (ammesso che vi sia stata nel passato) un’Emilia felix da contemplare e beatificare»[19].
A suo avviso la mappa trainante del “modello emiliano” consiste nei seguenti fattori chiave: l’elevato capitale sociale esistente nel territorio che promuove e si riversa nel tessuto produttivo locale; la contestuale crescita delle dimensioni delle imprese e degli investimenti in conoscenza, almeno a cominciare dagli anni Duemila, insieme ai diffusi miglioramenti qualitativi avvenuti tutte le filiere produttive.
Per l’attività d’impresa centrale sarebbe stato il contributo anti-crisi del robusto sistema bancario e il radicamento – presso tutte le filiere economiche – del movimento cooperativo, che è riuscito a far convivere le leggi del mercato, per quanto concerne la dimensione economica, e l’interesse comunitario, per quanto concerne la dimensione sociale.
Non si possono sottovalutare le economie di atmosfera come l’ampiezza dell’associazionismo, il volontarismo individuale e la rete degli imprenditori illuminati. Sono i componenti dello “spirito comunitario” che si può addirittura assumere come il “terzo pilastro” tra Stato e Mercato.
In questo straordinario contesto si è sviluppata come trainante l’industria manifatturiera. Sulla frontiera della tecnologia e della proiezione nei mercati internazionali ha creato nuove conoscenze (anche grazie all’intenso rapporto col mondo della ricerca) e nuovi prodotti.
Ma questo quadro positivo convive con altri fattori dai quali possono venire difficoltà e pericoli di rottura, e quindi una possibile torsione involutiva del “modello”.
Negli ultimi due-tre anni sono cominciati a riemergere, seppure in misura ancora contenuta, gli incubi che si erano neutralizzati o fatti scemare, cioè i livelli di disuguaglianze, le discriminazioni, forme vecchie e nuove di povertà e di sfruttamento proprie del capitalismo. Secondo la Banca d’Italia[20] nel 2020 la Regione Emilia-Romagna ha visto aumentare sensibilmente il numero dei gruppi famigliari afflitti da povertà assoluta. Il 6,3 per cento dei 2 milioni di nuclei familiari della Regione si trovava in tale stato, mentre nel 2019 era 3,4 per cento. Dunque, il pericolo persistente, non marginale, di effetti irreparabili su questo territorio, Mosconi lo associa anche al suo “inverno demografico” (la dinamica crescente della popolazione), al riemergere degli interessi campanilistici, sopiti ma mai vinti e, infine, alla tendenza all’autocompiacimento che descrive come “euforia da narrativa”.
La bassa crescita da circa un ventennio morde l’economia nazionale e «dopo le crisi del 2008-2009 (crac finanziario) e del 2011-2013 (debiti sovrani), l’Emilia-Romagna è stata capace di recuperare una parte del divario rispetto a un gruppo di regioni europee simili»[21] . Questa rappresentazione delle condizioni dell’Emilia Romagna sono preesistenti all’azione governativa dei comunisti e non sono rinvenibili in molte altre regioni. Il loro merito e quello dei socialisti di averle sapute consolidare e sviluppare. A differenza delle origini, il capitalismo non è più un tenebroso nemico. Lo si percepisce come un compagno di strada con cui si è scelto di coabitare.
Il “modello emiliano” come limite
Alla fine Baldissara e Capuzzo sembrano rassegnarsi a riconoscere che oltre il cosiddetto “modello emiliano” i comunisti non sarebbero riusciti ad andare. L’espressione è criptica e un po’ sfingetica[22]. Non a torto entrambi i due storici la disdegnano perché è una formula vuota e rettorica.
Non hanno, però, la forza o il coraggio (non saprei dire) di confessare quel che lo stesso Berlinguer ritenne, con i suggerimenti avventati di Antonio Tatò[23], di riempire di nebbie vaporose (l’esistenza di una cosiddetta “terza via” tra bolscevismo e riformismo), cioè che oltre i confini della socialdemocrazia (quella scandinava) non erano riusciti, e non potevano, andare. In altri termini, le pratiche economiche e sociali di governo sperimentate in Emilia-Romagna sono il punto più alto di trasformazione che i comunisti abbiano potuto realizzare.
Baldissara e Capuzzo non amano racchiudere il comunismo nel lessico del “modello emiliano”. E’ difficile dare loro torto, anche se il termine modello non è per niente fuori luogo.
In realtà, nella prassi quel che è stato messo alla prova nella Regione dell’Emilia Romagna è un insieme di meccanismi legislativi, cioè istituzionali e contrattuali (nelle imprese pubbliche e private) e di pratiche sociali. Certamente nulla hanno a che fare col comunismo di fattura bolscevica di cui erano imbevuti i dirigenti di partito, ma molto meno, credo si possa dire, lo strato degli amministratori. Dopo il 45 aprile 1945 nei Comuni e nelle Province furono in grande crescita per il dilatarsi della filiera, come hanno mostrato i molti e pregevoli studi di Luca Baldissara.
Molto, se non tutto, invece, pare riecheggiato dalle sequenze di una musica di cui furono compositori i socialdemocratici sparsi tra Reggio Emilia Modena, Ferrara, Forlì, Ravenna e Bologna. Purtroppo la storiografia socialista è massicciamente assente, salvo qualche stimolo critico[24].
Almeno per quanto concerne la valorizzazione delle scuole di ogni ordine e grado (salvo la formazione professionale di ampi settori come idraulici, falegnami, muratori, antennisti eccetera), gli asili nido, le politiche sanitarie e per la sicurezza, l’estensione di modelli contrattuali pro-labour alle imprese private, gli interventi delle istituzioni locali concordati con piccola-media industria e artigianato in modo da aumentare l’occupazione e il salario (soprattutto delle donne).
Nuoce al volume la mancata verifica dell’esperienza emiliana su scala europea, che potrebbe essere servita di riferimento. I due curatori non amano citare, se non di straforo, la rassegna che a livello europeo di queste esperienze seppero offrire Leonardo Paggi e Franco o D’Angelillo[25], e neanche il volume di Valerio Evangelisti[26], in cui il contributo del coautore (cioè di chi scrive) è intitolato Il comunismo emiliano, una variante storica della socialdemocrazia. Tanto meno gli studi di uno dei maggiori esperti del sistema economico, del pensiero politico e di un ex capo partigiano e noto docente torinese (ed ex dirigente partigiano) di diritto commerciale[27].
Credo che mutamenti avvenuti nella composizione e nell’organizzazione del Pci regionale potevano trarre vantaggio dalle ricostruzioni più recenti di Fausto Anderlini[28].
Tali omissioni si spiegano probabilmente con la sicurezza di potere rinvenire interamente gli stessi prolegomeni della teoria e della pratica riformatrice all’interno delle politiche di governo delle città prima e della regione emiliana amministrata dai comunisti.
La damnatio dei socialisti
In concorso con i socialisti, com’è noto, ma ai quali poco e nulla è riconosciuto. Non lo si dice, ma occupano il ruolo di figure teatrali o elementi di scorta. Soprattutto dai sindaci e dei dirigenti sindacali e delle cooperative di Bologna, Modena, Ferrara, Ravenna e Forlì qualcosa si dovrebbe avere appreso nell’uso di leggi e istituzioni per favorire i poveri meno abbienti.
Non esiste una riflessione approfondita dei socialisti sulle esperienze di governo con i comunisti e sul “modello emiliano”. Il silenzio è stato a lungo il segno di una rassegnazione e la presa d’atto di una incoercibile minorità. Si cercherà di rimediarvi suonando le campane e menando fendenti con la segreteria di Bettino Craxi. Ma la stabilizzazione del consenso elettorale intorno al 10-15 per cento impedirà al Psi di essere una forza in grado di coalizzare alternative, cioè condannata ad essere solo partner da una parte della Dc e dall’altra del Pci, cioè di non potere esercitare nessuna reale egemonia.
Il convegno (ottobre 1978) organizzato dalla Federazione regionale, in realtà, tenne fermo l’obiettivo di contrastare l’interpretazione politica e storiografica (sollecitata da Togliatti nella conferenza a Reggio Emilia su Ceto medio ed Emilia rossa) di assumere nel contesto del suo municipalismo e nel decentramento amministrativo regionale la tradizione del riformismo socialista prefascista. Il tema (Pci contro Psi in Emilia,) svolto dal relatore (uno studioso di storia sempre molto apprezzato come Nazario Sauro Onofri), fu, dunque, un ceffone bello e buono al “rinnovamento nella continuità”, la volontà di ribadire l’esistenza di uno spartiacque tra la violenza rivoluzionaria di cui il Pci era stato vittima e protagonista e la tradizione legalitaria del socialismo riformista emiliano. La conferenza di Togliatti è considerata per quello che era: cioè
“il punto di arrivo della linea antisocialista del Pci, emiliano, impostata in cui il giorno in cui questo partito fu fondato, il cui obiettivo era quello di screditare e demolire il ‘modello emiliano’, costruito dal Psi prima del fascismo e la conseguente distruzione del Psi”
nella morta gora del socialfascismo. Pertanto, la difesa e la prosecuzione dell'”aborrito riformismo socialista” dei comunisti emiliani avveniva rinnegando Togliatti. Lo stesso sindaco di Bologna, Renato Zangheri, su l‘Unità deplorerà gli “infausti attacchi al riformismo padano”.
Ma in casa socialista non verrà meno la riflessione sul fatto che il comunismo emiliano non era rosso, ma rosa, una sorta di “socialdemocrazia orientale” in quanto giustapporrà la prassi del consociativismo e la riduzione della complessità sociale al controllo dei partiti.
Non si capisce perché Creatini ricomprenda questa analisi nella tematizzazione di quella che nel suo saggio chiama il “laboratorio dell’anticomunismo”. Fu anche, in verità, anche il laboratorio in cui si dispiegarono in luce meridiana le contraddizioni, le resistenze, il rifiuto del cambiamento dei comunisti. Toni Rovatti è molto fermo nel considerare mero orgoglio di partito la dichiarazione di Zangheri e Vincenzo Galletti che per un ritorno della violenza di destra e il rilancio del fascismo (come al terrorismo rosso) in Emilia sarebbe stato eretto un muro invalicabile. La risposta sarà il massacro del 2 agosto 1980 alla stazione ferroviaria di Bologna.
Malgrado un riscontro, che temo sia più omissivo che fuggevole, dell’apporto della socialdemocrazia, il volume riesce a disegnare con un’energia che manda in frantumi le vecchie reti interpretative della stessa precedente storiografia comunista d’antan, lo schema evolutivo di nascita e sviluppo del Pci. Ne sanno cogliere gli aspetti di continuità e valorizzare anche le differenze. Non poche e sempre più rilevanti di fronte ai programmi, spesso rimasti sulla carta o molto ritardati, dei governi di centro-sinistra.
Il pragmatismo della politica economica e la débâcle del modello
La ricostruzione della politica economica e sociale (ad opera di Bruno Settis) che ha fatto da sfondo al “modello emiliano”, si ispira prevalentemente al pragmatismo. E quanto seppe fare presente il maggiore ispiratore di questo lavoro, il giovane ricercatore ravennate Pierpaolo D’Attorre. Fu un innovatore negli studi su diversi aspetti del secondo dopoguerra. Lo ricordo come un uomo di partito che non poteva fare a meno del dialogo, cioè dell’ascolto non formale né banale degli altri, soprattutto quando erano diversi. Troppo repentinamente strappato al mondo della ricerca storica che aveva avviato e agli affetti.
Colpisce la volontà di non richiudersi nelle maglie di uno schema ideologico (come per esempio la lotta ai monopoli o l’opzione per una programmazione che esautori il mercato), ma di relativizzarli valutandone ogni sostenibilità su scala regionale. Il primato è quindi dato di volta in volta alla piccola e media impresa, all’artigianato e alla cooperazione, successivamente ai settori dell’imprenditoria collettiva (dalle municipalizzate alle partecipazioni statali). Non si demonizza più come avvenne tra le due guerre alla grande impresa.
La chiave dell’orientamento dei comunisti emiliani fu la politica delle alleanze. Non solo tra i partiti, ma soprattutto tra i ceti sociali più deboli e tra gli imprenditori di qualunque grandezza nel mondo produttivo.
La centralità della classe operaia, che il Pci eresse a punto di riferimento privilegiato, in Emilia non si trasformò in un pilastro a cui tutto venisse sacrificato come la questione salariale e quindi i rapporti col sindacato. Ne sortirono tensioni a sempre meno bassa intensità che videro il partito scontrarsi con Claudio Sabbatini.
Insieme alle analisi del democristiano Ermanno Gorrieri nell’area del carpigiano, fu infatti il segretario della FIOM di Bologna a porre in evidenza la depressione salariale e le stesse condizioni della salute in fabbrica in seguito alla politica industriale di valorizzazione delle dimensioni e degli spazi medio-piccoli delle imprese privilegiata dai comunisti della Regione.
L’assemblaggio di questa imprenditorialità minore, il movimento cooperativo, l’intervento pubblico e l’americanismo alimentarono, dunque, delle contraddizioni. Esploderanno intorno alla fine degli anni Sessanta, ma, secondo Bruno Settis
“la critica alla linea sulla piccola impresa, proveniente dall’interno del partito e del sindacato, avrebbe cercato di portare allo scoperto queste contraddizioni. In modo opposto e complementare, le idee della ‘terza Italia’ e poi del ‘modello emiliano’, costruite attorno all’idea del Pci come garante del patto sociale, le cavalcarono”[29].
Lo stile bello di Settis (al quale si deve il saggio più impegnativo, compatto e alla fine demolitorio, pur essendosi l’autore limitato a far parlare la bibliografia) sprigiona un delicato aroma per non dire rudemente quel che dalla sua narrazione si può dedurre: cioè il fallimento sul piano economico e sul piano politico dei capisaldi del “modello emiliano”.
Come si poteva preservarlo da un rigoroso vaglio critico dal momento che la politica delle agevolazioni creditizie non riusciva a distinguere nel finanziamento le aziende che oltre a produrre sfruttavano; e la politica delle alleanze, invece di confrontarsi con i movimenti di trasformazione reale era vissuta attestandosi “solo sulla propaganda ideale da un lato e sul recepimento acritico di certe esigenze corporative dall’altro”?
E nella grande crisi del 1977 il partito fece qualcosa di più che manifestare un’incomprensione assoluta. Arriva, infatti, a far coincidere la sua incapacità di capire la “nuova peste”[30] (cioè i movimenti giovanili, le loro domande, la loro diversità e inassimilabilità, alla tradizionale politica comunista di ricondurre tutto ad ampliamento dei servizi sociali e delle tutele), con una terribile scelta di campo, la difesa dell’ordine con le forze a questo compito deputate.
Toni Rovatti non la deduce, ma la ricava direttamente dall’archivio del PCI presso la Fondazione Gramsci di Bologna. I comunisti bolognesi
“in consonanza con la Direzione nazionale radicalizzano l’intransigenza della risposta, autorizzano l’azione di polizia, collaborano con Questura e Procura, come se si trovassero di fronte ad un concreto pericolo terrorista, dando corpo ad una rappresentazione del movimento che individua il partito come principale avversario politico e modello da contrastare”[31].
Peggio del social-fascismo verrebbe da dire
Sull’onda delle valutazioni di Claudio Sabbatini si schierano altri sindacalisti comunisti della Cgil, ribadendole.[32]
Erano entrati nella sfera degli interessi da difendere il ceto medio produttivo (cioè le imprese piccole e medie) e sempre più i pezzi di società (soprattutto i giovani) privi di tutele e il più delle volte anche di reddito. Ma a questi “reclutamenti” corrispondeva quel che il giovane Pierpaolo D’Attorre aveva previsto: un contenimento della conflittualità sociale, l’enfatizzazione del mercato come banco di prova sia della vitalità dell’economia emiliana sia del riformismo come cultura di governo dello sviluppo, cioè una
“versione più efficiente e democratica dello stato assistenziale, piuttosto che componente importante del fronte di lotta per la trasformazione sociale e istituzionale” [33].
Settis mostra i momenti e i piani su cui avvenne questo svolgimento. E’ (falsamente) circospetto nel chiedersi alla fine se questi continui adeguamenti di linea e di mobilitazione di alleati non abbiano spogliato il comunismo emiliano di una propria identità.
Questa è un fattore indispensabile quando l’obiettivo è centrato sulla costruzione di un ordine nuovo, la trasformazione dalle radici dell’esistente. Ma dopo la grande infatuazione ideologica tale disegno o visione del futuro è diventato progressivamente un discorso post-comunista. Si adatta bene alla realtà di oggi.
Il Pci e la violenza subita e agita
Sulla base dei molti studi locali fioriti in Emilia Romagna, il Pci nasce ideato e attrezzato per far fronte a nemici di classe sempre col mitra in mano (per usare una nota espressione di Togliatti che non negava, ma respingeva, che questa fosse l’unica cosa che i comunisti sapessero fare) per contrastare padronato agrario e industriale, fascismo e Democrazia cristiana[34], identificata in maniera superficiale con i primi due).[35]. Spesso fu una necessità, si badi bene, non una scelta ricorrere alle armi (di offesa e difesa), rifugiarsi nella clandestinità, inerpicandosi in un iter tortuoso di privazioni della libertà e perdita del lavoro, di infinite condanne al carcere e all’emigrazione.
Dati e testimonianze fornite sono significativi. Mi pare, però, che nelle responsabilità sulle origini del fascismo andavano assecondate le analisi di Roberto Vivarelli e di Serge Noiret sul ruolo tutt’altro che modesto del massimalismo socialista[36]e, per quanto non di minore rilievo fino al 1924, degli stessi comunisti.
La loro è stata un’incessante guerra di resistenza e di vera e propria guerriglia contro la rivoluzione fascista e imprenditoriale che ad un certo punto marciarono unificate.
Il Pcd’I nacque e si sviluppò legando, per un lungo periodo di tempo, il tema pervasivo della violenza a bisogni e momenti diversi: dalla lotta al fascismo, alla guerra di Spagna, alla Resistenza; dai rapporti con la classe operaia ai ceti non facili del mondo contadino; dalla salvaguardia della propria unità intessuta di solitudine e isolamento all’esigenza, stabilita dal VII congresso dell’Internazionale nel 1937, di creare alleanze ampie, non ideologicamente conformi, ma utili dando la priorità all’antifascismo. Ha che fare con la violenza lo stesso controllo dei militanti, l’educazione alla disciplina, la lotta per colpire spie e disertori, ed isolare o emarginare chi deborda nell’estremismo e nel farsi vendetta da sé.
Saranno le vicende delittuose, i molti episodi di giustizia sommaria, legati al “triangolo della morte” (compreso tra le province di Modena, Reggio Emilia, Bologna, Ravenna e Ferrara) nel 1947-1948 a segnalare come il mito della rivoluzione sovietica e l’esempio di Stalingrado, non trovando se non una parziale soddisfazione negli atti di governo del Pci avesse riaperto un varco nella base del partito a radicalismi e strascichi puramente vendicativi. Una sorta di risposta alle moltissime violenze subite nel 1919-1920[37].
Il partito ebbe un disegno anti-capitalistico e un modello che – non esclusivamente, ma in molta parte dei suoi dirigenti- è stato a lungo assimilabile a quello di Lenin e dei bolscevichi. In Urss non pochi leader, diventati comandanti militari, commissari politici e poi dirigenti di partito o anche (ma meno) amministratori, erano vissuti anche lungamente. Poiché nel volume non ce n’è traccia, mi chiedo come sia possibile che da essi non sia pervenuta una memoria o una parola di critica del libero arbitrio nell’esercizio della violenza dominante nella patria della dittatura del proletariato.
Questa identità, modo di essere, di credere e di combattere copre il lungo lasso di tempo tra le due guerre mondiali.
Quasi tutti collaboratori (in particolare Paolo Capuzzo, Andrea Ventura e Toni Rovatti) di questa importante raccolta squarciano in profondità il mondo di rivoluzionari professionali non di rado non rinvenibile, se non sconosciuto, nella storia e nelle fila dei socialisti. Sulla scorta di Baldissara sanno distinguere tra massimalismo e bolscevismo, tra fondatori e costruttori del partito, tra il susseguirsi delle generazioni (le esperienze politiche e di lavoro e il carico di sacrifici di chi è costretto a continuare in Spagna, Francia, Belgio, Unione sovietica, Stati Uniti, esperienze e tecniche di lotta).
Soprattutto durante il fascismo, la guerra di liberazione e nei primi anni del dopoguerra il ricorso al terrorismo individuale o collettivo, come nelle esperienze delle Sap e dei Gap, o nel cosiddetto “triangolo della morte” le campagne (non sempre coperte dal Pci) di rivalsa e vendetta per le violenze subite nella furiosa lotta di classe del primo dopoguerra ha in Toni Rovatti una narrazione non facile, ma complessivamente equilibrata.
Tra gli anni Sessanta e Settanta ha luogo una svolta significativa. La prima generazione comunista vede i suoi protagonisti uscire di scena, e due eventi inattesi (il dispiegarsi di un positivo trend elettorale del partito con l’apice del 1976 e la prospettiva di governo) inducono i comunisti a sostituire la lunga e tormentata riflessione sulla violenza in cui il partito era nato e vissuto su un progetto di riforma dello Stato.
Al seguito di Gramsci (che rifletteva su una sconfitta epocale) il volume cerca anche di capire quel che di nuovo (nel corporativismo, nelle diverse forme di intervento dello Stato in economia) sembra maturare nel fascismo e nello stesso capitalismo sotto i colpi delle grandi crisi, in particolare degli anni Trenta.
La ricostruzione di Baldissara è per la prima volta ampia, senza scrupoli né pudori, e anche insolitamente efficace per intendere il cumulo di speranze millenarie (e millenaristiche) e pesanti disillusioni che pervasero le origini della principale forza della sinistra italiana.
Continuano, però, ad essere accennate e lasciate inspiegate le ragioni per cui la civiltà auspicata dall’evangelismo socialista di Camillo Prampolini e compagni, e costruita da Andrea Costa, Anselmo Marabini, Giacomo Matteotti, Filippo Turati e dai leader della cooperazione venga travolta e sostituita, città o per città, dall’infuriare e rassodarsi del devastante maestrale comunista.
Essi avevano saputo mettere a punto nell’uso delle leggi le aperture politiche dei governi liberali, spianando la strada successivamente a molte delle realizzazioni dei governi locali comunisti.
Né si ama ricordare che lo stesso Togliatti non seppe indicare che cosa avrebbe potuto esserci di meglio, al di là e oltre le pratiche di governo di Giovanni Giolitti nei profili che ne redasse nel secondo dopoguerra, si potrebbe aggiungere, dei programmi che furono al centro della collaborazione del Psi con la DC[38]. Non è un caso che né gli studi sullo statista piemontese né sulla sinistra italiana e tedesca di un vecchio, sempre indipendente, storico comunista come Massimo L. Salvadori, abbiano meritato neanche un richiamo bibliografico salvo quello isolato e generico.
Un’illusione: la riformabilità dell’Urss
Al loro ritorno dopo una lunga permanenza e educazione in Urss[39] (al quale è dedicato il saggio del secondo curatore, Paolo Capuzzo, direttore della Fondazione Gramsci di Bologna) quale cultura di governo (soluzioni finali e programmi) i dirigenti del PCI emiliano avevano portato con sé, applicandoli alla loro regione?
Detto in altre parole, oltre a un regime carcerario implacabile, a uno Stato di diritto mai perseguito e mai nato e a un regime politico-istituzionale che non ha mai consentito dibattiti, critiche, alternative, in funzione dell’incremento dei diritti civili dei cittadini sovietici, gli antifascisti e i comunisti (che tra il 1922 e il 1945 optarono per la cittadinanza o la sola residenza in Urss) che cosa hanno ereditato, e proposto in Emilia Romagna, sul piano dei programmi, delle riforme delle trasformazioni inizialmente millenaristiche?
La domanda nasce dal grande rilievo che ebbe l’illusione dei comunisti emiliani, come dell’intera leadership comunista nazionale, cioè che il modello di Stato e società civile (assorbite nel totalitarismo) di fattura sovietica potesse essere riformato.
Fin dall’inizio fu questa la certezza di Gramsci, salvo negli anni Trenta fare una descrizione del vecchio “Stato operaio” (come gli ordinovisti amarono chiamare l’Urss) che nell’analisi ravvicinata di Silvio Pons viene sintetizzata nel termine (gramsciano) di neo-bonapartismo.[40]
Credo che la mitizzazione di questa possibilità sia presente ancora oggi in moltissimi dei dirigenti e negli intellettuali della Fondazione Istituto Gramsci, e li trattenga dal praticare un sano ed elementare anticomunismo.
Equivale alla stessa domanda chiedere come mai i comunisti, malgrado la loro forza elettorale e l’insediamento territoriale diffuso, non sono mai riusciti a dare vita a uno stuolo di ministri e di tecnici di grande competenza come quelli socialisti (penso a Riccardo Lombardi, Giuliano Amato, Giorgio Ruffolo, Luciano Cafagna, Giuliano Vassalli, Antonio Giolitti, Federico Mancini, Gino Giugni, Francesco Forte, Gianni De Michelis, eccetera)? Come mai i dirigenti emiliano-romagnoli hanno contato così poco nella leadership politica del Pci, ma hanno avuto un ruolo significativo solo nel sindacato, nella cooperazione e in generale nei comparti organizzativi e gestionali? Nessun personaggio di rilievo si può ricordare tra gli economisti.
Il centralismo democratico: una cultura
Un altro limite di questo lavoro riguarda l’esame della democrazia interna, cioè dei metodi per costruire il consenso e promuovere-alternare i gruppi dirigenti nel Pci. Se nella Dc e nel Psi fu una prassi spesso irruente e non facile da disciplinare, nel mondo comunista operò come strumento di filtro (per rendersi conti della misura del consenso della base degli iscritti alla linea del gruppo dirigente) e di controllo.
C’era un modo di evitare la formazione di una vera e propria nomenklatura che si è perpetuata nei decenni? Non solo in seno al gruppo dirigente, ma negli stessi enti culturali ed amministrativi, dove un uso prolungato del potere e della prassi delle cosiddette “porte girevoli” era, ed è, diventata una regola. Analogamente, va detto subito, a quanto è avvenuto in altri partiti.
Il tema ha scalato, dopo la prima metà degli anni Settanta, i primi posti della graduatoria delle riforme perseguite dal partito. Il fascicolo pubblicato da Il Mulino, che – per la penna di chi scrive allora ancora munito di una tessera di iscrizione al Pci – aveva dedicato un’analisi ravvicinata, su richiesta rivoltagli dal direttore Arturo Parisi, a L’austero fascino del centralismo democratico. Venne ristampata più volte.
Non era mai accaduto prima. Ma segnava l’epilogo dell’atteggiamento di moderazione, in un contesto di tenace e non plebeo anticomunismo, che la rivista e la stessa casa editrice (legata ai democratici americani e alla loro cultura politologica), avevano saputo mantenere sulle questioni interne del Pci.[41]
Nell’episodio che sto citando conta l’origine di esso. Le riedizioni furono determinate, infatti, dalla richiesta massiccia fatta all’editore bolognese dagli stessi esponenti comunisti che preparavano le tesi congressuali. Ed Enrico Berlinguer affidò ad uno storico di prestigio a lui molto vicino come Giuliano Procacci, una prima valutazione critica dell’argomento ospitata sulla rivista Critica Marxista.[42]
Il paradigma del marxismo terzinternazionalista
Nel volume non si ha, nell’insieme, nessun interesse anche per un argomento cruciale come la lettura del marxismo della Seconda e della Terza Internazionale.
L’opzione, senza bisogno di farvi riferimento, è scontata, va alla Terza. Pertanto a prevalere in questa importante ricerca storica circoscritta alla regione emiliana non è il tema del quando e come fare la rivoluzione, ma quello della soggettività, della coscienza antagonistica. Da Lenin a Gramsci in avanti, fu separato dall’analisi del livello dei fattori di produzione, cioè dallo sviluppo-crisi del capitalismo.
Di qui nacque la vecchia litania (diventata paradigma ideologico) che a predisporre il socialismo riformista alla sconfitta (e al tradimento, preciseranno per decenni i comunisti) sia stato il marxismo della Seconda Internazionale. Esso avrebbe dato vita a quella concezione fatalistica, deterministica che è stata vilipesa (soprattutto da Gramsci) come il carattere perspicuo del socialismo prefascista, non rivoluzionario.
Non c’ è collaboratore o dirigente della Fondazione Istituto Gramsci che non la esibisca ad ogni piè sospinto con l’intenzione di valorizzare nella narrazione storica di questi eventi l’atto, il fatto, la decisione contro le teorie e le parole, e lo stesso Marx de Il Capitale
Mi pare che in questo modo si vogliano giustificare due eventi che, malgrado l’enorme distanza temporale, qualche inquietudine e scrupolo dovrebbero suscitare anche negli studiosi. Da un lato i protocolli delle intese di tipo neocoloniale, tra Ribbentropp e Molotov nel 1939[43] e, dall’altro, l’inesausto – almeno dal 1921 al 1979 – fiume di rubli-dollari che hanno alimentato anche la pretesa “diversità” del Pci rispetto al Pcus.
Questo massiccio sostegno finanziario esterno, anche per via della sua durata, non è stata una solidarietà fraterna tra compagni, ma il calco di un’identità che è andata ben oltre le differenze che gli italiani disordinatamente hanno pensato di inventare e di attribuirsi. Tra di esse non è mai apparsa una presa di distanza dalla visione antagonistica delle lotte operaie e contadine e dalla lettura del marxismo in termini leninisti.
Il salto in avanti sarebbe stata la rottura introdotta dai bolscevichi nel privilegiare rispetto alla crescita dei fattori produttivi l’iniziativa concreta e immediata, cioè lo sviluppo della soggettività operaia nel percepire come insopportabili e da rifiutare le condizioni del lavoro e della produzione, cioè il comando capitalistico.
E’ quanto, secondo Lenin e Gramsci, sarebbe avvenuto in Russia e in Italia. A mobilitare e far ribellare il proletariato sarebbero stati non l’intreccio catastrofico tra maturità e crisi del capitalismo, ma le condizioni e i problemi del dopoguerra e soprattutto l’accentuata consapevolezza dello sfruttamento, insieme alla spinta a farla finita con la rassegnazione e le elezioni delle grandi masse. Questo è il presupposto, per non dire il paradigma, della Terza Internazionale.
A riassumerlo con grande efficacia e tempestivamente è il noto commento di Gramsci sull’Avanti! sul 1917 come “La rivolta contro Il Capitale”. Non concerneva solo la ribadita condanna dei socialisti ossessivamente attestati nella ricerca dei fattori di un capitalismo maturo, mentre il primato, invece, andava affidato alla reattività sociale degli operai e dei contadini, cioè al livello di consapevolezza dell’antagonismo.
Contro i menscevichi Gramsci la “dittatura del proletariato di Lenin
E’ con questa inedita lettura del marxismo che si penserà giustificare quanto storicamente ne è derivato, cioè le terribili forme dittatoriali assunte dal potere in Urss, il che ha significato il dispotismo del partito-Stato. Esercitato a livello di massa, contrassegna il governo di tutte le esperienze comuniste. Di qui trae origine l’illusione tragica che il socialismo dalle forme intimidatorie, violente e oppressive, fosse un momento di passaggio, un errore non enfatizzabile, un’escrescenza correggibile e non un male assoluto.
Fu lo stesso Gramsci con questo ragionamento a venire incontro a Lenin quando, dopo le elezioni del gennaio 1918, anticipando una vocazione direi genetica del comunismo, il leader dei bolscevichi sciolse l’Assemblea costituente in cui il suo partito era risultato minoritario. Abolì la libertà di stampa e di riunione, perpetrando una vera e propria sopraffazione della minoranza (da lui rappresentata) sulla maggioranza dei menscevichi.
Il loro leader Julij Martov affidò la sua protesta a una lettera pubblicata dalla stampa socialista che segnalava al mondo l’inaffidabilità di Lenin. A imporsi in lui e nei suoi successori fu la sindrome del giacobinismo.
La vicenda avrà un rilievo storicamente decisivo. Commentandola[44], Gramsci la considerò poco significativa in quanto la Costituente (che nel 1937 raccomanderà al suo partito come la prima manifestazione popolare del post-fascismo) sarebbe stata una forma vecchia e decrepita di espressione della volontà popolare.
In altri termini, la rappresentanza propria del parlamentarismo liberale e occidentale ai suoi occhi era una ben misera cosa rispetto a quella manifestatesi ben più sovranamente nei Soviet. In secondo luogo la giustificava perché il ricorso alla violenza da parte di Lenin e dei bolscevichi sarebbe stato un atto contingente, una parentesi, un’eccezione che non si sarebbe ripetuto. I bolscevichi erano minoranza nel momento presente, in una dimensione temporale assolutamente contingente, ma nel futuro erano destinati a
“diventare maggioranza assoluta, se non addirittura la totalità dei cittadini”.
Dunque, per Gramsci il comportamento usurpatorio dei bolscevichi non era da considerare l’opzione per una “dittatura perpetua”. Un investimento sul futuro dell’esercizio della violenza politica non faceva parte del programma della rivoluzione socialista perseguita da Lenin.
Questo intermezzo della dittatura proletaria secondo Gramsci sarebbe servito a reprimere le forze contro-rivoluzionarie che impedivano la trasformazione del Paese; e in secondo luogo a rendere possibile quella che era sembrato irrealizzabile[45]. L’utopia di cui scrive era il consolidamento dello Stato dei Consigli, cioè la nuova architettura del potere
“in cui la dittatura si dissolverà, dopo aver compiuto la sua missione”.
Fu l’espace d’un matin, in cui democratici e totalitari si misurarono e separarono fino a metà degli anni Trenta le loro strade.
Jan Palach l’eroe negativo’ di Zangheri
Emblematica fu la vicenda dello studente universitario di 21 anni Jan Palach. Il 16 gennaio 1969, in piazza San Venceslao a Praga, preferì cospargersi di liquido infiammabile e darsi fuoco per protestare contro l’occupazione dell’Armata rossa.
Dalle istituzioni politiche dell’Emilia Romagna non si levò nessuna voce di solidarietà, se non di commiserazione anche sommessamente venata di un velo di sarcasmo.
Il sindaco di Bologna Renato Zangheri lo bollò, con sentenza inappellabile emessa dalle sale papaline illustrate e sinuose di Palazzo d’Accursio, come “eroe negativo”. Il suo gravissimo errore, e colpa, sarebbe stata di non avere fiducia nel fatto che dopo l’intervento armato dell’esercito sovietico, a Praga sarebbero arrivate tradotte colme di fiori, rampicanti e piante esotiche a indicare che il regime si era emendato e il governo si sarebbe mosso sul sentiero del rispetto delle libertà e dei diritti anche delle minoranze. Intendeva, cioè. far credere che nei manufatti istituzionali creati dall’Unione sovietica in Europa dopo la seconda guerra mondiale fosse possibile esercitare il diritto di critica come nelle esecratissime democrazie occidentali.
Ian Palach preferì, invece, togliersi la vita piuttosto che essere vittima consenziente di quello che i comunisti italiani non osavano ammettere e denunciare: l’esistenza a Praga (cioè nel cuore del totalitarismo comunista) di un fantoccio di democrazia politica.
L’episodio che ho ricordato sintetizza la fiducia (speranza o illusione che fosse) serbata a lungo dai dirigenti comunisti emiliani sulla riformabilità del sistema politico dell’Urss, cioè sulla sua democratizzazione.
Nella scuola sovietica del comunismo
Paolo Capuzzo affronta con acribia l’argomento cruciale dei rapporti con i bolscevichi e in generale con l’Unione sovietica, le scuole di formazione ideologica e politica dei “rivoluzionari professionali”, l’addestramento militare, la forma zione della militanza eccetera. Ne deriva -come nel caso del saggio di Baldissara – uno spaccato efficace che coinvolge le biografie (utilissime) di molti dirigenti emiliani e romagnoli.
Il fatto che i compagni segnati da una severa educazione ideologica e di una disciplina che arrivava fino al sacrificio della vita (e quindi all’accettazione delle accuse, delle torture e delle stesse violenze fisiche da parte delle autorità di polizia sovietiche) siano rimasti alla testa del partito anche dopo la seconda guerra mondiale confermerebbe un’interpretazione avanzata ma non molto diffusa.
Essa consiste nel ritenere che dopo la Resistenza il Pci avrebbe inaugurato un secondo ciclo rivoluzionario. La formazione nelle scuole, nei centri, come nelle carceri sovietiche di questi compagni tornava utile per far fronte ad un processo rivoluzionario che era stato non escluso, ma semplicemente differito.
La domanda alla quale il volume non mi pare risponda in maniera convincente, e parziale, è la seguente: questi rivoluzionari professionali come poterono, finita la Resistenza, essere tenuti alla testa di organi (non importa quanto minori) o riciclati in funzioni non centrali del “partito nuovo” quando la loro formazione politica si era svolta nella lotta senza quartiere contro il capitalismo e la stessa democrazia politica, che solo alla fine della guerra di liberazione Togliatti fece propria? Non solo capitalismo e democrazia politica, ma anche e soprattutto tutta la storia del socialismo riformista erano ai primi posti nella loro lista di proscrizioni e ostilità.
Era tanto il disegno (mai prospettato) del “modello emiliano” ad appassionarli e muoverli oppure l’attesa del “secondo tempo”, del “momento buono” per fare come in Urss? Si trattava di completare il lavoro che si era portato a termine con la cacciata de nazifascisti.
Mi pare indispensabile il riferimento al trend delle iscrizioni al partito. Il loro improvviso incremento straordinario non è opportuno attribuirlo esclusivamente ai legami con le grandi masse popolari contratti durante la Resistenza. Da 6-7 mila iscritti nel 1943 balzano a 1.899 mila nel 1945 fino a toccare 2.252 mila nel 1947. Gli emiliani oscillano rappresentando oltre il 20 per cento, più precisamente 345 mila del 1945 e 436 mila nel 1947 fino a lievitare a 480 mila del 1955.
Probabilmente questi trasferimenti inizialmente debbono molto anche alla paura da cui sono pervasi i vecchi tesserati al PNF di essere arrivati al capolinea. Di qui la massiccia opzione a favore di chi rappresentava una grande potenza vincitrice, risulta essere il più presente e armato, cioè il Pci. La defascistizzazione e il delinearsi dei nuovi rapporti internazionali sicuramente lo favorì.
L’apparato para-militare: il braccio armato di una rivoluzione differita?
La precedente domanda rispecchia un’idea, anzi una convinzione che le analisi della polizia e dei servizi segreti (comprese le autorità degli Stati Uniti)[46] faranno a lungo propria, cioè che il Pci non avesse archiviato, ma solo differito la politica della conquista del potere che dal 1919, su disposizione del Comintern, prevedeva il ricorso alle armi.
Di qui la decisione di munirsi di una sorta di esercito di riserva, con epicentro l’area del Modenese, per lo più fondato sul personale che aveva combattuto la guerra di Liberazione[47]. Il suo impiego era destinato anche all’eventualità in cui il partito fosse stato messo in pericolo da operazioni restrittive degli spazi di democrazia di cui aveva goduto, oppure da situazioni eversive o da colpi di stato dell’estrema destra.
Non siamo in presenza della costruzione di un reato penale da parte dei nostri servizi segreti. Com’è noto negli anni Cinquanta ne fecero una estesissima relazione per il Ministero dell’Interno. Ad essa fecero seguito, o vennero precedute, da analisi e rapporti dei servizi anglo-americani[48]. Su di esse ho richiamato distesamente l’attenzione in un volume.[49]
Siamo in presenza, invece, della cosiddetta “politica della “doppiezza”. Purtroppo ad essa, sia anche per contestarla sulla base di eventuali risorse documentarie, curatori e collaboratori negano ogni rilievo. Si finisce così per ridicolizzarla come un’invenzione degli avversari, quasi che il disconoscimento progressivo della violenza che ha luogo nel PCI dopo la “svolta di Salerno” e la teorizzazione togliattiana del “partito nuovo”, non siano stati fattori essenziali per la sua progressiva legittimazione democratica.[50]
All’argomento della “doppia lealtà” viene dedicato uno spazio inadeguato e temo prevalentemente di carattere controversistico. Salvo ammettere quel che Luciano Casali aveva anticipato[51] e Toni Rovatti nel suo saggio ribadisce scrivendo che
“in Emilia Romagna il confronto con il sovversivismo- una dimensione sociale della violenza, caratterizzata da estremismo e autonomia decisionale dal basso, che si presenta quale cifra specifica della storia (e dell’immagine) del territorio – appare imprescindibile per il governo della società nel contesto regionale”[52].
E non esita a parlare di un fiume carsico (quello della violenza) che si sviluppa di fronte ai molti aspetti delle sopraffazioni.
Non sembra che la strada per una nuova e non (facilmente) contestabile storiografia sul Pci possa essere lastricata dal negare anche occasionalmente i problemi, far finta che non esistano. Questo approccio è stato in passato, attraverso i suoi organi dedicati alla ricerca storica, un aspetto della linea di condotta del PCI. Il continuismo non è, però, mai stato una buona regola.
Sfuggente e parziale è anche il giudizio di estrema condanna dei socialisti, soprattutto riformisti (giudizio a cui segue una forma – tipica come quella accordata dai vincitori ai perdenti – e la cauta “riabilitazione” del secondo dopoguerra.
Dico cauta perché, dopo le recriminazioni e gli attacchi di Gramsci, anche nelle ammissioni di Togliatti resta l’accusa al Psi di non aver assecondato il processo rivoluzionario del primo dopoguerra. Una situazione che per la verità i socialisti hanno sempre negato e la stessa storiografia, facendo i conti con l’imperante sovversivismo rilevabile nel postbellico in Europa e in Asia, sembra condividere.
L’ibridazione della democrazia politica ha sedato gli estremismi
A mio avviso, la faglia che in Italia ha segnato a lungo la differenza tra socialisti e comunisti, rendendoli diversi, quando non antagonisti, anche nei periodi di lunga collaborazione governativa, è la maggiore o minore misura temporale in cui sono vissuti in un sistema di democrazia politica. Accettando di esserne ibridati.
Il PSI è nato e maturato in una fase storica del Diciannovesimo secolo in cui un leader come Giovanni Giolitti aveva ampliato le basi dello Stato di diritto riconoscendo ai socialisti libertà di organizzazione politica, sindacale e di stampa, l’accesso ai finanziamenti per mutui e cooperative, la legittimità di battersi per adeguati incrementi salariali eccetera. Senza ottenerne in cambio, occorre sottolinearlo, l’accettazione della democrazia fondata sul parlamento né la rinuncia ad un massimalismo spesso solo inconsulto, becero e parolaio. Ma la possibilità di esercitare la lotta di classe, e l’opposizione nelle aule parlamentari, come il poter governare molte amministrazioni locali ed essere il garante nei luoghi di lavoro dell’autonomia operaia fu un esito attribuibile all’aver potuto vivere in una democrazia politica. Pur con limiti gravi, nelle elezioni del 1919 consentì ai socialisti di avere il maggiore successo elettorale, un eccezionale numero di eletti nella Camera dei deputati, ma anche nei comuni e nella filiera delle cooperative eccetera. Fino a indurre Giolitti a cercare di cooptare Filippo Turati nella coalizione di governo.
Nati nel 1921, i comunisti subiranno gli inconvenienti della crisi economica del dopoguerra e della lunga guerra civile (dalle lotte del 1919-’20 al ventennio fascista), del terrorismo (anche di Stato), delle discriminazioni e dell’emigrazione per sopravvivere. Furono ferite gravissime che portarono a forme di autodifesa e di rivalsa a mano armata.
Questo diverso contesto spiega perché il militante comunista fu radicalmente diverso dal militante socialista e la ragione per cui il primo che non esitò ad assimilare il secondo al suo peggiore nemico, cioè ai fascisti, e decretarne la politica dell’eliminazione.
L’organo internazionale di cui il PCd’I scelse fin dal 1921 di far parte (il Comintern) aveva sancito, per tutte le sue sezioni nazionali, il principio che l’azione per abbattere il capitalismo e il suo regime politico esigevano, programmaticamente, il ricorso alle armi. La prassi della violenza rivoluzionaria non fu, dunque, occasionale, ma sistematica.
Quando dopo il 25 aprile 1945, i comunisti vissero in un regime politico liberal-democratico assai avanzato, ne subirono positivamente le conseguenze come i socialisti durante l’età giolittiana. Poterono conseguire degli obiettivi insperati come essere la maggiore forza di opposizione nelle due Camere, assumere la direzione di migliaia di Comuni e Province, essere i protagonisti dei negoziati sui salari e sulle forme di potere nelle fabbriche, e addirittura di continuare indisturbati a ricevere il finanziamento proveniente (prima mensilmente e poi trimestralmente) dall’Unione sovietica. Il vecchio partito della rivoluzione si trasformò progressivamente nel partito delle riforme. E poco, ben poco, lo ha differenziato dalla socialdemocrazia, di cui fu una variante storica.
Vale la pena di chiedersi che cosa sia rimasta anche di questa variante.
A Bologna un ceto beneficiato come quello degli idraulici non ha ombra di dubbio sulla liceità di offrirti un lavoro e un compenso alla macchia, cioè illegali (“Guardi, se mi paga cash sono 200 euro, se vuole la ricevuta fiscale sono 250 euro alle quali va aggiunta l’Iva”)? Analogamente sia gli elettricisti, i falegnami, i tecnici delle antenne televisive, eccetera, sia l’universo delle piccole imprese, anch’esse sui picchi della bandiera del Pci. Non sembra l’Emilia, ma l’inferno delle indulgenze sulla legalità di Santa Teresa di Gallura, in Sardegna.
[1] Si veda, dopo quella fatta da Angelo Tasca, la rilettura dei documenti ad opera di Antonella Salomoni, Il Protocollo Segreto. Il Patto Molotov-Ribbentrop e la falsificazione della storia, Bologna, Il Mulino, 2022, 280 p.
[2] Il comunismo in una regione sola? Prospettive di storia del Pci in Emilia Romagna, a cura di Luca Baldissara e Paolo Capuzzo, Bologna, il Mulino, 2023. Vi hanno collaborato Andrea Ventura, Toni Rovatti, Federico Creatini, Teresa Malice, Bruno Settis, Roberta Ventresca e Marica Tolomelli.
[3].Federico Creatini, “L’Emilia-Romagna: un laboratorio dell’anticomunismo nel lungo dopoguerra”, in: Il comunismo in una regione sola?, op. cit., alla nota 2pp. 269-321; Toni Rovatti, “Repressione, eversione e uso consapevole della forza. I comunisti e la violenza”, ibidem, pp 211-269.
[4]Si veda “Diseguaglianze Diversità. There is an Alternative”, Pandora Rivista, 30 agosto 2019, in cui compare l’intervista resa dallo studioso ed ex ministro Fabrizio Barca.
[5] Bruno Settis, “Al governo dello sviluppo. Industrialismo, comunismo e conflitto dalla Ricostruzione all’autunno caldo”, in: Il comunismo in una regione sola?, op. cit. alla nota 2, pp.363-423.
[6] Roberto Ventresca, “Territorio, Europa, comunismo”, ibidem, pp. 423-457.
[7] Luca Baldissara, “Per una storia dell’esperienza comunista in Emilia-Romagna”, ibidem, pp. 93-165.
[8] Andrea Ventura, “Rispondere con la disciplina alla disciplina, con le armi alle armi. i comunisti di fronte all’uso della forza (1921-1945)”, pp. 163-211.
[9] L’ha documentano anche il saggio di Giovanni Marongiu, Una storia fiscale dell’età repubblicana, Torino, Giappichelli, 2017.
[10] Si veda la ricostruzione del suo iter di studioso ed esponente politico presso la Treccani ad opera di Guido Melis, “Paolo Fortunati”, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 49, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1997, 829 p..
[11] Per una prima illustrazione si veda, Bologna futuro. Il “modello emiliano” alla sfida del XXI secolo, a cura di Carlo De Maria, Bologna, Clueb, 2012, 208 p.
[12] Cf. «Libro Bianco su Bologna». Giuseppe Dossetti e le elezioni amministrative del 1956. Con saggi di Luigi Pedrazzi, Paolo Pombeni e Luigi Giorgi, a cura di Gianni Boselli, Reggio Emilia, Diabasis, 2009, 251 p.
[13] A richiamare questa contro-cultura è il saggio, citato alla nota 3, di Federico Creatini, “L’Emilia-Romagna: un laboratorio dell’anticomunismo nel lungo dopoguerra”, avvalendosi dell’ampia saggistica su Dossetti di Paolo Pombeni, e di un saggio di Gianni Boselli. Di questo saggio di Creatini si vedano in particolare le pp. 306-309.
[14] “Diseguaglianze Diversità. There is an Alternative”. Intervista a Fabrizio Barca, Pandora Rivista, loc. cit. alla nota 4.
[15] Sia quello più recente: Paolo Favilli, Il marxismo e le sue storie. Contributi di Piero Bevilacqua, Fabio Mussi e Leonardo Paggi, Milano, Franco Angeli, 2016, 222 p., sia quello più noto su scala non locale: Paolo Favilli, Marxism and Historiography. Contesting Theory and Remaking History in Twentieth Century Italy, Cham (Svizzera), Palgrave McMillan,
Springer International Publishing, 2021. E’ il caso di ricordare che nel mondo degli studi (e a breve anche della stessa sterminata Cina), Favilli è noto per un’originale e fortunata rilettura critica di Marx. Crea, pertanto, qualche imbarazzo e curiosità che la sua allieva prediletta, nel liceo cittadino di Lugano, Elly Schlein, non sembri averla ancora letta e fatta propria, almeno sul piano della conoscenza. Lo farà dopo che il segretario della Repubblica popolare cinese, Xi Jinping, avendone di recente autorizzato la traduzione anche per i molti milioni di suoi compagni, glielo avrà in maniera felpata e sorniona, suggerito?
[16] Mussi ne offre una preziosa e intelligente memoria vissuta. Direi che uno scrosciante sarcasmo da toscanaccio fa velo, ma non fino ad ovattare il compito di raccontare il funerale dei compagni sopravvissuti ad un epocale naufragio.
[17] Per una descrizione attenta e una riflessione storiografica originale dei due aspetti si veda il saggio di Serge Noiret, Massimalismo e crisi dello Stato liberale. Nicola Bombacci (1879-1924), Milano, Franco Angeli, 1991, 608 p.
[18] Franco Mosconi, Modello Emilia. Imprese innovative e spirito di comunità, Prefazione di Stefano e Vera Zamagni, Padova, Post editori, 2023, 272 p. Si veda alche il recente lavoro di Guido Caselli, Vicesegretario Generale Unioncamere Emilia-Romagna,
[19]Franco Mosconi, Modello Emilia. Imprese innovative e spirito di comunità, op. cit. alla nota 18, p.16.
[20] Cfr. Banca d’Italia, “L’economia dell’Emilia-Romagna. Aggiornamento congiunturale”, (30), novembre 2022.
[21] Franco Mosconi, Modello Emilia…, op. cit. alla nota 18, pp.173-174 e Cfr. Banca d’Italia, “L’economia dell’Emilia-Romagna. Aggiornamento congiunturale”, loc. cit. alla nota 20.
[22] Un apporto conoscitivo maggiore è stato reso disponibile dai lavori curati da Carlo De Maria, ma non ha trovato grande udienza.
[23] Antonio Tatò, Caro Berlinguer. Note e appunti riservati (1969-1984), Torino, Einaudi, 2003, XLII-336 p.
[24] Franco Piro, Comunisti al potere. Economia, società e sistema politico in Emilia – Romagna (1945-1965), Padova, Marsilio, 1983, 236 p. e Franco Piro “La critica socialista al ‘modello emiliano’”, E-Review. Rivista degli Istituti storici dell’Emilia-Romagna in rete, (1) 2013.Cf https://e-review.it/piro-una-critica-socialista-al-modello-emiliano.
[25]Leonardo Paggi e Franco d’Angelillo, I comunisti italiani e il riformismo. Un confronto con le socialdemocrazie europee, Torino, Einaudi, 1986, XXI-219 p. Il saggio del Nuovo Politecnico è fruibile online. Cfr. https://docenti-deps.unisi.it/wp-content/uploads/sites/26/2016/02/Paggi-I-comunisti-italiani-e-il-riformismo.pdf.
[26] Valerio Evangelisti e Salvatore Sechi, Il galletto rosso. Precariato e conflitto di classe in Emilia – Romagna (1880-1980), Venezia, Marsilio, 1982, VIII-192 p.
[27] Tra i molti interventi di Leonardo Rapone, La socialdemocrazia europea tra le due guerre. Dall’organizzazione della pace alla resistenza al fascismo, Roma, Carocci, 1999; 432 p. e “La crisi finale dell’Internazionale operaia e socialista”, in I socialisti e l’Europa. Annali della Fondazione Giacomo Brodolini, 2, Milano, Franco Angeli, 1989, 628 p. [il saggio è alle pp. 37-93]. Si vedano anche Mario Telò, “Il governo dell’economia e problema dello Stato nel planismo belga e francese”, in Aldo Agosti et alii, Esperienze e problemi del movimento socialista tra le due guerre mondiali, Milano, Franco Angeli, 1987, 344 p. [il saggio è alle pp. pp. 117-152]. Simone Neri Serneri, Democrazia e Stato. L’antifascismo liberaldemocratico e socialista dal 1923 al 1933, Milano, Franco Angeli, 1989, 320 p., Mario Telò, La socialdemocrazia europea nella crisi degli anni Trenta, Milano, Franco Angeli, 1985, 336 p; Amedeo Cottino, La socialdemocrazia svedese, Milano Franco Angeli, 1980, 96 p. e, infine, Michel Brélaz, “Henri de Man: une autre idée du socialisme”, Vingtième siècle. Revue d’histoire, (11) novembre 1986, pp. 153-154 (numero speciale: Nouveaux enjeux d’une décennie: fascismes, antifascismes, 1935-1945).
[28] Fausto Anderlini, “La metamorfosi di Luciano Canfora, Nuova Atlantide.org, 22 aprile 1921. A proposito del saggio di Luciano Canfora, La metamorfosi, Bari Laterza, 2021, 96 p. Cf. https://www.nuovatlantide.org/la-metamorfosi-di-luciano-canfora/.
[29] Bruno Settis, “Al governo dello sviluppo. Industrialismo, comunismo e conflitto dalla Ricostruzione all’autunno caldo”, in: Il comunismo in una regione sola?, op. cit. alla nota 2, p. 363.
[30] Ho esaminato il fenomeno nel saggio, Salvatore Sechi, “Il PCI: l’albero, la foresta e la nuova peste”, il Mulino, XXVII (2) marzo- aprile 1977, pp. 274-302.
[31] Toni Rovatti, “Repressione, eversione e uso consapevole della forza. I comunisti e la violenza” in: Il comunismo in una regione sola?, op. cit. alla nota 2, pp. 263-264.
[32] Francesco Garibaldo, Tiziano Rinaldini e A. Zappelli, “Un’analisi dell’impresa minore in Emilia. Ristrutturazione capitalistica e sfruttamento operaio”, Fabbrica e Stato I (2), marzo-aprile 1972, p. 31.
[33]Pierpaolo D’Attorre, “I comunisti in Emilia-Romagna nel secondo dopoguerra: un’ipotesi di lettura”, introduzione al volume: I comunisti in Emilia-Romagna. Documenti e materiali, a cura di Pierpaolo D’Attorre, Bologna, Istituto Gramsci sezione dell’Emilia-Romagna, GrafiCoop, 1981 [il passo citato è a p. 24].
[34] Fa strame di questa immagine la recente ricostruzione Storia della Democrazia Cristiana, 1943-1993, a cura di Paolo Pombeni, Guido Formigoni e Giorgio Vecchio, Bologna, Il Mulino, 2023, 720 p.
[35] Roberto Vivarelli, “Rivoluzione e reazione in Italia negli anni 1918-1922”, in Rivoluzione e reazione in Europa, 1917-1924, Atti del Convegno internazionale di Perugia, Milano, Edizioni Avanti!, 1978, vol.1; pp. 201-279.
[36] Serge Noiret, “Il partito di massa massimalista dal PSI al PCd’I, 1917-1924: la scalata alle istituzioni democratiche”, in Fabio Grassi Orsini e Gaetano Quagliariello (a cura di), Il Partito politico dalla grande guerra al fascismo. Crisi della rappresentanza e riforma dello Stato nell’età dei sistemi politici di massa (1918-1925), Bologna, Il Mulino, 1996, 1034 p. [pp. 909-965]. Si veda anche Steven Forti, “Parole in storia: Massimalismo”, Diacronie. Studi di Storia Contemporanea, 15 maggio 2015. Cf. https://www.studistorici.com/2015/05/15/parole-in-storia-massimalismo/.
[37] Inappuntabile è la ricostruzione che ne fa fatto Guido Crainz, Il conflitto e la memoria. Guerra civile e ‘triangolo della morte’”, Meridiana, (13) gennaio 1992 pp. 17-55. Cf. http://www.rivistameridiana.it/files/Crainz,-Il-conflitto-e-la-memoria.pdf. Si vedano i diversi studi di Massimo Storchi sul Reggiano e sul Modenese e il saggio a più mani Lorenzo Bertucelli, Antonio Canovi, Claudio Silingardi e Massimo Storchi, “L’invenzione dell’Emilia rossa. La memoria della guerra e la costruzione di un’identità regionale”, in Leonardo Paggi, a cura di, Le memorie della Repubblica, La Nuova Italia, Firenze 1999, XLII-430 p. [il saggio si trova alle pp. 269-323].
[38] Il recente saggio prima citato di Paolo Pombeni, Guido Formigoni e Giorgio Vecchio Storia della Democrazia Cristiana, 1943-1993, op. cit. alla nota 34, dipana la ricostruzione bandendo pregiudizi e anche falsità.
[39] Ad esso è dedicato il saggio del secondo curatore, Paolo Capuzzo, direttore della Fondazione Gramsci di Bologna), “La genesi internazionale della classe dirigente comunista in Emilia Romagna” in: Il comunismo in una regione sola?, op. cit. alla nota 2,pp. 93-163.
[40] Silvio Pons, “Gramsci e la Rivoluzione russa: una riconsiderazione (1917-1935)”, Studi Storici, LVIII (4), ottobre-dicembre 2017, pp. 883-928.
[41] Rimane un esempio prezioso di opposizione e di rigore culturale la ricerca politologica curata da Giorgio Galli ed edita da il Mulino in più volumi.
[42] Giuliano Procacci, “Appunti sugli statuti del Pci dopo la Liberazione”, Critica marxista, XVI (6), novembre-dicembre 1978, pp. 69-78.
[43] Si veda, dopo quella fatta da Angelo Tasca, la rilettura dei documenti ad opera di Antonella Salomoni, Il Protocollo Segreto. Il Patto Molotov-Ribbentrop e la falsificazione della storia, op. cit. alla nota 1.
[44] Antonio Gramsci, “Costituente e Soviety”, La città futura, 26 gennaio 1918, oggi in: Antonio Gramsci, La città futura, (1917-1918), a cura di Sergio Caprioglio, Torino, Einaudi, 1982, 1036 p. [l’articolo è alle pp. 602-603].
[45] Antonio Gramsci, “Utopia”, Avanti!, 25 luglio 1918. Ora in Antonio Gramsci, Il nostro Marx (1918-1919), a cura di Sergio Caprioglio, Torino, Einaudi, 1984, 734 p. [l’’articolo è a p. 210].
[46] Sull’azione parlamentare ed extraparlamentare scatenata dai comunisti dopo la loro esclusione dal governo De Gasperi cfr. la nota di Henry Tasca, corrispondente personale del ministro del Tesoro Henry Morghenthau Jr. presso l’ambasciata degli Stati Uniti a Roma, “Counter Measures Toward Policies and Practices of the Italian Communist Party”, in RG 84, Rome Embassy. tel. n. 2077b, dicembre 1947, box 17.
[47] Si veda la saggistica di diverso livello animata dalle inchieste di alcune Commissioni parlamentari d’inchiesta, a cominciare dalla raccolta di materiali ordinati da Gianni Donno, La Gladio rossa del Pci 1945-1967. Introduzione di Piero Craveri, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2001, 550 p.
[48] Si vedano i rapporti all’ambasciatore Dunn a Roma del console Usa di Milano in C.U. Bay, February 24 1947 (ma consegnato il 14 agosto 1947, 88 Italy – Milan, in RG 84 Rome Embassy del 14 agosto (“Political, Military, Administrative Synthesis of the PCI Organization”: e il rapporto segreto “Communist Propaganda Agents”, redatto dalle autorità di intelligence (Cic) di Milano.
[49] Li ho descritti ed esaminati dettagliatamente in “Il Dipartimento di Stato e l’esercito rosso” nel volume Salvatore Sechi, Compagno cittadino Il Pci tra via parlamentare e lotta armata, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2006, 509 p. [il capitolo si trova alle pp. 315-397].
[50] Per un’analisi in cui non viene data per scontata la sua inesistenza, si veda il saggio, sempre acuto di un intellettuale comunista di primo livello, Biagio De Giovanni, “La questione del partito: laicità e critica della doppiezza”, Critica marxista, XVI (5) settembre – ottobre 1978.
[51] Luciano Casali, “Sovversivi e costruttori. Sul movimento operaio in Emilia-Romagna”, in Roberto Finzi (a cura di), Storia d’Italia. Le regioni dal l’Unità ad oggi. L’Emilia-Romagna, Torino, Einaudi, 1997, 968 p. [si vedano le pp. 480, 485 e 544].
[52] Toni Rovatti, “Repressione, eversione e uso consapevole della forza. I comunisti e la violenza”, cit. alla nota 31, p. 213.













