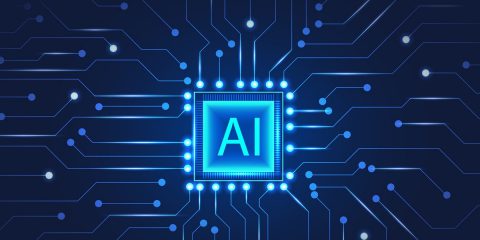La moda politica più e meno recente in materia digitale richiama il penoso ritardo italiano nella partecipazione al flusso globale della ricerca e dello sviluppo digitali e implica, soprattutto, l’ambiguità e la fallacia storica delle nozioni di sovranità digitale e di ‘trasferimento tecnologico’.
Vediamo di trattare i temi con ordine.
La nozione di sovranità digitale
La sovranità digitale, com’è noto, sembra persa da almeno vent’anni, quando qualcuno decise che l’Italia era solo un mercato per aziende rivenditrici di tecnologie digitali prodotte altrove, immemore della qualità tecnologica del recente passato.
Nella logica della globalizzazione, iniziavano a proliferare le branche nazionali dei giganti high tech della consulenza e della tecnologia digitale, che fiorivano in una relazione soporifera tra investitori partner locali delle aziende multinazionali e aziende multinazionali stesse.
Il connubio nel ‘globale’ portava a due conseguenze: l’apertura utile di un mercato occupazionale del lavoro digitale, per personale italiano assunto dalle branche locali delle aziende straniere multinazionali e le partnership italiane.
Il valore aggiunto della multinazionale locale risiedeva e risiede nella ricerca di clienti, la funzione preziosa del ‘commerciale’. La seconda conseguenza è consistita negli accessi più o meno lobbistici alle gare pubbliche da parte delle aziende ‘multinazionali’ locali, con un’occupazione pressoché totale da parte delle stesse dell’esito delle gare.
Le note questioni sulla possibilità di sopravvivenza di piccole e medie imprese in modalità di sub-appalto o la possibilità di accesso alle gare da parte delle stesse con accordi consortili e raggruppamenti vari sono note. Va pur detto che esistono alcune eccellenze di imprese medie nazionali.
Tratto distintivo delle realtà aziendali multinazionali locali, tuttavia, è stata l’assenza di attività di investimento economico per ricerca e sviluppo innovativo locale, logica non prevista dalle case madri e la configurazione fiscale di dette società quali società a responsabilità limitata (srl).
È pur vero che la comprensione del valore strategico di un’identità nazionale digitale, non totalmente caudataria dei poteri globali, è recentissima e allarmata, considerata la tensione attuale e prospettica dei rapporti industriali a livello geo-economico.
È tristemente accertata la debolezza del sistema nazionale a livello di aggiornate competenze digitali, con il ricorso fugace degli addetti a certificazioni di conoscenze, acquisite spesso frettolosamente nel mercato formativo. La preparazione degli addetti, per molti, risale al tempo della laurea. Ora, la velocità della trasformazione digitale e dei relativi prodotti e servizi richiede un ‘re-skilling’ e un up-skilling, riconversione e innalzamento delle competenze necessarie, permanente, sia nelle attività aziendali digitali sia nelle aziende clienti, succubi del fascino linguistico digitale esterofilo.
La refrattarietà del sistema a dotarsi di competenze digitali mature si è riverberata in parlamenti e governi digiuni di una visione evolutiva dell’economia digitale, addirittura allineati di piatto sulle ‘agende digitali europee’, nate per governare processi digitali transfrontalieri e non necessità nostrane. Politiche industriali adeguate del settore sono state e sono tuttora assenti se omettiamo, per amor patrio, le concessioni a pioggia di regalie monetarie modeste per start-up, che chiudono per lo più in pochi mesi come riportato a suo tempo dall’ISTAT, o per l’avvio scimmiottante di un’Industry 4.0, lanciata a suo tempo dalla Germania e adottata come ‘agenda’ improvvisata in Italia.
L’idea di un’Industry 4.0 non consisteva nel rinnovamento tecnologico del ‘parco macchine’, in particolare per le PMI: iniziativa pur utile, come previsto dalla nuova normativa Sabbatini. Andavano e vanno progettati e realizzati sviluppi applicativi complessi pluriennali i cui scopi variano dalla riconfigurazione gestionale digitale dell’azienda a una modifica qualitativa del ciclo di vita e sviluppo dei prodotti, a una produzione digitale totalmente innovativa: dove siano le competenze necessarie allo scopo e dove siano effettivamente visibili i risultati degli investimenti pubblici in materia è difficile dirsi.
Lo stesso dicasi per iniziative più o meno sterili di comitati istituzionali nati su stimolo europeo per promuovere ricerca, sviluppo e mercato delle nuove tecnologie (comitati spesso implementati da sindacalisti, commercialisti e avvocati, quali ‘esperti’ di intelligenza artificiale e blockchain, con tutto rispetto per le competenze professionali specifiche). Il risultato ‘apprezzabile’ è l’attuale marketing di prodotti e servizi digitai, connotati dal marchio di intelligenza artificiale (IA), affascinante nuovo mantra di qualunque prodotto, servizio, applicativo oggi proposto dal mercato, a prescindere dalla coerenza concettuale e terminologica della tecnologia evocata. Lo stesso vale per ‘progetti’ blockchain, iniziative spesso improvvisate, anche nel privato, e delle relative logiche promozionali. Parliamo sempre, ovviamente, dell’esigenza di disporre di nuove competenze di alto profilo.
Queste sporadiche iniziative istituzionali a vantaggio dell’innovazione digitale hanno moltiplicato il metalavoro consulenziale più o meno improvvisato, talora da parte di neolaureati volonterosi, braccio operativo assistenziale di manager non specificamente aggiornati, in aziende digitali di varia tipologia e livello e la creazione di centri di consulenza, hub, poli tecnologici europei e non (EDITH e marchi di eccellenza) e quant’altro, di dubbia utilità e di indubbio costo. Sempre metalavoro.
Né migliora le cose la pletora dei programmi europei di ricerca e sviluppo propri, in ordine ai quali, una volta o l’altra, sarebbe utile conoscere le esatte proporzioni dei risultati delle gare e dei capifila vincitori delle medesime.
In particolare, in momenti di magra economica, sarebbe utile sapere lo stato dell’arte dei progetti vincitori la cui sostenibilità nel tempo, richiesta per gara, andrebbe verificata e resa nota. Non che l’Italia sia stata e sia fuori da progetti internazionali: abbiamo degli eccellenti studiosi e ricercatori. Ma gli è che l’iniziativa di gara e i capifila sono stati e sono di norma stranieri. Un qualche autorevole lobbismo istituzionale comunitario sarebbe forse utile.
Per le gare pubbliche italiane, abbiamo già detto qualcosa. Ma una seria riflessione sull’impossibilità tecnica delle centrali di ‘vendita’, cui spetta la valutazione per l’assegnazione di gara, andrebbe svolta.
Un velo silente, infine, merita il lento degrado industriale nella gestione nazionale delle reti e le vicende di privatizzazione delle medesime, fatto salvo un rigurgito di attenzione recentemente innescato dal golden power.
Ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico digitale
Veniamo, tuttavia, agli operatori attuali della ‘mission impossible’ del recupero di quanto altri Stati europei hanno fatto nel tempo, ovvero un tentativo di sovranità digitale seppur marginale, negoziando il rapporto con i giganti del mercato e promuovendo logiche efficaci di sviluppo innovativo, peraltro richieste dall’Europa stessa.
Cominciamo con un’affermazione che può sembrare impropria: credere che l’innovazione tecnologica digitale sia appannaggio prevalente o esclusivo dei centri apparentemente preposti alla R&D, ovvero università, CNR, ENEA e simili. L’affermazione è da tempo smentita, segnatamente dall’estero.
Ammettendo che le belle menti di matrice accademica, che meriterebbero comunque uno spazio occupazionale economicamente dignitoso, possano sopravvivere in Italia, ci sarebbe da chiedersi con quali prospettive e per fare cosa. È il limite attuale dei dottorati di ricerca. Occorre chiedersi quanti dottori di ricerca poi facciano ricerca, anche in contesti accademici. E’ la prospettiva presente dei PNRR: quanti giovani ricercatori, finiti i soldi, saranno occupabili e da chi nel settore ricerca e sviluppo. Ma, soprattutto, una volta occupati nelle aziende del digitale, quanti saranno addetti allo sviluppo innovativo ovvero a ciò per cui si sono diligentemente preparati per anni?
Pur nel movimento registrato dal Politecnico di Milano in ordine alla tendenza all’incremento degli investimenti in digitalizzazione, resta il quesito sulla qualità ed efficacia degli stessi nel mercato. I quesiti potrebbero continuare. Ad esempio, chiedendosi quante e quali aziende non digitali investono in sviluppo digitale innovativo o quante aziende digitali operano per lo sviluppo digitale con budget precisi o cosa rilascino le corpose gare o gli investimenti nazionali pubblici in chiave di innovazione o, infine, quale sarebbe il potenziale ambito di mercato occupabile dalle piccole e medie imprese lodevoli.
Il cosiddetto trasferimento tecnologico, carenza da sempre lamentata in questo Paese, non consiste in un’ennesima mediazione nel mercato digitale per prodotti esteri già realizzati, promozione da parte di centri di competenza, hub, poli tecnologici ovvero normale attività di marketing, imbellettata dalla patina dell’auspicato sviluppo industriale nativo. Il fraintendimento è semantico: la nozione non dovrebbe riferirsi al solo trasferimento di tecnologie mature e di mercato internazionale alle imprese, sempre necessario, bensì nella trasformazione industriale di prodotti innovativi realizzati nell’R&D nativo, ovvero di prototipi locali da industrializzare.
Il vero trasferimento tecnologico, dunque, starebbe nell’opportunità offerta ai soggetti sviluppatori, università e centri di ricerca inclusi, e alle micro-piccole aziende digitali di trasformare prototipi digitali in prodotti industriali, su modello estero, capaci di stare nel mercato e competere nello stesso. Le diverse ‘strutture’ di supporto a un processo industriale digitale, ad oggi ancora invisibile, moltiplicano gli addetti del ‘metalavoro’ digitale che ormai affollano assieme ai retailer nostrani il mercato digitale. Aumentano, infine, le procedure burocratiche per accedere ai finanziamenti disponibili.
Servono molta progettualità inedita, reali competenze e nuova politica industriale del settore. E servono correttivi forti. Auguriamo al governo attuale di farcela.