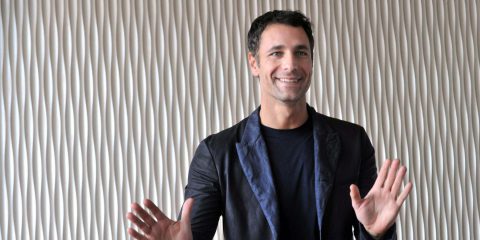La recente registrazione – tuttora in pendenza di esame – delle espressioni “Occhi Spaccanti” e “Buongiorno essere speciale…” da parte di Raoul Bova ha suscitato grande curiosità.
La vicenda nasce dalla diffusione virale di alcuni audio privati, divenuti in breve oggetto di cronaca estiva e di attenzione mediatica, amplificata dai social e approdata nei talk televisivi.
Ma dietro l’apparente leggerezza del “tormentone” si intravede una scelta legale quantomeno discutibile, soprattutto se intesa a contenere la diffusione mediatica della frase: un obiettivo che il diritto dei marchi, per sua natura, non è strutturato a garantire. Bova ha infatti incaricato i propri legali di depositare due domande di marchio denominativo presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM): una per l’intera frase e una per il solo sintagma Occhi Spaccanti.
Tutela economica
Una mossa che, a una prima lettura, potrebbe apparire come una reazione immediata all’esposizione mediatica, ma che – osservata con le dovute accortezze giuridiche – appartiene a un’altra dimensione: quella della tutela economica e della gestione dell’asset immateriale, non certo della limitazione del dibattito pubblico.
La tutela del marchio non ferma il gossip
Qualunque sia la finalità perseguita, è chiaro che la registrazione come marchio non possa incidere sulla circolazione mediatica di una frase. Il marchio è infatti concepito per garantire un diritto esclusivo sull’uso economico del segno, non certo per impedire che un’espressione diventi notizia, citazione o elemento di costume.
La rapida viralità del caso Bova ne è la prova: il marchio non è uno strumento di “silenzio mediatico”.
Discutibile anche la scelta di estendere la – agognata – protezione a ben dodici classi merceologiche: dall’abbigliamento alla ristorazione, fino all’intrattenimento e ai prodotti multimediali.
Si tratta di una strategia che mira a prevenire sfruttamenti commerciali non autorizzati – dal merchandising ai format digitali, dalle campagne pubblicitarie all’apertura di locali o piattaforme online – più che a contenere la narrazione giornalistica o la diffusione social.
Se l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi accoglierà le domande, l’art. 20 del Codice della Proprietà Industriale (c.p.i.) attribuirà a Bova il diritto esclusivo di vietare l’uso della formula a fini economici.
Uno strumento, dunque, idoneo a contrastare contraffazioni e utilizzi parassitari, ma che non può limitare il diritto di cronaca, di satira o di libera espressione.
Il marchio: funzione, requisiti e tenuta nel tempo
Per comprendere fino in fondo questa scelta difensiva occorre guardare alla funzione del marchio e ai suoi presupposti normativi. L’art. 7 c.p.i. consente di registrare come marchio qualsiasi segno – parole, nomi, disegni, suoni, forme o combinazioni cromatiche – purché idoneo a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa e rappresentabile con chiarezza nel registro.
Rientrano quindi anche frasi e slogan, a condizione che assolvano la funzione essenziale di indicatore d’origine.
Requisiti sostanziali
Su questo impianto si innestano i requisiti sostanziali:
- Novità (art. 12 c.p.i.): il segno non deve essere identico o confondibile con marchi anteriori. La protezione è normalmente circoscritta ai prodotti e servizi indicati, ma può estendersi anche a settori non affini quando il marchio acquisisca rinomanza, evitando che terzi ne traggano indebito vantaggio o ne pregiudichino la reputazione.
- Capacità distintiva (art. 13 c.p.i.): il marchio deve essere percepito dal pubblico come segno distintivo, non come mero slogan ornamentale. La giurisprudenza ammette che una frase possa acquisire carattere distintivo, ma solo se il pubblico la collega stabilmente a un’origine imprenditoriale.
In mancanza di un effettivo utilizzo coerente con le classi rivendicate, o se l’espressione dovesse divenire un modo di dire comune, la protezione potrebbe affievolirsi, fino alla decadenza. - Liceità (art. 14 c.p.i.): restano esclusi i segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume, e quelli ingannevoli quanto a natura, qualità o provenienza. Nel caso di frasi nate in ambito privato questo profilo non pone particolari ostacoli, ma non è irrilevante il bilanciamento con la libertà di espressione e il diritto di cronaca, che il marchio non può comprimere.
Inoltre, il marchio è un “titolo” che mantiene la propria efficacia solo se effettivamente utilizzato: l’art. 24 c.p.i. prevede infatti la decadenza quando, entro cinque anni dalla registrazione, non se ne faccia un uso reale e coerente rispetto ai prodotti o servizi rivendicati.
Nel caso di un’espressione nata da un episodio mediatico e divenuta rapidamente virale, questo requisito assume un peso determinante, poiché senza un progetto imprenditoriale concreto e continuativo – ad esempio attraverso iniziative di merchandising strutturate – la registrazione perderebbe progressivamente la propria efficacia fino a estinguersi.
Oltre il marchio: gli strumenti a tutela dell’immagine
Il marchio è dunque uno strumento patrimoniale: perfetto per contrastare lo sfruttamento economico non autorizzato, ma non certo idoneo a proteggere l’immagine o la reputazione personale.
La libera circolazione di una frase su media e social rientra, salvo abusi specifici, nel perimetro della libertà di informazione e di espressione.
Per la protezione della sfera privata e della reputazione, l’ordinamento offre altri strumenti più pertinenti:
- il diritto all’immagine e alla riservatezza (art. 10 c.c. e artt. 96–97 l.d.a.),
- la tutela dei dati personali,
- le azioni per diffamazione o per responsabilità civile in caso di divulgazione illecita.
Sono questi i terreni giuridici su cui si gioca la partita della protezione della persona rispetto alla diffusione di contenuti privati, ben diversi da quello della proprietà industriale.
In conclusione
Il caso Occhi Spaccanti dimostra come una frase nata in un contesto privato possa diventare, in poche ore, un fenomeno di interesse pubblico. La scelta di ricorrere alla registrazione come marchio – se finalizzata a contenere la diffusione mediatica della frase – si rivela però intrinsecamente impropria: il diritto dei marchi non è pensato per arginare il clamore giornalistico né per limitare la libertà di cronaca, di satira o di commento.
La registrazione, anche quando estesa a numerose classi merceologiche, opera su un piano strettamente commerciale: offre un’esclusiva sull’uso economico del segno, ma non può impedire che la frase continui a circolare nei media, sui social o entri nel linguaggio comune.
Per proteggere reputazione e sfera privata, l’ordinamento mette a disposizione ben altri strumenti – dal diritto all’immagine e alla riservatezza alle azioni per diffamazione o per illecita diffusione di dati personali – che incidono direttamente sulla pubblicazione e sulla permanenza online di contenuti lesivi.
Il marchio, dunque, non è il presidio giuridico per difendere la dignità personale.
Può avere una funzione nella gestione di eventuali sfruttamenti economici non autorizzati, ma non potrà mai trasformarsi in un argine al dibattito pubblico o all’eco mediatica di una vicenda privata.
Se l’obiettivo fosse stato realmente quello di tutelare l’immagine e contenere il gossip, la scelta di percorrere la via della proprietà industriale mostra tutti i suoi limiti.