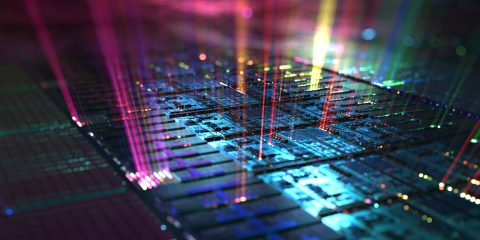#PAdigitale è una rubrica settimanale a cura di Paolo Colli Franzone promossa da Key4biz e NetSquare – Osservatorio Netics.
Per consultare gli articoli precedenti, clicca qui.
Italia

Il tema delle società ICT “in-house” possedute dalle amministrazioni regionali sta tornando di strettissima attualità, dopo qualche anno di relativo silenzio. In un mercato (quello dell’IT per la pubblica amministrazione) sempre più asfittico, riemergono nervi scoperti e qualche ferita mal rimarginata.
Stiamo parlando di una quindicina di società o consorzi i quali, tutti insieme, fatturano poco più di 700 milioni di Euro all’anno in un mercato (Regioni, compresa Sanità) che di milioni all’anno ne spende poco più di 1.500.
Dai dati che le in-house – attraverso la loro associazione di categoria – comunicano all’esterno, emerge un quadro fatto di società attentissime al mercato e alla generazione di ricadute positive verso “i fornitori privati”. Stando a questi dati, due terzi del giro di affari delle in-house torna sul mercato attraverso commesse esterne.
In senso strettamente letterale, il dato è vero: è sufficiente un rapido controllo dei bilanci per rendersene conto.
Il fatto è che alla voce “costi per commesse esterne” le in-house (correttamente, dal punto di vista contabile) conteggiano anche le consulenze esterne acquistate in modalità “body rental”: sistemisti, analisti, sviluppatori acquistati “un tanto a giornata” e destinati ad affiancare il personale interno (circa 5.000 unità) con rapporti di collaborazione di lungo periodo (contratti annuali, nella norma).
Affidandosi a stime, Netics sostiene che non più di 250 milioni l’anno vengono effettivamente “girati al mercato” attraverso acquisti di licenze e/o servizi e iniziative progettuali “chiavi in mano”.
Affrontare questo discorso facendo finta che le in-house regionali siano “tutte uguali” è un clamoroso errore: da qualche anno, anche grazie ad alcune sagge limitazioni imposte alle in-house dal “famigerato” art. 13 della “Legge Bersani” del 2006, molte di queste società hanno avviato percorsi virtuosi di trasformazione. Mandando in soffitta la (pessima) abitudine di “farsi tutto in casa”, sviluppando software applicativo “in concorrenza” con l’offerta privata e la ancora peggiore abitudine di considerarsi “player di mercato” operanti sul versante dell’offerta.
Complessivamente, il fenomeno “in-house” sta tornando ad assumere una dimensione “sana”: meno “make” e più “buy”, quasi ovunque al netto dalle solite (e preoccupanti) eccezioni.
Se un effetto la “Bersani” lo ha sortito, è quello di aver contribuito ad accelerare un dibattito in realtà già avviato da molte delle principali in-house a partire dall’inizio degli anni duemila: andare verso una efficace gestione del demand management e della governance complessiva delle piattaforme digitali, lasciando al mercato tutta la “ordinaria amministrazione”.
Tutto bene, dunque?
Fino a un certo punto.
Contrazione degli investimenti IT
Quello che nel frattempo è accaduto, ha a che fare con una significativa contrazione degli investimenti in IT da parte delle Regioni: in molti casi, parliamo di tagli considerevolissimi. In qualche caso, parliamo addirittura di azzeramento degli investimenti.
Con le “in-house” costrette a far di conto facendo quadrare budget sempre più risicati, in presenza di una rigidità strutturale non banale (dipendenti molto difficilmente “esodabili”) e di decenni di abitudine alle “vacche grasse”.
Assistiamo così a qualche timido tentativo di “ritorno al passato”, prendendo fogli bianchi a partire dai quali scrivere ex-novo software applicativo abbondantemente reperibile sul mercato. Unico modo, probabilmente, per far lavorare le risorse interne e quella quantità significativa di consulenti esterni contrattualizzati a lungo termine.
Unico modo, soprattutto, di tentare un recupero di valore capace di rendere attrattive le in-house pubbliche nei confronti di potenziali acquirenti privati: non è un mistero che almeno in quattro Regioni si è avviato un dibattito piuttosto acceso rispetto a scenari di più o meno imminenti privatizzazioni.
Il modello che sembra, fortunatamente, prendere il sopravvento è quello che possiamo definire “duale”: si mantengono di mano pubblica delle strutture “leggere” operanti come Agenzie e si mettono sul mercato le “fabbriche” del software e dei servizi (datacenter compresi).
In questo modo, le Regioni mantengono il controllo della governance e delle funzioni di “regia” e devolvono al privato tutte le operations.
Sempre che ci siano privati realmente intenzionati a comprare e – soprattutto – capaci di farlo sotto il profilo finanziario.
Anche in questo caso, dando per scontata (e lo è) la validità del modello privatistico, probabilmente ci si dovrà inventare qualcosa. Forse, ancora una volta, partendo dalla Cassa Depositi e Prestiti e dal Fondo Strategico Italiano.
Un “sistema ponte” innescato da FSI con la partecipazione del maggior numero possibile di operatori privati impegnati – sostanzialmente – a “ricomprarsi il tutto” nell’arco di una ventina d’anni.
Potrebbe non essere una stupidaggine.
Pensiamoci.