Il ruolo delle batterie negli ultimi anni è diventato sempre più centrale. La crescente elettrificazione dei consumi e l’introduzione nel mix energetico di fonti rinnovabili non programmabili, ha infatti reso questa tecnologia indispensabile per l’accumulo energetico di lunga durata. Dalle profondità dello spazio, alle applicazioni terrestri più avanzate, le batterie costituiscono ad oggi il non plus ultra per garantire stabilità alla rete.
Si parla spesso di diversi tipi di batterie, quasi sempre composte da celle elettrochimiche. Dalle tradizionali agli ioni di litio, alle nuove soluzioni organiche, biologiche o persino “a base d’acqua”. Un capitolo a parte, ancora poco esplorato, meritano poi le batterie nucleari. Questa particolare tecnologia, oggi sviluppata principalmente in Cina, non si basa su processi elettrochimici, e viene ancora guardata con grande diffidenza dal mercato europeo.
Fonti industriali interpellate da Key4Biz, appartenenti alla filiera delle rinnovabili, minimizzano il loro impatto, sottolineando che “si tratta di un’innovazione non comprovata, né matura ed economicamente efficiente per alimentare utilizzi commerciali o industriali”.
Eppure, il potenziale dirompente dell’idea merita attenzione.
Le batterie nucleari: energia (quasi eterna)
Entriamo nel merito. Le batterie nucleari, chiamate anche batterie atomiche, rappresentano di certo una delle tecnologie più affascinanti e longeve nel panorama energetico. Ma è corretto definirle batterie?
A.Rinaldi, ENEA “Non batterie ma generatori”
“I dispositivi i questione – chiarisce a Key4Biz l’Ing. Antonio Rinaldi, Head of TERIN-DEC-ACEL Laboratory (Electrochemical storage technologies and devices Lab) dell’ENEA – non sono batterie classiche ma piuttosto generatori. Si basano su un principio di emissione – eccitazione (betavoltaico) e non su un meccanismo elettrochimico. Purtroppo la nomenclatura è infelice e induce in errore”.
Più correttamente descrivibili, quindi, come Generatori Termoelettrici a Radioisotopi (RTG) o celle betavoltaiche, queste microcentrali in miniatura sfruttano il decadimento radioattivo controllato di isotopi stabili per produrre elettricità.
Il risultato? Una fonte di energia continua e (apparentemente) affidabile, capace di funzionare per decenni o persino secoli, senza ricariche né manutenzione.
Il termine batteria “allude”, perciò, soltanto alle caratteristiche tipiche:
- il pacchetto di energia immagazzinato nel dispositivo,
- la durata limitata (scarica) di tale dispositivo – è lunga ma comunque “finita” nel tempo ed è legata al decadimento dell’isotopo.
- i voltaggi confrontabili con le celle elettrochimiche convenzionali
- possibilità di sostituire batterie tradizionali
A che punto è oggi la ricerca internazionale sulle batterie nucleari?
Lo abbiamo chiesto a Davide Astiaso Garcia, Segretario Generale ANEV e Professore del Dipartimento di Ingegneria Astronautica, Elettrica ed Energetica, Università La Sapienza di Roma.
“Già negli anni Settanta, a Parigi, i chirurghi impiantarono il primo pacemaker alimentato a energia nucleare”, ricorda il Segretario Generale. Nei cinque anni successivi, almeno altre 1.400 persone ricevettero dispositivi simili, soprattutto in Francia e negli Stati Uniti.
“Racchiuse in involucri di titanio, le batterie di quei pacemaker contenevano un isotopo radioattivo — di solito circa un decimo di grammo di plutonio-238 — e potevano funzionare per decenni senza manutenzione. Un risultato che, all’epoca, apparve rivoluzionario: per molti pazienti significava dire addio agli interventi chirurgici ricorrenti per la sostituzione della batteria” prosegue.
Col passare del tempo, però, la situazione è cambiata.
“La tracciabilità di quei dispositivi divenne sempre più difficile, come si evince dagli archivi del Dipartimento dell’Energia statunitense. Negli Stati Uniti, infatti, i pacemaker nucleari avrebbero dovuto essere restituiti per il recupero del plutonio, ma spesso questo non accadeva. In molti casi, il materiale radioattivo finiva nei forni crematori o veniva sepolto insieme ai pazienti.
Di fronte a tali rischi, le autorità sanitarie di tutto il mondo decisero di interromperne l’uso. L’ultimo pacemaker nucleare conosciuto fu impiantato nel 1988. Da allora, fatta eccezione per applicazioni particolari — come sonde spaziali e fari remoti in Siberia — lo sviluppo delle batterie nucleari si è praticamente fermato. Negli ultimi anni, però, la ricerca ha ricominciato a muoversi”, ha osservato il Professore.
Più nel dettaglio, la ricerca è ripresa dopo il 2000, sebbene non abbia trovato sbocchi commerciali significativi. Ma nell’ultimo anno, numerose aziende e gruppi di ricerca in tutto il mondo hanno annunciato progressi che, a loro dire, rinvigoriranno la tecnologia e ne estenderanno l’utilizzo a robot, droni, sensori, oltre che a mezzi spaziali e impianti biomedici.
Dallo Spazio all’AI
A differenza dei reattori nucleari, che si basano sulla fissione a catena per produrre grandi quantità di calore, le batterie nucleari utilizzano l’energia costante e graduale rilasciata dalla disintegrazione di un isotopo radioattivo.
Da questo principio derivano due approcci distinti, quello delle RTG (Radioisotope Thermoelectric Generator) e delle Celle betavoltaiche.
Più recenti e decisamente più controverse, queste ultime sono protagoniste della nuova ondata di attenzione mediatica.
Un operatore del settore le descrive a Key4biz come:
“Una pila eterna da 3 volt, interessante per usi domestici o di nicchia, ma non applicabile su scala industriale”.
Mariano Tarantino, ENEA “I benefici vanno sempre valutati in base al settore di applicazione”
Per fare maggiore chiarezza sulla questione abbiamo chiesto a Mariano Tarantino, responsabile della Divisione Sitemi Nucleari dell’ENEA, l’Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile.
“Le batterie betavoltaiche suscitano perplessità perchè si tratta di materiale radioattivo composto da Nichel e Rame. Può essere molto pericoloso se inalato o ingerito, ed è anche questo il motivo per cui in Italia non ci sta lavorando nessuno. In Cina, invece, evidentemente c’è un’altra sensibilità: la radioattività non è percepita come un problema”, ha spiegato.
Dello stesso parere è il Professor Astiaso Garcia, che riferisce: “In Italia al momento non ci sono gruppi di ricerca che si stanno occupando di batterie nucleari, soprattutto perché i rifiuti radioattivi nel nostro Paese non sono molti e sono essenzialmente localizzati in una settantina di siti.”
Certo è, che anche le batterie tradizionali presentano i loro limiti in termini di ecocompatibilità e rischi per l’organismo umano.
“I benefici vanno sempre valutati in base al settore di applicazione,” prosegue a riguardo Tarantino. “Le batterie betavoltaiche sono estremamente compatte e, sebbene non offrano grandi potenze, potrebbero rivelarsi decisive nello Spazio, dove l’attuale tecnologia RTG impiega materiali molto più rari e difficili da reperire, come l’Americio e il Plutonio” aggiunge l’esperto.
Inoltre, come chiarisce anche D.A.Garcia, “nel settore Aerospaziale potrebbero fornire energia a sonde e satelliti che necessitano di fonti affidabili e a lungo termine.”
Celle betavoltaiche, i vantaggi dell’energia miniaturizzata
Ricapitolando, quindi, le celle betavoltaiche rappresentano la nuova generazione di batterie nucleari (più corettamente generatori nucleari), progettate per la miniaturizzazione e per applicazioni di precisione. La loro notorietà è esplosa dopo l’annuncio della batteria nucleare Betavolt. È, infatti, di pochi mesi fa la notizia della nuova “batteria nucleare” sviluppata dall’azienda cinese in collaborazione con la Northwest Normal University.
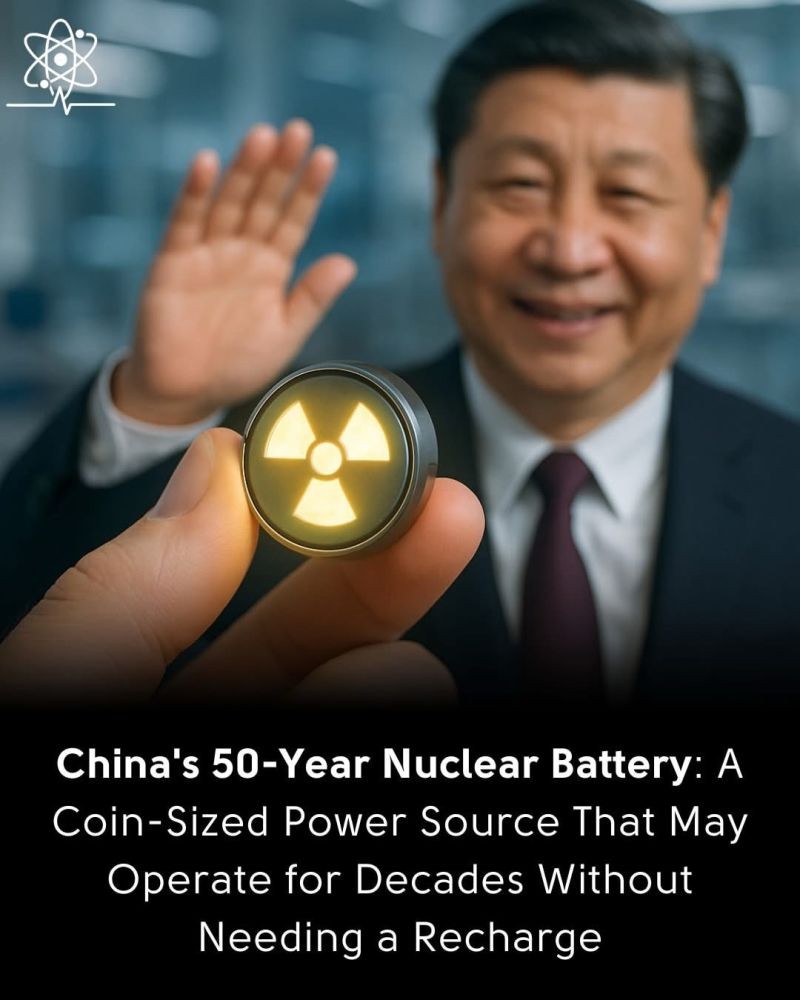
Si tratta di una tecnologia che resiste a temperature elevate e agli urti, senza rischi di combustione. Descritta come versatile, ideale per alimentare microelettronica, dispositivi medici impiantabili, sistemi aerospaziali, intelligenza artificiale autonoma, ed ecocompatibile (ma su questo aspetto restiamo scettici), la batteria Betavolt ha un ciclo di vita lunghissimo: da 50 a 100 anni senza mai essere ricaricata.
Betavolt ha già avviato la produzione di massa del modello BV100 da 100 microwatt, mentre una versione da 1 watt è prevista entro la fine del 2025.
L’obiettivo dichiarato è inaugurare una nuova era di autonomia energetica per la tecnologia civile e militare.
Tra le potenziali applicazioni rientrano, infatti, anche gli equipaggiamenti militari “potrebbero tornare utili per alimentare sensori, droni e altri dispositivi per i soldati sul campo per ridurre la necessità di trasportare batterie pesanti” specifica D.A.Garcia.
Come funzionano le batterie nucleari betavoltaiche
Riguardo al funzionamento dei “generatori nucleari betavolataici”, gli esperti concordano:
“I dispositivi di nuova generazione utilizzano isotopi radioattivi più sicuri e abbondanti, oltre a una tecnologia migliorata per generare energia a bassa intensità per decenni senza necessità di ricarica. Tuttavia, sebbene i prototipi recenti abbiano raggiunto una maggiore efficienza, siamo ancora lontani da quella necessaria alla maggior parte dei dispositivi elettronici di consumo.”
In breve, isotopi come Nickel-63 o Trizio emettono particelle beta (elettroni), che vengono catturate da un semiconduttore, solitamente silicio o, nelle versioni più avanzate, diamante artificiale.
Il semiconduttore assorbe l’energia degli elettroni e la converte direttamente in corrente elettrica, un po’ come fanno le celle solari, ma con una differenza fondamentale: l’energia proviene dall’interno e non dalla luce del sole.
Compatte, efficienti e potenzialmente eterne, le celle betavoltaiche sono però ideali esclusivamente per dispositivi a bassa potenza come sensori, impianti medici o apparecchiature pensate per ambienti estremi. Si pensi, ad esempio, ai sensori in luoghi remoti o inaccessibili, come le profondità marine o le regioni polari, dove la ricarica è impraticabile.
Batterie nucleari, ombre e limiti
È dunque possibile che una batteria piccola quanto una moneta possa davvero cambiare il sistema che attualmente conosciamo?
La risposta è no.
“Durata, densità energetica ed erogazione costante di potenza non bastano a compensare le criticità”, avverte il Segretario generale dell’ANEV. “La potenza resta molto bassa — insufficiente per dispositivi ad alta richiesta come gli smartphone — e i costi di produzione sono ancora esorbitanti, soprattutto se confrontati con altre tecnologie di accumulo.”
Sebbene innovative, queste batterie non rientrano poi nella categoria delle clean tech, di cui avevamo già parlato in un recente approfondimento, ossia le tecnologie a basso impatto ambientale utili alla transizione carbon-neutral.
Come osserva la professoressa Silvia Bodoardo, del Politecnico di Torino:
“Non porterei mai a bordo o da qualche parte un qualcosa che produce radiazioni.”
E, in effetti, come già detto, il tema delle radiazioni è quello più controverso.
Nonostante le batterie betavoltaiche siano schermate da involucri protettivi e l’isotopo radioattivo, una volta esaurito, si trasformi in un elemento stabile (come il Nichel-63 che diventa Rame-63), l’impatto ambientale delle scorie a lungo termine resta poco conosciuto.
“Il tracciamento e lo smaltimento a lungo termine dei materiali radioattivi rimangono ostacoli significativi – afferma Garcia – Inoltre, la percezione pubblica della tecnologia nucleare può rappresentare un ostacolo all’utilizzo e i quadri normativi per lo smaltimento sicuro sono ancora in fase di sviluppo” conclude.










