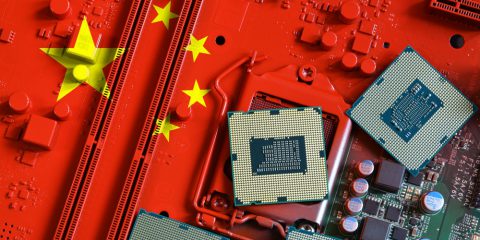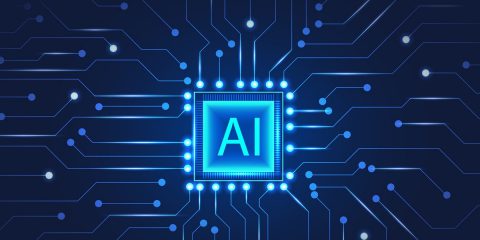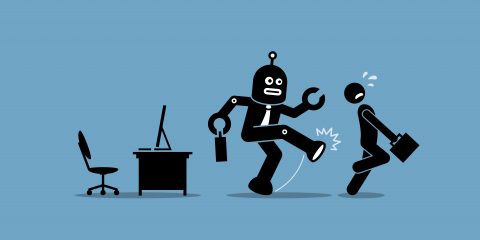L’Italia vuole entrare a far parte di una “cittadinanza digitale” globale, con vantaggi e svantaggi annessi. Abbiamo più volte ribadito che tale “cittadinanza digitale” debba essere non solo veloce, pronta al cambiamento, ma soprattutto accorta, sicura, rispettosa. Quindi, se vogliamo una “cittadinanza digitale” abbiamo bisogno di cittadini digitali, in carne ed ossa. E per rendere tali le persone non basta sbattergli in mano uno smartphone con connessione LTE e promettergli il diritto d’opinione – brutta faccenda della quale già ci siamo occupati in precedenza – ma occorre anche fare in modo che siano consapevoli.
La consapevolezza si genera con la cultura e con l’esempio, quello buono. Ma istituzioni e organizzazioni sono in grado di darlo?
Attualmente i cittadini digitali – al momento siamo tali in buona parte per la quantità di onde radio ed elettromagnetiche che rimpalliamo, non certo per consapevolezza, per fruizione di servizi telematici adeguati o per la capacità di compiere azioni sicure – risultano però più (con)fusi che mai. Perché di esempi virtuosi ce ne sono proprio pochi, mentre quelli più o meno velatamente disastrosi non mancano; sia nel pubblico che nel privato.
Lo stesso modello della grande rete non è più adeguato per supportare il cittadino digitale. Evgeny Morozov, sociologo e giornalista bielorusso, spiega su La Stampa che Google e Facebook hanno spostato il peso dell’economia digitale dal tempo ai target (attraverso la lavorazione dei dati personali).
Questi non vengono più estratti in forma grezza, bensì raffinati attraverso una psicanalisi forzosa di rilevamenti nascosti in ogni movimento del mouse, in ogni click, in ogni notizia letta, in ogni commento scritto. “Tutto ciò richiedeva – afferma Morozov – sia la progettazione di servizi che creassero una forte dipendenza, vale a dire che ci fanno scorrere e cliccare ossessivamente, sia lo spostamento dei confini dei regni digitali fino a fargli comprendere ogni aspetto della nostra vita quotidiana”.
Il cittadino digitale sventola con forza la bandiera della privacy, imbarcandosi però in improbabili crociate fin dove arriva la capacità di comprensione ed invece accetta in silenzio – è diplomatico oppure non capisce? – alcune condizioni paradossali. Basti considerare come sia passato in sordina, senza eclatanti ripercussioni, qualche strillo sensazionalistico a parte, il superbug identificato nei sistemi di una nota azienda italiana. Questo permetteva, attraverso l’inserimento del codice fiscale di un contribuente, la consultazione indiscriminata dei dati tributari a lui riferibili, anche da parte di soggetti terzi. Ma non c’è stata nessuna rivolta, se non per l’indisponibilità dello spesometro a ridosso della scadenza fiscale.
Mentre la proposta, ora alla camera, per la legge sull’estensione del registro delle opposizioni a cellulari e numerazioni fisse anche non presenti negli elenchi telefonici e l’introduzione di un prefisso unico per gli operatori di telemarketing sta riscuotendo rapidamente il consenso dei privati (sfiniti dalle pratiche di vendita telefonica selvaggia). Consapevoli del fatto che l’attuazione, così come denunciano associazioni di categoria e sindacati, potrebbe mettere a rischio 40mila posti di lavoro?
Non dimentichiamo poi che privacy non significa solo riservatezza dell’informazione, ma anche disponibilità – per coloro che sono autorizzati al trattamento, interessati in primis – dei servizi implicati. Eppure da un coinvolgente articolo – per altro ad elevata capacità comunicativa, pubblicato sul profilo LinkedIn del CEO di una nota azienda di cui vision e mission sono focalizzate sulla resilienza – si apprende che la PA avrebbe qualche difficoltà a definire con un minimo di correttezza formale (figuriamoci sostanziale) i requisiti minimi di continuità per l’affidamento di servizi informativi in outsourcing. Insomma, come dice l’autore stesso del pezzo, un vero e proprio “businesscontinuitycidio”.
Nel privato invece risulta eclatante il triste destino dei grandi investimenti compiuti nell’AI. Mentre in molti sono ancora eccitati per la rapida evoluzione dei bot e dei meccanismi di automazione ed auto apprendimento che vi sono dietro, l’applicazione alle attività di assistenza clienti, nell’ottica di virtualizzazione delle filiali, parla chiaro. Un flop che, dopo aver richiesto la messa in campo di tanti, tantissimi soldi e flotte di persone con profili elevati, sta costringendo i gruppi ad una rapida retromarcia.
C’è quindi da chiedersi come si dovrà formare e informare questo povero cittadino digitale, senza neanche l’aiuto di qualcuno che sappia veramente cosa fa. Forse ha ragione uno di quegli utenti che con 140 caratteri (scusate, tra poco 280) fa una satira sferzante e pubblica la foto di un post it con su scritto “spegnete internet”?