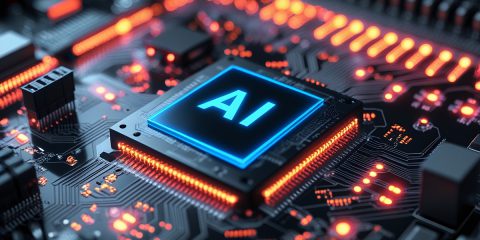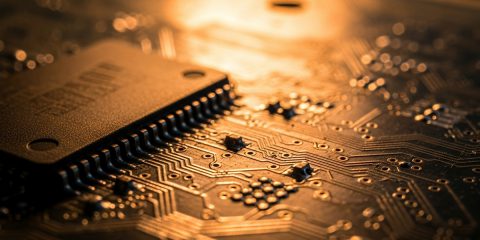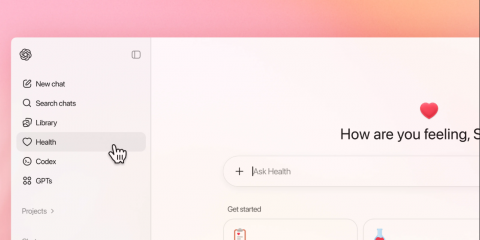Rubrica settimanale SosTech, frutto della collaborazione tra Key4biz e SosTariffe. Per consultare gli articoli precedenti, clicca qui..
Immaginare un insegnante nel 2035 significa pensare a un professionista che parla di letteratura o di fisica mentre un software analizza in tempo reale i progressi della classe.
È lo scenario che emerge dal nuovo studio La professione docente nella scuola di domani, elaborato da EY e Sanoma Italia: nei prossimi dieci anni oltre il 60% delle competenze richieste ai docenti sarà ridefinito dall’intelligenza artificiale, dalla digitalizzazione e dal mutamento delle pratiche didattiche. Solo un terzo delle abilità attuali resterà invariato.
La ricerca, basata su un modello predittivo di machine learning e su oltre 1.300 fonti internazionali, ha generato un dataset di 717 mila profili simulati di insegnanti italiani. Dall’analisi emerge una scuola che cambia non nei suoi valori ma nella sua struttura operativa.
Le tecnologie automatizzeranno le attività standardizzate (test, registri, burocrazia) mentre l’insegnante potrà concentrarsi sulla progettazione della didattica, sulla relazione con gli studenti e sulla lettura dei dati di apprendimento. L’intelligenza artificiale non sostituisce la figura del docente, ma ne estenderà il campo d’azione.
Il report individua tre assi di trasformazione. Il primo riguarda l’integrazione sistematica di strumenti digitali e agenti intelligenti; il secondo, il rafforzamento delle competenze socio-emotive (empatia, ascolto, adattabilità) sempre più cruciali per studenti abituati a vivere in ambienti digitali; il terzo, la diffusione di una didattica personalizzata e basata su dati. In un contesto dove il 47% dei lavoratori svolge mansioni che richiedono competenze diverse da quelle acquisite nel percorso di studi, la figura dell’insegnante dovrà tornare centrale come mediatrice tra conoscenza e tecnologia.
Dove cambia di più (e dove un po’ meno)
Chiaro, non tutte le scuole si muovono alla stessa velocità. Nella scuola dell’infanzia si prevede che circa il 39% delle competenze resti stabile: un dato che segnala una continuità di fondo, centrata sul sostegno emotivo e sociale dei bambini. Il profilo professionale del docente rimane fortemente relazionale e verticale, mentre le innovazioni riguardano soprattutto il modo di utilizzare gli strumenti digitali per creare contesti più inclusivi e partecipativi.
Nella scuola primaria, invece, la ridefinizione delle competenze supera il 40%. Qui il cambiamento è più strutturale: l’introduzione di strumenti interattivi, attività cross-modali e protocolli di inclusione digitale spinge verso una didattica sempre più personalizzata. L’insegnante deve diventare progettista di esperienze di apprendimento, capace di integrare tecnologie, linguaggi e approcci diversi in un ambiente che si fa sempre più dinamico.
Nella secondaria di primo grado, il quadro si complica ulteriormente: nell’area scientifica, il 44% delle competenze evolve verso una didattica tecnologizzata e adattiva, mentre il 36% si rafforza nella dimensione formativa e relazionale; un ulteriore 27% rappresenta competenze nuove, legate alla progettazione interdisciplinare e alla collaborazione con figure non strettamente scolastiche. Nell’area umanistica, la trasformazione tocca il 41% delle competenze e si orienta verso la facilitazione espressiva, l’uso di strumenti per l’analisi semantica dei testi e la scrittura assistita da sistemi digitali.
Per quanto riguarda la secondaria di secondo grado, nell’area scientifica il 42% delle competenze viene ridefinito attorno alla personalizzazione dell’apprendimento e al supporto individualizzato; nell’area umanistica l’evoluzione riguarda il 55% del profilo.
Una quota del 12% risulta esposta alla sostituzione da parte dell’intelligenza artificiale, soprattutto nelle attività di generazione e analisi dei contenuti. Le competenze più stabili, circa il 38%, ruotano invece attorno alla relazione, alla mindfulness e alla resilienza, dimensioni che restano centrali anche in un contesto sempre più digitale.
Il nuovo ruolo del docente di sostegno
Tra le figure professionali più esposte al cambiamento c’è quella dei docenti di sostegno, sempre più al centro di una scuola che punta sull’inclusione digitale. Lo studio prevede che entro il 2035 il 40% delle competenze richieste a questi insegnanti sarà ridefinito. Al loro lavoro viene attribuita una funzione strategica, e cioè quella di fare da interfaccia tra studenti, famiglie e tecnologie educative, compito che implica la capacità di progettare percorsi personalizzati, gestire ambienti digitali sicuri e promuovere la consapevolezza digitale tra gli alunni.
Le competenze emergenti sono di tipo ibrido: pedagogiche, tecnologiche e relazionali insieme. Nella nuova configurazione della scuola, il docente di sostegno collabora con chatbot educativi, strumenti di realtà aumentata e piattaforme di monitoraggio del progresso individuale. Perché tutto questo funzioni serve una connettività stabile e veloce, requisito essenziale per la didattica digitale. In questo senso, strumenti come il comparatore di offerte fibra ottica di SOSTariffe.it permettono di individuare soluzioni adatte alle scuole e alle famiglie, aiutando a ridurre il divario tecnologico che ancora pesa sull’inclusione.
Il report evidenzia anche un ampliamento del raggio d’azione di questa figura: dal lavoro diretto con lo studente al coordinamento con i colleghi curricolari e con le famiglie, fino alla co-progettazione di attività inclusive. Cresce quindi la necessità di competenze comunicative raffinate e di una buona alfabetizzazione digitale, soprattutto in termini di sicurezza, privacy e gestione dei dati sensibili.
In questa prospettiva, il docente di sostegno assume un ruolo decisivo nella transizione verso una scuola realmente personalizzata. Il valore aggiunto di questa evoluzione sta nella capacità di tradurre la complessità digitale in esperienze educative che restano umane, concrete e condivise.
La scuola che si prepara al futuro
Nel quadro delineato dallo studio, la tecnologia cambia il perimetro del mestiere ma non la sua essenza. L’intelligenza artificiale entra nei processi quotidiani della scuola, dalla valutazione ai percorsi personalizzati, mentre la centralità dell’insegnante si rafforza proprio nelle aree dove l’algoritmo non arriva: la relazione, la motivazione, la gestione delle differenze. Le competenze socio-emotive diventano il vero campo di evoluzione, perché l’efficacia della didattica passa sempre più dalla qualità dell’interazione. Ascolto empatico e adattabilità assumono lo stesso peso delle abilità digitali e della conoscenza disciplinare.
Per formare i docenti serviranno percorsi mirati alla lettura dei dati, alla progettazione collaborativa e alla gestione di contesti educativi sempre più complessi. L’insegnante si muove tra linguaggi, tecnologie e relazioni, punto di raccordo tra scuola, università e mondo del lavoro.
La scuola del 2035, come emerge dal report, sarà un sistema che combina strumenti digitali e presenza umana in un equilibrio da costruire giorno dopo giorno; le tecnologie analizzano e orientano, ma la responsabilità delle scelte deve rimanere nelle mani di chi insegna.