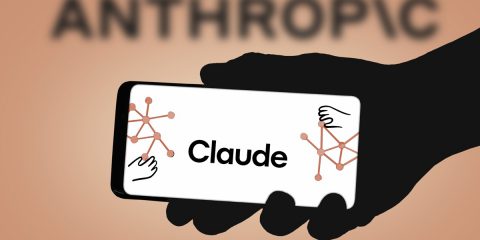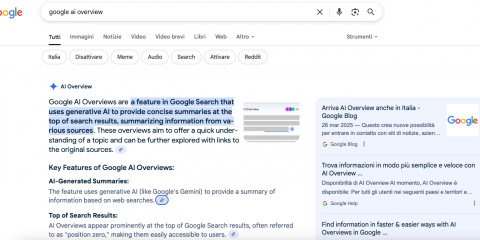Italia

Il 27 gennaio del 1984 andò in onda durante il Superbowl americano lo storico spot di Ridley Scott, commissionatogli da Steve Job per annunciare la nuova era del Mac.
Si chiudeva con la mitica affermazione: “…affinché il 1984 non sia un 1984“.
Il riferimento era alla fatidica data di Orwell e alla minaccia del totalitarismo che vi è rimasta inevitabilmente appiccicata.
Allora, in quel 1984, il grande fratello contro cui chiamava Steve Job alla mobilitazione era il gigante dell’elettronica mondiale IBM.
Oggi è la mela di Cupertino ad essere sul banco degli accusati.
Con la Apple gli altri Over the Top (OTT): Google, Amazon, Twitter, eBay, per citare i più noti.
E’ la rivolta dei nani contro i giganti.
Ma prima di ragionare sul potere degli OTT, chiediamoci per un momento se il 1984 è stato un 1984.
Insomma la grande ondata digitale, con l’emergere di grandi imperi dell’algoritmo, ha ristretto i margini di libertà, avvolgendo l’umanità in una rete di condizionamenti e controlli melliflui o no?
E’ evidente che discutere del nuovo mercato e denunciare lo strapotere dei grandi protagonisti dei social network non può prescindere da un giudizio di valore su cosa è realmente accaduto in questi 30 anni.
E’ questo un tema su cui noi italiani dovremmo applicarci particolarmente.
Sia perché, nonostante le giaculatorie di chi vuole nascondere i propri fallimenti dietro ad un destino nazionale, questo Paese è una grande potenza della cultura digitale.
Proprio dal 1984 inizia una straordinario cavalcata che vede l’Italia al centro dei grandi sommovimenti digitali: siamo i primi nel processo di ammodernamento del comparto televisivo in Europa; i primi nel sistema di telefonia mobile, i primi nell’uso e nelle applicazioni dei social network.
Siamo un paese che istintivamente esprime e produce una cultura relazionale che è la base della nuova economia digitale.
Ma questo primato non è un’eccentricità.
L’Italia, perché rimuoverlo, è stata la matrice di quell’economia.
Nei primi anni ’60 è l’Italia l’unico Paese al mondo che si trova al centro di tutti i grandi motori di innovazione:
- il petrolio, con L’ENI di Enrico Mattei;
- l’informatica con il primo personal computer dell’Olivetti di Adriano;
- la genetica con il primi gabinetto di ricerca a Napoli di Buzzati-Traverso;
- l’elettronucleare con le centrali di Felice Ippolito;
- l’areospaziale con i satelliti di Luigi Broglio,
- la chimica con il Nobel a Giulio Natta.
La rete stessa è una storia italiana.
E lo è perché italiana è la prima potenza di calcolo governata da un sapere umano, come la scuola di fisica teorica di via Panisperna con Enrico Fermi ed Edoardo Amaldi.
Volendo potremmo tornare ancora indietro alle prime riflessioni mnemoniche di Pico della Mirandola, alle configurazioni circolari dei saperi magici di Giordano Bruno, o alla governance del territorio di Niccolò Machiavelli.
Quel passato dovrebbe indicare a noi, prima ancora che ad altri, che il processo di innovazione digitale è qualcosa di più complesso e corposo di un buon piano marketing o di qualche furbizia fiscale di questo o quel brand multinazionale.
Trovo per questo forse insufficiente, per non dire deludente, una discussione quale quella che si è sviluppata nei giorni scorsi, a ridosso di importanti riunioni, come il Summit mondiale degli editori e la presentazione del rapporto del Garante della Privacy, o gli interventi dei dirigenti di Confindustria digitale.
Un singolare gioco mi è sembrato, dove tutto veniva limitato a qualche scippo di copyright o a qualche tracciabilità di troppo dei consumi.
Quello che sta accadendo mi pare purtroppo più serio e drammatico.
Cambia quella che Manuel Castells chiamava il segno distintivo della specie umana, ossia lo scambio di segni e contenuti. In questo tornante si stanno configurando nuovi poteri, che basano la loro centralità sull’abbondanza e non più la miseria: abbondanza di contenuti, di opportunità, di servizi.
Una trasformazione che vede almeno metà dell’umanità oggi condividere linguaggi e pratiche sociali che nulla hanno più a che fare con le ritualità localistiche del vecchio mercato editoriale.
A questo punto il tema è quali valori ma anche quali obbiettivi porsi per fare in modo che anche in futuro il 1984 non possa realizzarsi, così come non si è realizzato fino ad oggi.
Si pone così finalmente il tema del conflitto sociale nella rete, ossia di una contrapposizione di valori e di relazioni per modificare gli equilibri naturali che il determinismo mercantile impone. Ovviamente il conflitto non è in alcun modo sostenibile in nome di un ritorno all’antico o alle vecchie egemonie.
Anche perché se il 1984 non è stato l’anno di Orwell non possiamo dire così del 1974 o del 1964 o del 1954.
In parti consistenti del mondo, con modalità diverse, milioni di uomini nei decenni precedenti gli anni ’80 hanno vissuto stagioni di sopraffazione e di intimidazione condotte proprio mediante il controllo completo del sistema mediatico.
Dunque nessuna lezione di libertà da parte di chi in passato ha goduto, penso a certi editori anche nazionali, di privilegi e di monopoli.
Fa bene Raffaele Barberio a mettere al centro un altro tema che rischia di non trovare sostenitori: gli interessi nazionali.
Infatti compiuta questa prima fase di evangelizzazione digitale, i grandi OTT si vedono tentati a sovrapposi agli Stati nazionali.
L’ultimo esempio è lo sguardo annichilito del ministro dei beni culturali Dario Franceschini di fronte al presidente di Google Eric Schmidt che si permette una reprimenda all’Italia che non segue le ricette di Mountain View.
Oggi è necessario riappropriarci di autonomia intellettuale e di sovranità geopolitica, pianificando il nostro sviluppo tecnologico.
Si tratta di affrontare il tema di un negoziato dell’algoritmo, senza delegare ai grandi laboratori multinazionale la soluzione matematica di problemi comportamentali della nostra comunità.
E’ qui che mi attenderei una levata di scudi degli editori e dei giornalisti, che rispetto alla riorganizzazione delle loro aziende, sono invece disciplinatamente in fila davanti agli stand dei vari Avid, Google, Sony e Dalet per acquistare, chiavi in mano, intelligenze e culture professionali da adattare nelle nostre aziende e scuole.
E’ sull’algoritmo che si vince o si perde la guerra digitale.
Come è sulla difesa dei nostri beni comuni dell’immaginario artistico e paesaggistico nazionale e dei nostri corredi di memorie che invece vengono allegramente appaltati a Google.
E’ il momento in cui la politica deve definitivamente convincersi che la questione è troppo seria per lasciarla agli specialisti.
Già qualcuno sta capitalizzando i propri contatti con i grandi gruppi tecnologici per creare e speculare sul potere salvifico della rete.
Ovviamente, per tornare al tema iniziale, se quanto è in movimento afferisce ad una trasformazione antropologica del sistema comunicativo la battaglia degli interessi nazionale deve essere condotta mettendo in campo tutte le intelligenze e le risorse per essere più abili, esperti e fantasiosi di Google e non solo più avidi o furbi.