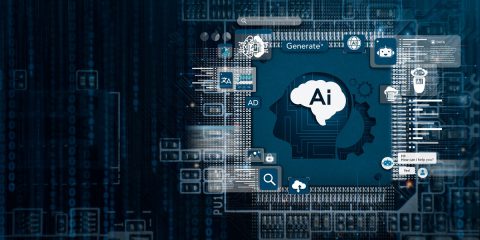“Diciamo subito con la necessaria chiarezza. Necessaria in questo momento dove non c’è più tempo da perdere. Il Green Deal europeo è stato un fallimento”. Così Chicco Testa, esperto di energia, in un articolo su Il Foglio, commenta il pacchetto di misure dell’Ue nato per rendere l’Europa climaticamente neutra entro il 2050. Ebbene, è vero che l’attuazione è stata e rimane più lenta e complicata del previsto: molti Stati membri hanno faticato ad allinearsi agli obiettivi di riduzione delle emissioni e le misure hanno suscitato resistenze sociali e politiche, con accuse di costi eccessivi per cittadini, cittadine e imprese. Eppure, è grazie al Green Deal se la vendita delle auto elettriche in Europa è passata da 360mila nel 2019 a 2,2, milioni nel 2024; eppure, è grazie al Green Deal se la quota di energie rinnovabili nella produzione di elettricità dal 35% del 2019 ha raggiunto il 54% del 2025; eppure, le “politiche ambientali che noi europei abbiamo adottato per primi a partire dagli anni Novanta hanno portato ad oggi nella Ue a una riduzione della CO2 del 37% e una crescita del Pil del 68%”, come ben sottolineato nel Data Room del Corriere della Sera.
Dal Fit for 55 alla Legge europea sul clima, dalla Nature Restoration Law per il ripristino degli ecosistemi degradati alla Tassonomia europea che indirizza i capitali privati verso attività sostenibili, solo per fare degli esempi, il Green Deal ha generato politiche e normative che stanno trasformando l’economia europea: promuovendo la finanza verde, rendendo più efficienti gli edifici, riducendo i consumi energetici e favorendo l’innovazione industriale e tecnologica. E allora, no, il Green Deal non è stato un fallimento. Ma l’Unione europea deve superare le contraddizioni tra impegni e decisioni concrete se non vuole perdere quel ruolo di “campionessa dello sviluppo sostenibile” che ha assunto negli ultimi anni con politiche forti e coraggiose.
L’Unione europea ha rallentato il ritmo del cambiamento. Il Data Room a cura di Milena Gabanelli ripercorre molto bene le ultime proposte avanzate, ancora non entrate in vigore. Oltre a quelle relative alla direttiva sulla rendicontazione della sostenibilità aziendale e alla direttiva sulla due diligence aziendale, ce ne sono altre come il rinvio di due anni per la riduzione delle emissioni per i veicoli immatricolati dal 2025, la sospensione della direttiva che obbliga le imprese che si dichiarano green a dimostrarlo, o la possibilità, nell’ambito della Legge sul clima che prevede che i Paesi membri riducano le emissioni nette di gas serra del 90% entro il 2040, di arrivarci ora anche con crediti di carbonio, piantando alberi o costruendo impianti fotovoltaici in Paesi extra Ue. “Il Green Deal dunque è stato diluito, vista la morsa in cui ci troviamo, ma l’impianto resta”, sottolinea Gabanelli. Ma va detto chiaramente che in termini operativi le modifiche finora apportate sono minime, al contrario di quanto sostiene una certa propaganda.
Nel Rapporto ASviS 2025 “Pace, giustizia e diritti: pilastri della sostenibilità” sottolineiamo come, guardando alle scelte concrete della Commissione, del Parlamento e del Consiglio, risultino evidenti le contraddizioni non solo con le preferenze espresse dai cittadini e dalle cittadine europee nel corso di diversi sondaggi, ma anche con il programma di mandato 2024-2029 e i principi fondanti l’impegno dell’Ue per lo sviluppo sostenibile. Esempi di tali contraddizioni sono: l’assenza di una valutazione (prevista dal Patto sul futuro) sulle modalità con cui l’aumento delle spese militari impatterà sul conseguimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile; l’arretramento di alcune politiche commerciali (in particolare negli accordi con gli Stati Uniti) improntate a criteri di sostenibilità, aprendo alla possibilità di rivedere alcuni aspetti della legislazione vigente sull’importazione di prodotti provenienti da deforestazione e sulla tassa sul carbonio alle frontiere (Cbam), di esaminare gli impatti delle Direttive europee su rendicontazione di sostenibilità (Csrd) e dovere di diligenza (Cs3d) sulle aziende americane, oltre che di aumentare le importazioni di gas naturale liquefatto dagli Usa; le eccessive semplificazioni sulla rendicontazione di sostenibilità e sul dovere di diligenza, motivate dall’urgenza e adottate in assenza di valutazioni d’impatto sistemiche e sul medio-lungo termine, che, come notato anche dalla Banca centrale europea, indeboliscono in modo significativo il quadro normativo europeo costruito nella precedente legislatura 2019-2024, rendendo l’Unione più esposta ai rischi fisici e di transizione che possono incidere sulla sua stabilità finanziaria; la mancata definizione dei suoi impegni nel percorso di decarbonizzazione entro il 2050 e di riduzione delle emissioni del 90% al 2040, previsti dall’Accordo di Parigi e dalla legislazione vigente.
Eppure, il Consiglio dell’Ue, cioè i governi degli Stati membri, in vista della Cop 30, ha chiesto espressamente “che gli Stati presentino contributi determinati a livello nazionale (Ndc) allineati alle traiettorie verso il valore di 1,5 ºC”, esortando i principali responsabili delle emissioni ad aggiornare urgentemente i loro Ndc affinché rispecchino livelli di ambizione più elevati, dal momento che i cambiamenti climatici rappresentano una “minaccia esistenziale per l’umanità, gli ecosistemi e la biodiversità, nonché per la pace e la sicurezza”. Inoltre, il Consiglio ha rimarcato l’importanza “che il settore dell’energia sia prevalentemente privo di combustibili fossili ben prima del 2050” e l’importanza di puntare a “realizzare un sistema energetico globale completamente o prevalentemente decarbonizzato negli anni 2030”. Al tempo stesso, il Parlamento ha rimproverato il Consiglio per non essere stato in grado di raggiungere un accordo per la definizione di un obbiettivo di taglio delle emissioni al 2035 e lo esorta a concordarlo quanto prima,
Il programma di mandato 2024-2029 di Ursula von der Leyen include azioni finalizzate ad accelerare il perseguimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile attraverso varie misure, dalla “Bussola per la competitività” al collegato “Patto per l’industria pulita”, dallo sviluppo delle competenze e delle capacità d’innovazione all’impegno nelle nuove tecnologie dell’AI. Analogo discorso vale per la visione di un’agricoltura rispettosa dei limiti planetari, per la strategia per la resilienza idrica e il previsto Piano europeo d’adattamento ai cambiamenti climatici, per i piani volti ad attuare quanto previsto dal Pilastro europeo dei diritti sociali, per le misure finalizzate al rafforzamento della partecipazione democratica, al coinvolgimento delle nuove generazioni nei processi decisionali politici, per l’introduzione di una strategia per l’equità intergenerazionale, per l’impegno all’allargamento dell’Unione a nuovi Stati.
Se allora l’Europa vuole rimanere “campionessa di sviluppo sostenibile”, cioè migliorare la vita dei propri cittadini e cittadine, la competitività delle imprese e ridurre l’inquinamento ambientale e il degrado degli ecosistemi, non può rinunciare a rimanere coerente con i suoi obiettivi, come peraltro chiaramente indicato nel Trattato che ne regola il funzionamento. Di fronte allo scontro in atto per “un nuovo ordine mondiale basato sul potere” (come affermato da Ursula von der Leyen), l’ASviS ritiene che l’Europa debba rispondere con più unità, per divenire più indipendente ma comunque aperta al mondo, ferma nella difesa dei propri valori, della propria libertà e della capacità di scrivere il proprio destino, come indica la Relazione di previsione strategica (strategic foresight) 2025 della stessa Commissione. In particolare, la Relazione segnala come priorità lo “sviluppo di una coerente visione globale per l’Ue”, basata sui suoi valori fondamentali e sostenuta da progetti in sintonia con le persone e i territori dell’Europa, sulla base dei loro interessi e valori. Interessante e positivo, in tale prospettiva, è il lavoro (cui concorre anche l’ASviS) che la Commissione sta realizzando per definire la prima strategia Ue per l’equità intergenerazionale, in linea con gli impegni che gli Stati membri hanno assunto con il Patto sul futuro e la connessa Dichiarazione sulle future generazioni.
E di fronte all’attacco sui costi troppo alti per la transizione verde, ricordiamo uno dei risultati emersi dal Rapporto ASviS “Scenari per l’Italia al 2035 e al 2050. Il falso dilemma tra competitività e sostenibilità”, che presenta quattro scenari relativi all’impatto della transizione energetica sull’economia italiana: con la transizione verde il Pil arriverebbe a +8,4% entro metà secolo, mentre con una transizione tardiva il Pil reale sarebbe inferiore a quello tendenziale del 2,4% nel 2035, e il tasso di disoccupazione salirebbe all’8%. E questo dimostra che la sostenibilità conviene, anche sul piano economico. La scelta per la decarbonizzazione e per l’economia circolare offre al nostro Paese un novero di opportunità, tra cui: maggiore autonomia e costi più bassi dell’energia; elevata competitività (indispensabile anche per reagire ai dazi e alle guerre commerciali), redditività e solidità finanziaria delle imprese; maggiore sviluppo ed equità sociale; miglioramento dello stato della finanza pubblica. Ad esempio, come spieghiamo nel Rapporto ASviS, l’intensità delle esportazioni cresce in modo continuo al crescere del grado di sostenibilità ambientale, fenomeno che si osserva anche nelle imprese con maggiore attività innovativa e grado di adozione di tecnologie digitali. Evidenze in linea con la maggiore produttività delle imprese esportatrici, che incidono anche maggiormente nei livelli più alti di indicatori quali quello di sostenibilità.
Ridurre l’ambizione climatica europea significherebbe compromettere anche la competitività dell’economia europea. Mentre Cina, India e Asia in generale, e l’Africa accelerano sugli investimenti nelle tecnologie pulite, sostenuti da politiche industriali aggressive, l’Europa rischia di rimanere indietro proprio nel momento in cui la transizione ecologica sta ridisegnando gli equilibri economici globali. Invece, l’Europa ha già dimostrato con il Green Deal di poter essere leader mondiale nelle politiche per la sostenibilità. Ora deve dimostrare di saper resistere alle pressioni del breve periodo e mantenere una visione di lungo termine. Abbassare l’ambizione climatica non è solo un rischio ambientale, ma anche un errore politico ed economico.